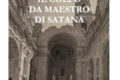fonte doncurzionitoglia.wordpress.com 18/08/2015
Autore don Curzio Nitoglia
Introduzione
Dopo i colpi inferti dalla falsa scolastica decadente di Scoto († 1308) e di Occam († 1349) al Tomismo con l’Umanesimo, il Rinascimento e il Luteranesimo si assiste ad un discredito generale gettato dalle classi colte sul Tomismo, il quale però lungi dallo spegnersi si ravviva grazie all’opera del Capreolo († 1444), che ripropone al secolo XV le verità immutabili della filosofia perenne che è stata esposta nella maniera più sublime da S. Tommaso d’Aquino. Inoltre due grandi geni teologici hanno approfondito e commentato la Summa theologiae s. Thomae Aquinatis (Tommaso de Vio detto il Gaetano, † 1534) e la Summa contra Gentes (Francesco de’ Silvestri detto il Ferrarese, † 1528).
Nell’epoca moderna, che inizia con Lutero († 1546) e Cartesio († 1650) ed è caratterizzata dal libero esame soggettivo religioso (“sola Scriptura”) e dal primato del pensiero (“Cogito”) sulla realtà (“ergo sum”), la scuola di Salamanca e il Tridentino rilanciano – nel Cinque/Seicento – la dottrina tomistica verso le più alte vette della somma speculazione dogmatica, morale, metafisica, politica, ecclesiologica, sacramentaria e mistica ad opera di grandissimi filosofi, teologi, esegeti e controversisti tomisti (de Vitoria, Soto, Cano, Bañez, Giovanni di San Tommaso, Suarez e Bellarmino e di grandi santi: S. Teresa d’Avila, S. Giovanni della Croce e S. Ignazio da Loyola, che son tre pietre miliari nella storia della teologia ascetica e mistica).
Dopo l’Illuminismo radicalmente razionalista della Rivoluzione francese, la Terza Scolastica col belga Charle René Billuart († 1757) ripropone il Tomismo approfondito, commentato e comparato col razionalismo allora imperante offrendo agli intelletti smarriti i princìpi evidenti e immutabili della ragione umana e della sana filosofia.
Infine di fronte all’attacco estremo contro il senso comune da parte dell’idealismo soggettivista e panteistico (da Kant † 1804 a Hegel † 1831) e del liberalismo politico, economico e teologico, che condurrà al Nichilismo nicciano (1900), freudiano e Sessantottino (1968-2000) la prima Neoscolastica a partire dal 1850 risponde con gli studi e la manualistica di grandi filosofi e teologi (Saneverino, Sordi, Cornoldi, Liberatore, Zigliara, Mattiussi, Billot e Franzelin) e la seconda Neoscolastica (Garrigou-Lagrange, Gilson, Maritain solo sino al 1936, Olgiati, Vanni-Rovighi, Fabro, Pizzorni e Gherardini) a partire dai primi anni del Novecento, grazie all’impulso datole da Leone XIII con l’Enciclica Aeterni Patris (1789) riscopre la originalità e lo superiorità della metafisica tomistica rispetto a quella aristotelica e risolve i problemi filosofici, teologici, morali e politico/economici dell’uomo contemporaneo.
A partire dalla fine del Trecento la Scolastica – che è stata affiancata alla Patristica da Melchior Cano († 1560) come “luogo teologico” – ha dovuto 1°) difendere (pars destruens) la philosophia perennis dagli attacchi del naturalismo e del razionalismo, iniziati già con Guglielmo di Occam († 1349) e avanzati con l’Umanesimo e il Rinascimento del Quattrocento/Cinquecento; e 2°) contrattaccare (pars construens) dando un nuovo impulso alla dottrina tomistica.
“Dialogare con la cultura della modernità, che intende quantomeno escludere Dio dal proprio orizzonte, diventa cosa estremamente ardua se non impossibile”. Osservazione, questa, di puro buon senso, che è mancato agli uomini di Chiesa, i quali dal 1959 sino ad oggi hanno iniziato l’aggiornamento e il dialogo con la modernità, la quale nega 1°) l’oggettività e la realtà della conoscenza umana; 2°) i primi princìpi per sé noti e specialmente quello di identità e non contraddizione. Ora, come insegnano Aristotele e S. Tommaso, “cum negante principia nequit disputari / non si può discutere con chi nega i primi princìpi per sé noti”. Già Aristotele circa trecento anni prima di Cristo concludeva: “È ridicolo andare in cerca di ragioni contro chi, rifiutando il valore della ragione, non vuol ragionare” (Aristotele, Metafisica, IV, 4).
Quindi la Seconda Scolastica, al contrario del neomodernismo, ha dibattuto, disputato con la modernità e l’ha smentita, inficiata, annullata logicamente e confutata razionalmente, approfondendo nel medesimo tempo la dottrina perenne e sempre attuale del Tomismo, ma non per questo mummificata ed incapace di essere approfondita e letta in ogni epoca alla luce degli errori sempre nuovi refutabili e contraddicibili alla scuola della Sintesi tomistica.
La Seconda Scolastica ha prodotto una gran fioritura di nuovi filosofi e teologi tomisti. In questo capitolo tratto solo dei tre grandi Commentatori delle Summae tommasiane, che hanno refutato il soggettivismo filosofico nominalista pre/cartesiano e per gli altri grandi scolastici del Cinque/Seicento rinvio ai capitoli in cui ho trattato della polemica scolastica contro il soggettivismo politico o machiavellismo/rousseauismo e il soggettivismo religioso luterano.
LA SECONDA SCOLASTICA
I – Gli albori (XV-XVI secolo)
Il Quattrocento e il Cinquecento sono i secoli dei Commenti alle due Somme (Teologica e Contro i Gentili) di S. Tommaso ad opera di tre grandi Domenicani: Jean Capreolus († 1444), Tommaso de Vio detto il Gaetano († 1533) e Francesco de’ Silvestri detto il Ferrarese († 1528). Questa è l’epoca delle Defensiones di S. Tommaso contro gli attacchi degli scotisti e dei nominalisti occamisti (Capreolus), poi vengono i veri e propri Commnenti, che spiegano il testo delle due Somme tommasiane articolo per articolo (Cajetanus e Ferrariensis).
Johannes Capreolus
Jean Capreolus, nato presso Rodez nella Francia meridionale nel 1380 e morto ivi il 7 aprile 1444, è detto il princeps thomistarum. Egli ha il merito di aver fatto tornare in vigore il Tomismo alla Sorbona di Parigi che, durante il Trecento, si era affievolito ed eclissato sotto i colpi dello scotismo e dell’occamismo. Capreolo nel 1407 iniziò il suo insegnamento nel convento domenicano di Saint-Jacques di Parigi, che fu un centro di rinascita del Tomismo, e, contemporaneamente alla Sorbona, poi all’Università di Tolosa (città in cui riposa S. Tommaso e ove S. Domenico fondò l’Ordo Praedicatorum) ed infine nell’università di Salamanca in Spagna fondata nel 1381, che divenne pian piano una delle più prestigiose università della Cristianità surclassando la Sorbona. Da essa usciranno i grandi teologi della Seconda Scolastica e della Controriforma, assai valenti nella filosofia morale individuale e politica e nel diritto naturale più che nell’approfondire la metafisica tomistica. Tra di loro brillano Francisco de Vitoria, Francisco Suarez, Domingo de Soto, Melchior Cano, S. Roberto Bellarmino (uscito dal Collegio Romano dei Gesuiti) e Luis de Molina. Capreolo, Gaetano e Ferrarese, invece, studiano la filosofia aristotelico/tomistica e soprattutto commentano e approfondiscono la teologia delle due Summae tommasiane, tuttavia senza approfondire troppo l’originalità filosofica del Tomismo rispetto all’Aristotelismo.
Capreolo compose la sua opera principale in circa lunghi 20 anni di duro lavoro, tra il 1409 e il 1432, con le famose Defensiones theologiae Divi Thomae Aquinatis (edita postuma a Venezia dal 1480 al 1484). Mons. Martin Grabmann († 1949) definisce le Defensiones del Capreolo “l’opera storicamente più importante che la scuola tomistica abbia prodotto a difesa della dottrina dell’Aquinate” (Storia della teologia cattolica, tr. it., Milano, 1937, p. 137). In questo grande lavoro Capreolo si eclissa volutamente dietro la figura e la dottrina di S. Tommaso, preoccupato soltanto di interpretarne obiettivamente e di spiegarne correttamente il significato per difenderlo contro gli attacchi degli insegnanti antitomisti: Guglielmo Durando da S. Porziano († 1334); degli scotisti: Pietro Aureolo († 1322) e dei nominalisti: Guglielmo Occam († 1349) e l’occamismo.
Capreolo raccoglie sia i vari passi delle opere di S. Tommaso sia le critiche mosse loro dagli scotisti, li compara e poi confuta gli scotisti utilizzando le citazioni dell’Aquinate stesso. La trattazione è tipicamente scolastico/tomistica, lo stile è conciso, il rigore dialettico è irresistibile.
Celebre è la sua interpretazione della dottrina della Personalità o Sussistenza di S. Tommaso (S. Th., I, q. 29, a. 1-2) che è diversa da quella datane dal Gaetano ed è per questa fedeltà all’Angelico, la quale spesso manca al Gaetano, che Capreolo fu chiamato il “principe dei tomisti”.
Francesco de’ Silvestri
Nato a Ferrara nel 1474, e detto perciò il Ferrarese o Ferrariensis, è morto a Rennes nel 1528. Fu Maestro generale dell’Ordine Domenicano. La sua opera maggiore è In libros S. Thomae Aquinatis contra Gentes commentaria scritto dal 1503 al 1517 e pubblicato a Venezia nel 1524; è stato incluso per volere di Leone XIII nell’Edizione Leonina delle Opera di S. Tommaso a fianco della Summa contra Gentiles.
Il Ferrarese ha scritto anche di logica e psicologia filosofica: Adnotationes in libros posteriorum Aristotelis (Venezia, 1533) e In tres libros de Anima (Venezia, 1535).
Egli è un commentatore fedele al maestro, forse meno acuto del Gaetano, ma più fedele a S. Tommaso. Infatti il Gaetano si distacca dall’Aquinate in più di qualche questione. Lo si constata 1°) riguardo alla teoria dell’Analogia interpretata da Gaetano come di proporzionalità propria sia dal Ferrarense (Comm. in Contra Gentes, ed. Leonina, voll. XIII-XV) che da Giovanni da San Tommaso (Cursus Philosophicus, Logica, II, q. 14, a. 4, II ed. Torino, Marietti, 1948, pp. 504-513), mi sembra più correttamente, come di Attribuzione intrinseca secundum prius et posterius, che esige l’ordo ad unum ossia l’analogato principale. Infatti per S. Tommaso l’elemento essenziale dell’analogia è l’ordo ad unum (S. Th., I, q. 13, a. 6: “necesse est quod omnia dicantur ad unum”); 2°) riguardo alla immortalità dell’anima, che secondo il Gaetano non si può dimostrare con la ragione mentre per l’Aquinate e il Silvestri sì e 3°) quanto alla dimostrazione razionale dell’esistenza di Dio minimizzata quanto al grado di certezza dal Gaetano, che la ritiene solo probabile ed invece affermata dal Silvestri con l’Angelico come metafisicamente certa.
Il Ferrarese, come il Capreolo, si confronta con Duns Scoto e lo confuta dimostrando l’inconsistenza delle sue posizioni metafisiche (la negazione della distinzione reale tra atto e potenza, tra essenza ed essere, tra materia e forma; la negazione dell’unicità della Forma sostanziale in un composto; la negazione della distinzione reale tra sostanza e accidente e conseguentemente tra l’anima e le sue facoltà…).
Il suo commento sulla questione del “desiderio naturale” di vedere Dio faccia a faccia (In S. c. Gent., lib. V, cap. 51) è capitale ed è tornato di grande attualità col modernismo di Le Roy, Loisy, Tyrrell, Buonaiuti e Fogazzaro (condannato da S. Pio X, Enciclica Pascendi, 8 settembre 1907) , il quale pretendeva che l’ordine soprannaturale, la grazia santificante e la gloria del cielo fossero dovuti alla natura umana e soprattutto col neomodernismo di Henry de Lubac (Le surnaturel, Paris, Aubier, 1946) condannato da Pio XII (Enciclica Humani genersis, 12 agosto 1950) poiché riprendendo l’errore del modernismo classico lo aggravava equiparando natura e soprannatura.
Tommaso de Vio
Dopo i colpi inferti dalla falsa scolastica decadente di Scoto († 1308) e di Occam († 1349) al Tomismo con l’Umanesimo, il Rinascimento e il Luteranesimo si assiste ad un discredito generale gettato dalle classi colte sul Tomismo, il quale però lungi dallo spegnersi si ravviva grazie all’opera del Capreolo († 1444), che ripropone al secolo XV le verità immutabili della filosofia perenne che è stata esposta nella maniera più sublime da S. Tommaso d’Aquino. Inoltre due grandi geni teologici hanno approfondito e commentato la Summa theologiae s. Thomae Aquinatis (Tommaso de Vio detto il Gaetano, † 1534) e la Summa contra Gentes (Francesco de’ Silvestri detto il Ferrarese, † 1528).
Nell’epoca moderna, che inizia con Lutero († 1546) e Cartesio († 1650) ed è caratterizzata dal libero esame soggettivo religioso (“sola Scriptura”) e dal primato del pensiero (“Cogito”) sulla realtà (“ergo sum”), la scuola di Salamanca e il Tridentino rilanciano – nel Cinque/Seicento – la dottrina tomistica del realismo della conoscenza secondo cui il pensiero deve adeguarsi alla realtà extramentale (“adaequatio rei et intellectus”) e non viceversa (“agere sequitur esse et non esse sequitur agere: id est, sum ergo cogito”) verso le più alte vette della somma speculazione dogmatica, morale, metafisica, politica, ecclesiologica, sacramentaria e mistica ad opera di grandissimi filosofi, teologi, esegeti e controversisti tomisti (de Vitoria, Soto, Cano, Bañez, Giovanni di San Tommaso, Suarez e Bellarmino e di grandi santi: S. Teresa d’Avila, S. Giovanni della Croce e S. Ignazio da Loyola, che son tre pietre miliari nella storia della teologia ascetica e mistica).
Dopo l’Illuminismo radicalmente razionalista della Rivoluzione francese, la Terza Scolastica col belga Charles René Billuart († 1757) ripropone il Tomismo approfondito, commentato e comparato col razionalismo allora imperante offrendo agli intelletti smarriti i princìpi evidenti e immutabili della ragione umana e della sana filosofia.
Infine di fronte all’attacco estremo contro il senso comune da parte dell’idealismo soggettivista e panteistico (da Kant † 1804 a Hegel † 1831) e del liberalismo politico, economico e teologico, che condurrà al Nichilismo nicciano (1900), freudiano e Sessantottino (1968-2000) la prima Neoscolastica a partire dal 1850 risponde con gli studi e la manualistica di grandi filosofi e teologi (Saneverino, Sordi, Cornoldi, Liberatore, Zigliara, Mattiussi, Billot e Franzelin) e la seconda Neoscolastica (Garrigou-Lagrange, Gilson, Maritain solo sino al 1936, Olgiati, Vanni-Rovighi, Fabro, Parente, Piolanti, Pizzorni e Gherardini) a partire dai primi anni del Novecento, grazie all’impulso datole da Leone XIII con l’Enciclica Aeterni Patris (1789) riscopre la originalità e lo superiorità della metafisica tomistica rispetto a quella aristotelica e risolve i problemi filosofici, teologici, morali e politico/economici dell’uomo contemporaneo.
Tommaso de Vio essendo nato a Gaeta nel 1468 viene detto Gaetano o in latino Cajetanus (come il de’ Silvestri fu chiamato Ferrarese poiché era nato a Ferrara). Domenicano sin da giovane studiò a Napoli, Bologna e Padova, ove divenne professore di metafisica all’Università nel 1494 e dovette confrontarsi col francescano p. Trombetta professore nella medesima università di filosofia scotista e grande avversario del Tomismo. A soli 40 anni fu nominato Maestro generale dei Domenicani. Insegnò anche all’Università La Sapienza di Roma (fondata da papa Bonifacio VIII nel 1300) dal 1501 al 1508. Sempre nell’Urbe durante il famigerato “sacco di Roma” (1527) da parte dei Lanzichenecchi fu fatto prigioniero e subì le più atroci torture e umiliazioni. Morì a Roma nel 1534 e il suo corpo riposa all’entrata della basilica di S. Maria sopra Minerva a Roma a fianco del Ferrarese.
Uomo di grande talento, scrisse 157 opere di filosofia (Commentaria super tractatum de ente et essentia divi Thomae de Aquino; De nominum Analogia, Commentaria in tres libros Aristotelis de Anima), di teologia (In Summam Theologiae S. Thomae Aquinatis) ed esegesi (In librum Job; In Psalmos; In Evangelia Matthei, Marci, Lucae, Johannis; In Acta Apostolorum, In Epistulas Pauli). La sua fama è legata all’imponente commento durato circa 20 anni (esattamente dal 1507 al 1522) alla Somma Teologica, come quello del Ferrarese al commento della Somma contro i Gentili dell’Angelico.
Scrisse anche dei libri di dottrina sociale, politica ed economia (De monte pietatis, 1498; De cambiis, 1499; De usura, 1500) assai attuali riguardo alla liceità o meno del prestito a interesse, dell’usura e del cambio tra merce e moneta e quindi della natura del denaro o della moneta. Gli scolastici consideravano, a partire dalla dottrina economica di Aristotele, il denaro solamente un semplice mezzo di scambio, in sé improduttivo, quindi ogni interesse o guadagno proveniente dal mero prestito di denaro era considerato usura. Il cardinal Tommaso de Vio, purtroppo, nel suo Tractatus de Montibus Pietatis (1498) e si schierò contro i Monti.
Dovette intervenire il Magistero ecclesiastico e papa Leone X (1513-1521) nel V Concilio Lateranense (sessione X, maggio 1515, DB 739) discusse la liceità del prestito ad interesse. Il Concilio e il Papa decretarono che siccome il guadagno veniva ai Monti di Pietà non dal prestito del denaro, ma dal dovuto pagamento del giusto salario degli impiegati e delle spese per la conservazione materiale del Monte, tale guadagno era del tutto lecito e non usuraio. Fu così che i Monti di Pietà si diffusero in tutta Europa, però pian piano iniziarono a degenerare e a diventare vere e proprie banche che prestavano denaro e guadagnavano dal prestito stesso in maniera sproporzionata, ossia ben oltre il 4%.
“Profondamente attaccato alla Sede Apostolica, il Gaetano ne difese con profondità e brio le prerogative e il primato nel celebre trattato De auctoritate Papae con relativa Apologia, che stroncò le velleità conciliaristiche di Pisa (1511) e preparò in anticipo la condanna dell’errore gallicano” (U. Degli Innocenti, cit., col. 1508).
Fondamentali per l’ecclesiologia e indirettamente per la filosofia politica i suoi De auctoritate Papae et Concilii (Roma, 1511) e Apologia de comparata Papae et Concilii auctoritate (Roma, 1512), attualissimi per quanto riguarda la Collegialità episcopale o l’Episcopato monarchico e papale dibattuta recentemente nel Concilio Vaticano II. La Collegialità episcopale è stata costantemente condannata dal Magistero ecclesiastico sino a Pio XII, il quale ancora tre mesi prima di morire nell’enciclica Ad Apostolorum principis (29 giugno 1958), ribadì per la terza volta, dopo la Mystici Corporis del 1943 e la Ad Sinarum gentem del 1954, che la giurisdizione viene ai vescovi tramite il Papa. Il gallicanesimo o conciliarismo, invece, tende ad assegnare al Concilio ecumenico una funzione suprema eguale se non superiore a quella del Papa.
L’influsso del Gaetano sui tomisti della Seconda, Terza Scolastica e del primo Neotomismo (N. Dal Prado, M. Penido, E. Hugon, A. Gardeil, R. Garrigou-Lagrange, J. Gredt, V. Cathrein, F. Maquart, J. Maritain, Ch. Journet, J.-M. Ramirez, S. Vanni-Rovighi) è stato enorme. Egli è stato un “autentico scolastico e un tomista convinto, che penetrò a fondo anche le latenti virtualità del pensiero dell’Aquinate. Ma preoccupato di difenderlo dagli attacchi del teologo scotista Antonio Trombetta e degli averroisti padovani (Pomponazzi), indulse ad una polemica, che doveva conferire alla sua poderosa opera qualcosa di contingente e di caduco” (U. Degli Innocenti, Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1949, vol. IV, col. 1507, voce De Vio Tommaso). Infatti, nonostante l’ottima conoscenza della Somma Teologica tommasiana, il Gaetano “dotato di straordinaria vigoria di mente non poteva non imprimere al suo gran Commento della Somma Teologica dell’Aquinate i segni della sua forte personalità. Così gli accadde di scostarsi in alcuni punti da San Tommaso, sia in filosofia sia in teologia” (U. Degli Innocenti, cit., col. 1508). Infatti il Gaetano sostiene delle teorie che, pur se acute e molto complesse nelle loro conclusioni, si distaccano notevolmente dal Maestroe sono state messe in luce soprattutto dai grandi studiosi del secondo Neotomismo (soprattutto, ma non solo Gilson e Fabro). Per esempio de Vio sostiene che la ragione non può dimostrare con certezza la immortalità dell’anima, come pure con certezza metafisica l’esistenza di Dio (In Imam Summae S. Thomae), giudicando insufficienti le cinque vie tomistiche della Summa Theologiae, le quali condurrebbero solo ad un Ente necessario, ma non ad un Dio creatore, infinito e perfettissimo. Inoltre espone la filosofia tomistica come un puro commento di quella aristotelica (difetto umanamente possibile anche nei geni, che dal Maestro/Gaetano è passato ad un altro grandissimo tomista: l’Allievo per eccellenza/Reginaldo Garrigou-Lagrange) e non tratta della originalità tommasiana del concetto di essere come atto ultimo di ogni essenza, perfezione e forma. Infine, secondo il de Vio, la vera filosofia aristotelica sarebbe quella letta alla luce dell’averroismo e non del tomismo.
Per quanto riguarda l’analogia (De nominum analogia) Gaetano si distacca da S. Tommaso e dà il primato all’analogia di proporzionalità propria invece che a quella di attribuzione intrinseca in cui gli analogati secondari sono ordinati ad un analogato principale. Infatti S. Tommaso parla molto sovente dell’analogia secondo il prius et posterius in cui vi è un ordine essenziale ad un analogato principale, che quindi è più facilmente e correttamente utilizzabile in teodicea e in teologia riguardo al problema della conoscibilità da parte dell’uomo dell’esistenza di Dio e alla non-ineffabilità della sua natura, che altrimenti porterebbe all’apofatismo maimonideo o al nichilismo teologico, secondo i quali nulla si può dire su Dio se non di negativo: non/materiale, non/finito eccetera.
“Ma queste sono leggere incrinature, che non intaccano sostanzialmente il saldo blocco della sua vasta opera ” (U. Degli Innocenti, cit., col. 1508).
Infatti, nonostante ciò, il Gaetano difende mirabilmente la dottrina del Dottore Comune dagli attacchi di Duns Scoto, degli scotisti e degli averroisti nel suo Commento alla Somma Teologica. Infine nella III pars, trattando della giustificazione, confuta mirabilmente l’errore luterano basandosi sull’insegnamento della Somma Teologica dell’Aquinate.
LA SECONDA SCOLASTICA
II – Lo sviluppo: l’età d’oro del Tomismo tridentino e salamanticense (XVI-XVII secolo)
La Seconda Scolastica contro il nominalismo
Nel XIV secolo il nominalismo aveva fatto strage delle intelligenze cristiane e molti avevano abbandonato la fonte pura della Scolastica tomistica medievale per abbeverarsi alle cisterne inquinate ed avvelenate dello scotismo e soprattutto dell’occamismo, che oscilla tra un fideismo esagerato ed un razionalismo radicale, avendo scisso radicalmente fede e ragione, aprendo così le porte al soggettivismo moderno. Infatti da Occam († 1349) nascono i tre soggettivismi relativisti 1°) in filosofia con Cartesio; 2°) in teologia con Lutero († 1546) e 3°) in politica con Machiavelli († 1527) e Rousseau († 1778).
1) Il Concilio Tridentino
Il Concilio di Trento opera la grande e vera Riforma delle intelligenze, dei costumi, della spiritualità contro la falsa riforma o meglio rivoluzione del protestantesimo mediante la filosofia e teologia della Seconda Scolastica tomistica, la quale, in maniera precisa, chiara, ordinata, sistematica e metodologica, affronta e risolve i problemi religiosi, politici, ascetico/mistici ed ecclesiologici della modernità filosofico/teologica alla luce dei princìpi del Tomismo originario.
Nel Quattro/Cinquecento, speculativamente parlando, per quanto riguarda la riforma dell’intelligenza abbiamo già visto i nomi più famosi della Seconda Scolastica: Capreolus, Cajetanus e Ferrariensis. Dopo il Tridentino i commentatori non si contentano più di spiegare la lettera di S. Tommaso articolo per articolo per coglierne il vero significato, ma istituiscono delle Disputationes sui problemi dibattuti nel loro tempo specialmente dal Luteranesimo e dal razionalismo politico, sebbene Domingo Bañez faccia accezione e spieghi ancora la Somma Teologica articolo per articolo (cfr. R. Garrigou-Lagrange, La sintesi tomistica, Brescia, Queriniana, 1952, p. 35 ss.).
2) L’università di Salamanca
Tuttavia dal Tridentino e dalla università spagnola di Salamanca nasce una nuova vena della Seconda Scolastica, che produrrà i grandi Dottori mistici: S. Giovanni della Croce, S. Teresa D’Avila e S. Ignazio da Loyola. Perciò ci resta da passare brevemente in rassegna la “turba magna” dei grandi Dottori scolastici tridentini e salamanticensi. Alcuni li abbiamo già studiati come metafisici “decadenti”, anche se ottimi studiosi del diritto naturale, internazionale, della filosofia politica e dell’ecclesiologia (Francisco Suarez); altri li abbiamo visti per quanto riguarda la filosofia politica e la polemica ecclesiologica contro il Luteranesimo: S. Roberto Bellarmino, Francisco Suarez, Pedro de Ribadeneyra; Juan Mariana. Però resta da studiare ancora qualche altro luminare della filosofia e teologia moderna o tridentina: Domingo Bañez e Luis de Molina (che abbiamo trattato nel capitolo su Premozione e Predestinazione), Domingo de Soto, Melchior Cano e Giovanni da S. Tommaso.
Francisco de Vitoria
Francisco de Vitoria (1483-1546). Entrò dai Domenicani di Burgos da ragazzo e vi emise la sua professione religiosa nel 1506, poi fu inviato a Parigi per studiare teologia e nel 1522 conseguì la licenza in teologia. Quindi iniziò ad insegnare teologia a Parigi nello studio domenicano di Saint-Jacques sino al 1523 e poi a Valladolid nel Collegio San Gregorio (1523-26). Nel 1526 ottenne la prima cattedra di teologia nell’università di Salamanca, che aveva eclissato la Sorbona di Parigi, e vi restò per circa un ventennio sino alla sua morte avvenuta nel 1546.
Grande erudito e grande insegnante, si diceva che avesse ricevuto dal cielo il dono del buon insegnamento che incantava gli allievi, tra cui spiccano Melchior Cano e Domingo de Soto. Fu il de Vitoria a far accantonare formalmente i Quattro libri delle Sentenze di Pietro Lombardo come manuale ufficiale di teologia per sostituirlo con la Somma Teologica di San Tommaso d’Aquino, che iniziò, così, ad essere commentata de jure dai professori al posto delle Sententiae di Pier Lombardo. Nel 1532 l’esempio del de Vitoria fu seguìto da Domingo de Soto e pian piano in tutte le università europee i Maestri iniziarono a commentare non solo de facto ma per principio la Summa theologiae sancti Thomae Aquinatis.
Vitoria veniva consultato dai re e dai vescovi per avere un buon consiglio. Per primo nel 1528 si accorse della eterodossia di Erasmo da Rotterdam. Inoltre si batté contro l’opinione di coloro che volevano battezzare immediatamente gli Indios recentemente colonizzati dalla Spagna per dar loro solo successivamente un rudimento di dottrina cristiana, sostenendo che bisogna prima insegnare il catechismo agli Indios, come a tutti gli altri uomini, e solo dopo si possono dare i Sacramenti, battesimo incluso. Infine la sua grandezza e originalità è legata alla sistematizzazione del Diritto internazionale (De jure gentium).
Le sue opere più famose sono il Commento alla Somma Teologica di S. Tommaso d’Aquino alla luce del Commento del Gaetano reso più accessibile dal genio pedagogico del de Vitoria, che faceva difetto al de Vio; la Summa Sacramentorum Ecclesiae; le XIII Relectiones theologicae, ossia la raccolta di tutte le sue lezioni di teologia. In realtà ne dette XV ma solo XIII ce ne son pervenute: De potestate Ecclesiae prior (1532); De potestate Ecclesiae posterior (1533); De potestate civili (1528); De potestate Papae et Concilii (1534); De Indis prior (1539); De Indis posterior et de jure belli (1539); seguono le Lezioni sul Matrimonio, la Temperanza, l’Omicidio, la Carità, la Simonia, la Magia. Le più famose ed importanti sono quelle che trattano di ecclesiologia (Papa e Concilio) e di filosofia politica (potere civile temporale e diritto naturale degli Indios, che vanno considerati come uomini a tutti gli effetti). Come si vede, il Tomismo è rimasto sempre vivo in ogni epoca e pronto a rispondere alle obiezioni degli uomini che si trovavano a vivere situazioni difficili religiosamente (rivoluzione luterana) e socialmente (rivoluzione umanistico/rinascimentale e machiavellica). Di fronte alla anarchia luterana e umanistico/razionalista Vitoria ribadisce che sia la Chiesa che lo Stato non possono sussistere senza un’autorità in atto (e non virtuale). Egli riprende la dottrina tomistica (De regimine principum) della subordinazione dello Stato alla Chiesa per la superiorità del fine spirituale ecclesiastico su quello temporale statale, confuta il separatismo dell’Umanesimo e del Rinascimento, la falsa scienza politica moderna o “machiavellica” e la concezione spiritualista della Chiesa propria dei luterani, che porta all’anarchia religiosa e al soggettivismo teologico.
Melchior Cano
Insegnò teologia a Salamanca, partecipò al Tridentino, intervenendo sui Sacramenti e specialmente sull’Eucarestia, la Penitenza e il Sacrificio della Messa, temi molto attuali anche oggi dopo la riforma neomodernistica del Novus Ordo Missae del 1969.
Dotato di un intelletto lucido e sistematico è il padre della teologia dei “Luoghi teologici”. Infatti scrisse il famoso trattato Libri XII de Locis theologicis (usciti postumi). Altri scritti sono la Relectio de Sacramentis (1547) e la Relectio de Poenitentia (1548), mentre i suoi Commenti alla Somma Teologica dell’Aquinate son rimasti inediti.
I Luoghi Teologici sono «la sede di tutti gli argomenti della Scienza Sacra a partire dai quali i teologi traggono le loro argomentazioni sia per dimostrare una verità sia per confutare un errore» (M. Cano, De Locis theologicis, Roma, ed. T. Cucchi, 1900, Lib. 1, cap. 3). Melchior Cano ha stabilito 10 Luoghi teologici: a) “Luoghi propri e apodittici”: Tradizione e Scrittura (Fonti della Rivelazione), le Decisioni della Chiesa, dei Concili e dei Papi, che equivalgono al Magistero ecclesiastico pontificio/universale, ordinario/straordinario; l’autorità del Concilio senza il Papa è nulla poiché il Papa è il legittimo successore di Pietro cui Cristo ha dato un Primato di giurisdizione diretto e universale su tutta la Chiesa e le decisioni dei Concili o dei Papi sono infallibili quando definiscono una dottrina di fede o di costumi e la impongono; b) “Luoghi intrinseci e probabili”: l’insegnamento dei Padri, degli Scolastici, che – se è moralmente unanime nell’interpretazione della S. Scrittura – è segno di infallibilità; c) “Luoghi estrinseci”: la ragione umana, la retta filosofia e la storia. Questi ultimi tre sono “Luoghi alieni” o fonti ausiliarie per il lavoro teologico. I primi due sono “Luoghi fondamentali” o fonte della Rivelazione e quindi della Teologia, che deriva dal Dato Rivelato; gli altri cinque contribuiscono intrinsecamente alla retta interpretazione della Rivelazione.
Domingo de Soto
Nacque nel 1495 ad Alcalà e morì a Salamanca nel 1560. Nel 1524 entrò nell’Ordine Domenicano e gli venne assegnata la cattedra di teologia presso l’università di Salamanca ove affiancò il de Vitoria per un ventennio. Partecipò al Concilio di Trento e contribuì notevolmente alla elaborazione dei Decreti sulla giustificazione (sess. VI) e sul peccato originale.
I suoi scritti filosofici principali sono le Summulae (4 voll., 1529) e i Commenti ad Aristotele: In dialecticam Aristotelis (1543); In libros Physicorum (1545). Ma le sue opere più famose riguardano la teologia: De natura et de gratia (Venezia, 1547); De justitia et de jure (Salamanca, 1553 con 27 ristampe). Infine un trattato sui Sacramenti intitolato In IV Sententiarum (2 voll., Salamanca, 1557-1560).
Il suo pensiero spazia dalla metafisica, al diritto naturale, alla politica, alla dogmatica. Assieme al de Vitoria, ma subordinatamente a lui, è il pilastro della rinascita del Tomismo nella Seconda Scolastica. Tuttavia se eccelle nel diritto naturale e internazionale, in metafisica zoppica poiché nega la distinzione reale tra essenza ed essere, che è uno dei capisaldi del Tomismo originario.
Soto, col Vitoria, risplende nel diritto naturale e internazionale. L’origine dell’autorità (civile ed ecclesiastica) è Dio, ma – mentre il potere spirituale deriva al Papa immediatamente da Dio – il potere temporale giunge al Capo da Dio mediatamente, cioè tramite il popolo come canale (De justitia et jure, 1553).
Nella questione della grazia si allontana alquanto dall’insegnamento tommasiano. Infatti nega la pre-mozione fisica o reale da parte di Dio come Causa prima e la cooperazione susseguante dell’uomo come causa seconda ed insegna la causalità finale di Dio, che attira l’uomo “illuminando, chiamando e attraendo” come oggetto di amore, moralmente e non efficientemente (De natura et de gratia, 1547).
Giovanni di San Tommaso
Con Juan de Poinsot detto Giovanni di San Tommaso e Domingo Bañez, che dettero alla scuola di Salamanca – nel Seicento – un indirizzo eminentemente speculativo, mentre nel Cinquecento Soto, Cano e Vitoria le avevano dato un’impronta piuttosto pratica, morale e politica, inizia quella che alcuni chiamano la “Seconda Scuola di Salamanca” per distinguerla dalla “Prima Scuola di Salamanca” del Cinquecento.
Di Bañez abbiamo già parlato nella trattazione del problema della predestinazione e della grazia efficace. Quindi trattiamo adesso solo di Giovanni di San Tommaso.
Egli era portoghese e non spagnolo, nato a Lisbona da padre austriaco e madre portoghese nel 1589; il suo cognome è poco noto: de Poinsot. Nel 1610 entrò nell’Ordine dei Predicatori e nel 1620 fu nominato professore di teologia a Madrid, Plasencia e poi ad Alcalà. Morì nel 1644 a soli 56 anni nel pieno delle sue forze fisiche e intellettuali.
La sua produzione filosofico/teologica è strettamente legata con una grande fedeltà al pensiero di San Tommaso d’Aquino, “del quale è stato uno degli studiosi più attenti e più profondi. Da molti è considerato il miglior commentatore, e non solo del suo tempo, del pensiero dell’Aquinate. Il suo lavoro consistette principalmente nella ricerca dell’interpretazione genuina del pensiero dell’Angelico” (B. Mondin, Storia della teologia, Bologna, ESD, 1996, III vol., p. 280).
Profondo conoscitore della dottrina di S. Tommaso, ha raccolto i princìpi del Tomismo in una esposizione sistematica e “manualistica”. Come Capreolo combatté Scoto, così Giovanni di San Tommaso è fiero avversario dell’eclettismo metafisico di Suarez.
Le sue opere principali sono il Commento alla Prima Secundae (4 voll.) e alla Secunda Secundae (3 voll.), ma ancora più importanti sono il Cursus Theologicus thomisticus (8 voll., Lione/Parigi, 1663-1667) e il Cursus Philosophicus thomisticus (9 voll., Roma, 1637-38). Molti grandi Autori della prima Neoscolastica si rifanno a questi due Corsi del de Poinsot (per esempio N. Dal Prado, M. Penido, A. Lépicier, V. Cathrein, J. Gredt, F. Maquart, E. Hugon, A. Gardeil, R. Garrigou-Lagrange, J. Maritain, Ch. Journet e J.-M. Ramirez).
È singolare la coincidenza che proprio nel momento in cui Cartesio apriva la strada al primato del pensiero (Cogito) sulla realtà (ergo sum), Giovanni di San Tommaso (Cursus Philosophicus, IV, 10, 4) ripropone le teoria aristotelico/tomistica della conformità ed adeguazione del pensiero alla realtà (“adaequatio rei et intellectus”), riafferma che l’oggetto dell’intelletto è la “quiddità intelligibile della cosa sensibile”, che “nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu” e quindi la conoscenza sensibile è la prima via che apre le porte alla verità razionale conosciuta dall’intelletto per astrazione logica dalle immagini sensibili (Cursus Philosophicus, Logica, II, 23, 3). La metafisica, dunque, è il vertice di ogni conoscenza umana (Ibid., Logica, II, 26, 2).
Solo la mistica sorpassa la metafisica razionale (De Donis Spiritus Sancti, IV, nn. 13-14) e perfeziona l’ascetica secondo la dottrina delle tre vie della vita spirituale di S. Tommaso d’Aquino: la prima via purgativa e la seconda via illuminativa, proprie dell’ascetica, sono percorse dai principianti e dai progredienti; la terza via unitiva, propria della mistica, è percorsa dai perfetti.
La teologia, nata con la Patristica, ha la sua prima pietra miliare con S. Agostino. La Scolastica porta la teologia ad attingere il vertice della speculazione acuta e serena con S. Tommaso d’Aquino. Di fronte all’Umanesimo e al Luteranesimo nasce la Seconda Scolastica e di fronte all’Idealismo moderno la Neoscolastica, che riconosce pienamente la originalità e la assoluta perfezione della metafisica tomistica anche al di sopra di quella aristotelica. Questa è la attualità e la potenza irrefrenabile della sintesi tomistica.
LA TERZA SCOLASTICA (XVIII secolo)
La Terza Scolastica, pur non avendo l’acume speculativo, la forza della Prima e la vis polemica della Seconda Scolastica (la quale con i Dottori di Salamanca e del Collegio Romano aveva toccato vette speculative altissime), ha ribadito i grandi princìpi della metafisica dell’essere alla luce del Concilio di Trento ed ha sistematizzato la vasta speculazione filosofico/teologica del XIII-XVII secolo, che si trovava dispersa in vari Commenti specifici su questioni particolari, in relativamente pochi volumi, che inquadrano e compendiano tutta la teologia dogmatica e la teologia morale secondo lo spirito di san Tommaso.
Invece per la filosofia e soprattutto per la metafisica tomistica e la teologia ascetica e mistica occorre attendere il primo e soprattutto il secondo Neotomismo o la prima e seconda Neoscolastica del XX secolo con i suoi studi specifici di alto livello e i suoi Manuali tanto utili quanto oggi disprezzati.
La Terza Scolastica è più ricca di teologi che di filosofi, mentre il Neotomismo o la Neoscolastica, in gestazione già a partire dal 1850 – prima Neoscolastica – e nata ufficialmente con l’Enciclica Aeterni Patris di Leone XIII nel 1879 e sviluppatasi – seconda Neoscolastica – lungo il Novecento sino ad oggi, è ricca di filosofi e di teologi altamente qualificati, convinti di poter rispondere alle istanze di Cartesio, Kant ed Hegel alla luce della filosofia tomistica.
La Terza Scolastica inizia nel XVIII secolo soprattutto come reazione al razionalismo illuminista. Il suo più illustre rappresentante è il padre domenicano belga Charles René Billuart (1685-1757). Nato a Revin sulla Mosa nelle Ardenne. Egli è il più profondo studioso del tomismo di tutto il XVIII secolo. È celebre il suo Commento alla Somma Teologica dell’Aquinate in 19 volumi (Liegi, 1746-1751), intitolato Summa S. Thomae hodiernis Academiarum moribus accomodata, che è stato compendiato dallo stesso Billuart in soli 6 volumi: Summa Summae Sancti Thomae (Gand, 1754, Mondovì, V ed., 1903). Un suo confratello fece uscire postuma (appena un anno dopo la sua morte) un’altra sua opera Supplementum Cursus theologiae (Liegi, 1759). Billuart aggiorna l’Aquinate per confutare l’errore dei protestanti e dei giansenisti. La sua opera è tuttora valida soprattutto per quanto riguarda la teologia morale (cfr. P. Mandonnet, in D. Th. C., vol. II, coll. 890-892, voce Billuart; L. Flynn, Billuart and his Summa, London, 1938).
IL NEOTOMISMO O NEOSCOLASTICA (dal 1850 ad oggi)
Verso la metà dell’Ottocento – con la Neoscolastica o Neotomismo – a Roma, presso la Civiltà cattolica e l’Università Gregoriana (come pure a Piacenza presso il Collegio Alberoni e a Napoli presso il Collegio della Compagnia di Gesù, la quale si distinse allora nella rinascita del Tomismo forse più dell’Ordine dei Frati Predicatori), iniziò un gran ritorno al Tomismo nella lotta contro la modernità, il liberalismo e l’idealismo.
Specialmente la seconda Neoscolastica ha avuto il gran merito di mettere pian piano in luce l’originalità e la sublimità della metafisica tomistica, che non è un puro commento di Aristotele, ma lo sorpassa, lo eleva e lo “trasfigura” dalla usiologia alla filosofia dell’essere come atto ultimo di ogni sostanza, forma ed essenza.
Inoltre già il primo Neotomismo aveva sbarrato la porta agli errori della modernità idealistica, aveva distinto ragione e fede, filosofia e teologia, aveva combattuto il fideismo tradizionalista francese e il razionalismo idealista tedesco.
I- Il primo Neotomismo (1850-1900)
Già all’inizio dell’Ottocento la fiaccola della prima Neoscolastica si era riaccesa pian piano dopo il torpore del Settecento (escluso il Billuart) soprattutto a Piacenza nel Collegio Alberoni per opera del canonico Vincenzo Buzzetti († 1824) con le sue Institutiones sanae philosophiae iuxta divi Thomae atque Aristotelis inconcussa dogmata (2 voll., Piacenza, 1940-41, postumo a cura di Amato Masnovo) e dei suoi discepoli più brillanti tra i quali spicca Serafino Sordi († 1865) alla cui scuola si formarono il gesuita card. Giuseppe Pecci (fratello di Gioacchino, il futuro Leone XIII) e il padre gesuita Luigi Taparelli D’Azeglio († 1862) con il Saggio teoretico sopra il Diritto naturale (5 voll., Palermo, 1840-43). A Napoli nel Collegio dei Gesuiti si formarono padre Matteo Liberatore († 1892) e Gaetano Sanseverino († 1865) con la ponderosa e geniale Philosophia christiana cum antiqua et nova comparata (5 voll., Napoli, 1862-67). Poi nel 1850 la sede de La Civiltà Cattolica, nata nel 1849, fu trasferita da Napoli a Roma e lì, grazie anche alla Università Gregoriana, risplendettero i grandi maestri del Neotomismo: p. Giovanni Cornoldi († 1892) autore de Il Rosminianesimo sintesi dell’ontologismo e del panteismo (Roma, 1881); La Filosofia scolastica speculativa di S. Tommaso d’Aquino (Bologna, 1881), Taparelli D’Azeglio e Liberatore alla cui scuola si formarono Giovanni Perrone († 1876) autore de L’Ermesianismo (3 voll., Roma, 1838-39) contro il razionalismo di Hermes e Günther; Giovanni Battista Franzelin († 1886) De divina Traditione et Scriptura, 1870; De Ecclesia Christi, 1887 e il domenicano Tommaso Zigliara († 1893) con la classica Summa philosophica in usum scholarum (3 voll., 1891), natio della Corsica e studente di teologia a Roma e a Perugia.
Sempre alla Gregoriana si formarono le due stelle della filosofia e della teologia tomista: i padri gesuiti Guido Mattiussi († 1925) Fisica razionale (2 voll., Milano, 1869-1901); Il veleno kantiano (Monza, 1907); Commento alle XXIV Tesi del tomismo (Roma, 1917) e il card. Louis Billot († 1931) De Verbo incarnato, 1892; De Deo uno et trino, 1895; De Ecclesia Christi, 1898-1910; De gratia Christi, 1912; La Parusia, 1920.
II – Il secondo Neotomismo (1900-2000)
Reginaldo Garrigou-Lagrange
Tra i grandi filosofi e teologi neotomisti spicca il padre domenicano Reginaldo Garrigou-Lagrange (1877-1964). Le sue opere più famose sono: Il senso comune. La filosofia dell’essere e le formule dogmatiche, Parigi, 1909; Dio sua esistenza e sua natura, 2 voll., Parigi, 1914; De Revelatione, 2 voll., Roma/Parigi, 1918; Perfezione cristiana e contemplazione, 2 voll., Parigi, 1923; Il Salvatore e il suo amore per noi, Parigi, 1933; La predestinazione dei santi e la grazia, Parigi, 1935; Le tre età della vita interiore, 3 voll., Parigi, 1938/39; De Deo uno, Torino/Roma, 1938; La Madre del Salvatore e la nostra vita interiore, Parigi, 1941; De Eucharistia, Torino/Roma, 1942; De Deo trino et creatore, Torino/Roma, 1943; De Christo salvatore, Torino/Roma, 1945; De gratia, Torino/Roma, 1946; La Sintesi tomistica, Parigi, 1946; De virtutibus theoligicis, Torino/Roma, 1949; La vita eterna e le profondità dell’anima, Torino/Roma, 1950).
Etienne Gilson
Il professor Etienne Gilson (1884-1979) ha dato un notevole impulso allo studio dell’intera storia della filosofia e della teologia medievale (La filosofia di Bonaventura, 1924; Introduzione allo studio di S. Agostino, 1929; La teologia mistica di S. Bernardo, 1934; Lo spirito della filosofia medievale, 1932; Il realismo tomista, 1939; La filosofia del Medio Evo, 1944; Giovanni Duns Scoto, 1952) e (dopo padre Cornelio Fabro) ha approfondito il tema della originalità di S. Tommaso, questione mancata al grande p. Garrigou-Lagrange, che ha trattato molto profondamente e fedelmente la dottrina sia filosofica che teologica dell’Aquinate, ma in filosofia lo ha visto solo come un fedele e acuto commentatore di Aristotele, corretto in qualche punto discordante con la divina Rivelazione (cfr. R. Garrigou-Lagrange, La sintesi tomistica, Brescia, Queriniana, 1952, pp. 15-29, 41-68, 399-448, 501-514, 541-554). L’opera più famosa di Gilson è soprattutto la IV edizione de Il Tomismo (Parigi, Vrin, I ed., 1919) pubblicata nel 1941. Infatti solo nel 1941 il Gilson giunge alla scoperta della originalità della metafisica tomistica dell’essere come atto ultimo e l’anno seguente approfondì la questione con L’essere e l’essenza (Parigi, Vrin, 1948). Inoltre Gilson ha confutato (Il realismo metodico, 1936; Realismo tomista e critica della conoscenza, 1939) la tendenza del card. Desiderio Mercier (Le origini della psicologia contemporanea, 1897) a coniugare S. Tommaso con un certo criticismo kantiano della conoscenza, dando luogo al “Tomismo trascendentale” assieme a p. Joseph Maréschal (Il tomismo e la filosofia critica, 1926).
Jacques Maritain
Jacques Maritain (1882-1973) dopo aver aderito da giovane alla filosofia di Bergson se ne distaccò e la confutò (La filosofia bergsoniana. Studi critici, 1914). Si avvicinò a S. Tommaso (Arte e Scolastica, 1920; Elementi di Filosofia, 2 voll., 1921-23; Antimoderno, 1922; S. Tommaso d’Aquino, 1923; Tre riformatori: Lutero, Cartesio e Rousseau, 1925; Primato dello Spirituale, 1926; Distinguere per unire. I gradi del sapere, 1932; Sulla filosofia cristiana, 1933) ma dopo il 1936 cadde nel modernismo o progressismo che dir si voglia (Umanesimo integrale, 1936; Cristianesimo e democrazia, 1945). I lavori in cui abbozza la dottrina della originalità della metafisica tomistica rispetto ad Aristotele sono Sette lezioni sull’essere, 1934 e Breve trattato dell’esistenza e dell’esistente, 1947, in cui permane una certa vaghezza sia rispetto a Gilson e soprattutto a Cornelio Fabro.
Francesco Olgiati
Monsignor Francesco Olgiati (1886-1962) co-fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con p. Agostino Gemelli, ha scritto eccellenti monografie critiche dei filosofi moderni, le quali dimostrano un’eccezionale conoscenza dell’Olgiati delle loro opere ed un acuto spirito critico nella loro confutazione (La filosofia di Enrico Bergson, 1914; Carlo Marx, 1918; L’idealismo di Giorgio Berkeley, 1926; Il significato storico di Leibniz, 1929; Cartesio, 1934; Il panlogismo hegeliano, 1946). Inoltre ha approfondito lo studio del Tomismo (L’anima di S. Tommaso d’Aquino, 1923; Il concetto di giuridicità in S. Tommaso d’Aquino, 1943) e ha esposto il cuore della filosofia classica greco/romana (I fondamenti della metafisica classica, 1950).
Sofia Vanni-Rovighi
Sofia Vanni-Rovighi (1908-1990) è stata un’eccellente studiosa della filosofia medievale (S. Anselmo e la filosofia dell’XI secolo, 1949; Introduzione a S. Tommaso d’Aquino, 1973; Studi di filosofia medievale, 2 voll. 1978), tomistica (Elementi di filosofia, 3 voll., 1941-50; Gnoseologia, 1963) e critica della filosofia della modernità (La filosofia di Husserl, 1939; Introduzione allo studio di Kant, 1945; Heidegger, 1945; Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito di Hegel, 1973; Storia della filosofia contemporanea, 2 voll., 1980)
Cornelio Fabro
Padre Cornelio Fabro dell’Ordine degli Stimmatini (1911-1995) è il maggior filosofo neotomista del secolo quanto ad acume speculativo. Fabro è stato il primo ad aver messo in luce (nel 1939 con La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso, p. 190 ss. seguìto nel 1941 da Etienne Gilson con la IV edizione de Il Tomismo) l’originalità e la superiorità della metafisica di S. Tommaso su quella di Aristotele e come anche Platone ha avuto un influsso importante sulla metafisica della partecipazione dell’Angelico. Le sue opere fondamentali in cui sviscera questi argomenti sono: La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso, 1939; Partecipazione e causalità, 1961 che fanno da filo conduttore a tutta la sua vasta produzione scientifica. Altre opere sono: Dall’essere all’esistente, 1957; Introduzione all’ateismo moderno, 2 voll., 1964 (contenente un’ampia confutazione dell’immanentismo moderno e contemporaneo); L’uomo e il rischio di Dio, 1967; La svolta antropologica di Karl Rahner, 1974; L’avventura della teologia progressista, 1974 (costategli l’emarginazione da parte dei modernisti); Introduzione a S. Tommaso, 1983; L’enigma Rosmini, 1988 (che gli è costato molte critiche dagli ambienti degli intellettualoidi cattolici “progressistamente”/conservatori). Ottimo il suo libro Gemma Galgani. Testimone del soprannaturale (Roma, Editrice CIPI, 1989) uno dei recenti migliori scritti su Santa Gemma assieme a quello di padre Enrico Zoffoli, La povera Gemma (Roma, II ed., 1957).
Thomas Tyn
Thomas Tyn (1950-1990) padre Domenicano slovacco morto appena quarantenne a Bologna è l’autore della monumentale Metafisica della sostanza. Partecipazione e analogia entis, 1991. Egli tratta, con acume, del concetto di essere come atto ultimo perfezionatore della sostanza aristotelica, confuta la filosofia moderna da Cartesio all’hegelismo e difende il concetto di analogia interpretata da Gaetano come principalmente analogia di proporzionalità propria e non di attribuzione.
d. Curzio Nitoglia
18/8/2015