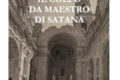fonte cesnur.com

L’induismo – insieme di credenze e pratiche di circa il settanta per cento degli abitanti dell’India e dell’ampia emigrazione indiana nel mondo, per un totale di 1.073.784.000 fedeli a livello planetario (213.000 nel nostro Paese, dei quali 50.000 cittadini italiani), secondo stime aggiornate al 2022 – trae la sua origine dalla parola sanscrita sindhu (fiume, corso d’acqua, area del fiume), corrispondente all’iranico hindu, con cui si indicava la terra più a Oriente del grande impero di Dario. In seguito, attraverso vari passaggi dal greco fino al latino indus, si è giunti al neologismo hindu mediante il quale si è soliti indicare l’insieme di usanze e convinzioni condiviso dalla maggior parte degli abitanti delle regioni a Est del fiume Indo. Più correttamente, come indicano le antiche scritture religiose di riferimento, i termini per definire tale “religione” – in realtà, insieme di religioni e credi religiosi – sono Sanatana Dharma (le “eterne leggi divine universali”) o Vaidika Dharma, insieme di norme contenute nelle sacre scritture dei Veda. Con il termine induismo non si intende, è opportuno sottolinearlo, un’unica struttura religiosa, ma una miriade di fedi, culture e filosofie, a volte anche distanti teologicamente fra loro, che manifestano però alcuni punti di convergenza comune, quali la teoria del karma e della reincarnazione, la possibilità di liberazione (moksha), l’accettazione dei Veda, il vasto numero degli dei adorati (peraltro, non tutte le correnti accettano le medesime manifestazioni del divino – dei o dee -, ma accettano il fatto che ogni manifestazione sia, in ultima analisi, un aspetto dell’unico Dio).
Le origini storiche dell’induismo sono state a lungo fatte risalire, secondo teorie oggi discusse anche criticamente dagli specialisti, all’arrivo degli ariani (insieme di tribù indoeuropee nomadi, di pelle chiara, provenienti dall’Asia centrale) nel subcontinente indiano – circa 1500 a.C. -, anche se più recentemente si va affermando la teoria cosiddetta “del substrato”, secondo la quale la religione degli ariani si sarebbe largamente avvalsa di materiale tratto dai precedenti abitatori del subcontinente, ivi residenti già a partire dal 2400 a.C. In proposito – e per rendere ragione dei due paradigmi attorno ai quali si articola la problematica relativa alle origini storiche dell’induismo -, è opportuno sottolineare come ampi settori dell’induismo ortodosso rigettino completamente sia la cosiddetta “teoria dell’invasione ariana” sia la “teoria del substrato”, considerate entrambe il frutto della storiografia eurocentrica, o addirittura reputate come una pura invenzione di studiosi occidentali, che avrebbero attribuito date e fatti storici adottando parametri arbitrari e soggettivi (si tratta, in questo caso, di una posizione non poco controversa, e che così posta rischia di cavalcare il tono fortemente politicizzato e nazionalistico della corrente contemporanea detta hindutva).
Comunque sia, le origini storiche dell’induismo, difficilmente databili, sono antichissime, e non mancano studiosi – archeologi e antropologi in particolare – i quali datano tracce della civiltà dell’Indo a prima del 6000 a.C. (una datazione che altri specialisti considerano acritica, postulando una sostanziale omogenia fra induismo e civiltà vallinde). Secondo questa versione, la civiltà indica arcaica e le diverse popolazioni che abitavano l’India dell’epoca, seguivano vari culti che nel tempo si sarebbero amalgamati, evolvendosi nelle forme vediche e agamiche delle pratiche religiose indù. È bene sottolineare che gli studiosi hanno applicato diversi parametri per suddividere l’evoluzione dell’induismo nelle varie epoche storiche (per esempio, in base ai testi di riferimento o al rituale, e così via); una possibile suddivisione potrebbe essere proposta in quattro periodi:
1. Il primo è detto vedico, dai Veda (“vera o sacra conoscenza”), testi sacri redatti in un periodo approssimativo compreso fra il 3000 e il 400 a.C. e canonizzati come increati ed eterni, auto-rivelazione dell’energia divina Brahman. Il periodo vedico si suddivide a sua volta in età dei Samhita (“raccolta degli inni”), dei Brahmana (composizioni sacerdotali di ritualistica) e delle Upanishad (parte speculativa-filosofica).
2. Il secondo periodo, durante la dinastia dell’impero Maurya (c. 560-200 a.C.), è l’età dei Sutra, o Kalpa Sutra, all’interno del quale si inseriscono i Vedanga (sei trattati supplementari ai Veda per la corretta celebrazione del rituale, in cui si trattano la corretta pronuncia, la metrica, l’etimologia, la grammatica, l’astronomia e le norme per la cerimonia).
3. Il terzo periodo, risalente al 200 a.C.-300 d.C. – fino alla fine della dinastia Gupta -, è quello Itihasa (“Così invero fu”, o poemi di carattere popolare leggendario, fra cui il Ramayana e il Mahabharata).
4. Il quarto periodo, a partire dal 300-650 d.C., è l’epoca dei Purana (raccolte di storie dei tempi antichi, che tradizionalmente trattano cinque argomenti: creazione dell’universo; sua distruzione e ricreazione; genealogia degli dei; regni e varie epoche del mondo; storia delle grandi dinastie solare e lunare), degli Agama (“ciò che è stato tramandato”; testi che contengono insegnamenti tradizionali non-vedici della tradizione Saiva) e dei Tantra (“fili intessuti su un telaio”; termine riferito a vari testi di carattere sia religioso sia laico, di tradizione sia hindu sia jaina e buddhista).
Questi periodi rispecchiano i passaggi fondamentali della religiosità indù: quello rituale, quello speculativo e quello devozionale, o bhakti. Peraltro, una peculiarità fondamentale dell’induismo è la sua visione atemporale, e quindi i periodi presi in esame non rispecchiano una rigida suddivisione cronologica, bensì una coesistenza e un intrecciarsi continuo. Infatti, il carattere di astoricità così affine alla cultura indiana è determinato da fattori quali la lunga trasmissione orale, la concezione tipica indiana dell’eternità dei Veda, la totale mancanza di rilievo data agli autori dei testi.
Sruti significa “ciò che è ascoltato” e sottolinea la trasmissione diretta, orale, da individuo a individuo, “ascoltata attraverso le orecchie e attraverso il cuore”. In origine, il termine era riferito ai seguenti testi: Veda, suddivisi a loro volte in quattro raccolte (Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda); Samhita; Brahmana. Successivamente, il termine sruti è stato esteso anche alle Upanishad. È opinione comune che il Rig Veda sia il più antico fra i testi vedici, dimostrata dal fatto che nelle altre raccolte vi siano porzioni più o meno ampie dei suoi 1.028 inni di preghiera con piccole addizioni e lievi alterazioni.
La religione vedica dà speciale importanza a numerose divinità “liturgiche”, quali Indra (simbolo della forza vitale), Agni (il fuoco), Soma (la pianta divina, il cui succo è estratto nel sacrificio), Varuna (il dio delle acque). Divinità specifiche presiedono alle tre funzioni della società – sacerdotale, guerriera, commerciale-agricola – cui corrispondono tre diverse caste (brahmana, ksatriya, vaisya), cui se ne aggiunge poi una quarta (sudra), più orientata verso la manualità; altre divinità – che diventeranno successivamente molto più importanti (per esempio, Vayu, Mitra, Parjania, Asvini, e così via) – hanno un ruolo, almeno apparentemente, secondario.
Nei Brahmana – che prendono il loro nome da Brahman (l’Assoluto) – sono elaborate le semplici idee sulla società e sul rito delle Samhita in una religione liturgica di tipo sistematico. Numerosi e complessi riti sono elaborati per la vita domestica, la morte (con la cremazione), i sacrifici di sostanze vegetali e di animali (soprattutto capretti). La funzione sacerdotale è cruciale nei Brahmana. Il sacrificio primordiale e unico di Purusha, di cui parlavano le Samhita, diventa in qualche modo secondario rispetto al sacrificio ricorrente di Prajapati, che simboleggia il ciclo di vita, morte e rigenerazione (da cui cominciano a emergere idee sulla reincarnazione). Prajapati è il prototipo del personaggio che nell’induismo classico diventerà Brahma, il dio che personifica l’assoluto, mentre Purusha diventerà un nome di Vishnu, e un’altra divinità dei Brahmana – Rudra – è il prototipo di Shiva, un dio che simboleggia la neutralizzazione delle forze impure che potrebbero minacciare il sacrificio.
Negli Aranyaka (“testi della foresta”), il rituale si sposta dalla casa alla foresta, mediante una interpretazione filosofica dei rituali attraverso le allegorie. La parte più squisitamente speculativa è composta dai testi delle Upanishad (“Ciò che si ascolta seduti ai piedi di un Maestro”), che costituiscono la parte essenziale del Vedanta, e che per taluni studiosi completano il passaggio dal “politeismo” vedico originario alla riduzione delle varie divinità a una (un concetto però già presente nel Rig Veda, dove è scritto: “Dio è uno, ma i saggi lo chiamano con molti nomi”). Nei vari momenti, dal rituale del periodo vedico alla speculazione o rinuncia delle Upanishad, a quello della devozione – bhakti -, al periodo dei Purana, Agama, Tantra, si sviluppano numerose tradizioni che compongono quella poliedrica struttura religiosa comprendente diverse teologie e filosofie, convergenti (come si è già detto) in temi quali il concetto di liberazione (moksha), il karma e la reincarnazione, l’autorità dei Veda, e così via.
Il concetto di karma, che talora ha assunto valore meritorio nel rituale, trova nelle speculazioni successive un risvolto più complesso e diventa maggiormente legato a una legge di causa-effetto che costituisce la causa delle successive reincarnazioni. Lo scopo dell’individuo, quindi, consiste nella liberazione dal ciclo delle rinascite (samsara), cioè nella moksha (“liberazione”). Per conseguire la liberazione, il rituale – così importante nei Veda – non è rifiutato, ma assumono importanza centrale la conoscenza (vidya) e gli insegnamenti che il maestro (guru) trasmette al discepolo. La conoscenza dell’Assoluto si sviluppa nelle Upanishad lungo due linee direttive, alle origini di una dialettica che percorre tutto l’induismo. Da una parte, l’Assoluto è concepito come “totalmente altro”, “né questo né quello” (neti neti), negazione di tutto ciò che è irreale, non permanente e transitorio; dall’altra l’affermazione di Assoluto come totalità, iti iti, il contrario di neti neti, definisce lo stesso Assoluto nelle sue qualità come sat cit ananda (realtà-coscienza-beatitudine).
Nella tipica predilezione per la classificazione del pensiero indiano, il numero quattro ha un posto particolare (anche se non il più rilevante): quattro sono i Veda; quattro sono le caste (anche se nascono innumerevoli sottocaste) – e l’induismo brahmanico tuona contro la confusione fra le caste e contro il matrimonio esogamico -; quattro sono gli stadi della vita dell’uomo, che in teoria – se non in una vita sola, attraverso le varie reincarnazioni – dovrebbe sperimentarli tutti, dallo studente al “rinunciante” (sannyasin), un ideale che l’induismo in questa sua fase di consolidazione afferma contro “eterodossie” (come il buddhismo e il giainismo) che distinguono invece fra laici e monaci; quattro sono anche gli scopi della vita, tre di carattere pratico e il quarto – la liberazione (moksha) – da perseguirsi in ogni stato della vita, e di ogni vita, ma particolarmente quando si è raggiunta la condizione di “rinuncianti”.
A proposito di come raggiungere la “liberazione”, lentamente nascono diverse scuole filosofiche o “punti di vista” (darsana), fra le quali la più nota è lo yoga (“aggiogamento” o “disciplina dell’aggiogamento”). La divisione fra i vari darsana è anche lo sfondo che vede nascere i movimenti di devozione (bhakti), che personalizzano il divino e fanno sentire la loro influenza nel periodo dei grandi testi epici – Itihasa – costituiti come si è accennato dal Mahabharata (che comprende la celebre Bhagavad Gita, il “Canto del Signore”) e dal Ramayana. L’universo che è qui descritto ruota intorno a Vishnu e alle sue incarnazioni (avatara), fra cui Rama e Krishna. A Vishnu è complementare Shiva – e la loro interazione regola i ritmi ciclici dell’universo – mentre Brahma, il creatore, la forma maschile dell’Assoluto impersonale, rimane – almeno originariamente – subordinato in quanto orientato verso il mondo.
La discesa degli avatara avviene, particolarmente, in tempi di crisi, per richiamare il mondo all’ordine. Così è ricostruita, in particolare, la missione di Krishna: con la precisazione, però, che Vishnu non scende nel mondo da solo e lo accompagnano “incarnazioni” di altre divinità, in particolare una dea, emanazione di un potere femminile (shakti) che comincia a essere considerato come essenziale all’opera cosmica della Trimurti composta da Vishnu, Shiva e Brahma. L’importanza della dea si riflette nel successo del movimento tantrico che, con radici precedenti (e forse con influenze pre-vediche), si sviluppa a partire dal quarto secolo d.C. e penetra non solo nell’induismo, ma anche nel buddhismo e nel giainismo (considerati sistemi filosofici nastika, ovvero eterodossi). Mentre il tantrismo critica il tradizionale sistema brahmanico (i suoi adepti vengono da tutte le caste, i maestri sono spesso di casta inferiore) e considera il corpo non un ostacolo, ma il principale veicolo della liberazione, una vigorosa ripresa dell’ortodossia (astika) induista è promossa da Adi Shankara (c.788-c.820), all’origine di un grande movimento riformatore e codificatore degli ordini monastici.
Shankara non è il fondatore, ma il principale promotore dell’Advaita Vedanta, una corrente “non dualistica” che insiste sull’importanza di considerare il mondo come illusione (maya). Tutto è illusione – compreso Dio, se lo si identifica con le sue qualità (saguna) – e tutto deve essere trasceso per sperimentare la pura unità fra il sé e Brahman, che è l’Assoluto “senza qualità” (nirguna). Da questo punto di vista, nonostante l’aspirazione a riconciliare tutte le correnti dell’induismo, l’Advaita Vedanta si pone in oggettivo contrasto con le varie forme di devozione bhakti, che continuano a fiorire e che a partire dall’XI e XII secolo corrono parallele alla formazione dei sampradaya (“tradizioni”, o “sette”, un’espressione questa che tra gli studiosi dell’induismo non ha un significato negativo, ma identifica i gruppi che onorano in particolare una specifica divinità oppure seguono gli insegnamenti di un particolare maestro).
Tra i maestri più importanti dell’induismo delle sampradaya vanno segnalati Ramanuja, tra l’XI e il XII secolo, e – molto più tardi, in Bengala – Krishna Mahaprabhu Chaitanya (1486-1533), fondatore della “setta” Gaudiya Vaishnava, alle origini dei moderni Hare Krishna e di diversi altri movimenti contemporanei. Contemporanei di Chaitanya nell’India occidentale e settentrionale sono maestri che si definiscono per il loro rapporto con l’islam, o di tipo polemico ovvero – al contrario – sincretistico, come nei casi di Kabir (1440-1518) e Nanak, quest’ultimo all’origine della religione sikh, che nasce precisamente dall’incontro fra islam e induismo.
Ancora più recentemente, l’induismo si è definito in relazione all’Occidente e al cristianesimo. Nascono così i grandi movimenti di riforma del XIX secolo, il Brahmo Samaj, fondato nel 1828 da Raja Ram Mohan Roy (1772-1833), e l’Arya Samaj, fondato nel 1875 da Swami Dayananda Sarasvati (1824-1883) e che ha una piccola sezione italiana, attiva dal 2011 e animata dall’ex-musulmano Massimo Palazzi con il nome di Satya Prakash Shankar. Pure molto diversi fra loro, entrambi presentano l’induismo come monoteismo. Altri maestri si pongono il problema di portare l’induismo in Occidente, superando il punto di vista secondo cui si tratta di una religione per i soli indiani.
La rinascita spirituale dell’induismo di fronte alla sfida dei missionari cristiani nel XIX secolo – e la successiva “contro-missione” in Occidente – è rappresentata particolarmente da Ramakrishna e dal suo discepolo Vivekananda, il “san Paolo dell’induismo”. Sulla scia di Vivekananda, moltissimi maestri indiani sono venuti in Occidente, e un catalogo anche succinto dovrebbe comprendere centinaia di nomi. Ci limiteremo, in questa sede, ai gruppi presenti in Italia, non senza notare che la maggior di loro rappresentano movimenti di riforma molti dei quali sono importanti in India per l’auto-definizione dell’induismo da un punto di vista intellettuale (e talora politico). Ma in India – e nell’emigrazione indiana – questi movimenti coesistono con forme popolari di religiosità del tutto diverse, che sarebbe peraltro improprio escludere dalla definizione di “induismo”, un concetto certamente insostituibile ma che gli studiosi considerano sempre più problematico.
B.: Per un’introduzione rapida, cfr. Ram Adhar Mall, L’induismo nel contesto delle grandi religioni mondiali, trad. it., ECIG, Genova 1997; Stefano Piano, Sanatana Dharma, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1996; Giorgio Renato Franci, Induismo, il Mulino, Bologna 2000; e Reender Kranenborg, L’induismo, Elledici, Leumann (Torino) 2003. Due importanti opere di carattere generale sono quelle di Thomas J. Hopkins, The Hindu Religious Tradition, Wadsworth, Encino (California) 1971; e di Wendy Doniger, The Hindus. An Alternative History, The Penguin Press, New York 2009. Sulla storia, cfr. Stanley Wolpert, Storia dell’India. Dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi, trad. it., Bompiani, Milano 1992; Hermann Kulke e Dietmar Rothermund, Storia dell’India, trad. it. Garzanti, Milano 1991; John L. Brockington, The Sacred Thread. Hinduism in Its Continuity and Diversity, Edinburgh University Press, Edimburgo-New York 1996. Sul dibattito a proposito delle origini: Edwin Bryant, The Indo-Aryan Migration Debate. In Quest of the Origins of Vedic Culture, Oxford University Press, Oxford – New York 2000. Sulla nozione di avatar: Daniel E. Bassuk, Incarnation in Hinduism and Christianity. The Myth of the God-Man, MacMillan, Basingstoke (Hampshire)-Londra 1987. Sulla “missione indiana” in Occidente (con spunti critici): Reinhart Hummel, Indische Mission und neue Frömmigkeit im Westen. Religiöse Bewegungen Indiens in Westliches Kulturen, Kohlammer, Stoccarda 1980. Infine, sui rapporti intrattenutisi nei secoli fra India e Occidente, si veda Wilhelm Halbfass, India and Europe, State University of New York Press, Albany (New York) 1988.