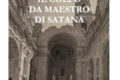Fonte: FSSPX Attualità
Giovanni di San Tommaso, I doni dello Spirito Santo.
Giovanni di San Tommaso è, insieme al Gaetano, uno dei più celebri commentatori di San Tommaso d’Aquino.
Nella Sacra Scrittura sono chiamati spiriti e doni: “Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, lo spirito di sapienza e di intelletto, lo spirito di consiglio e di fortezza, lo spirito di scienza e di pietà, lo spirito del timor di Dio lo riempirà”, possiamo leggere nel celebre brano di Isaia (11,2).
E Davide proclama a Cristo: “Sei salito in alto, hai fatto prigioniera la prigionia, hai ricevuto i tuoi doni negli uomini” (Sal 67,19). Queste ultime parole riguardano particolarmente i doni dello Spirito Santo che rendono l’anima docile alle sue ispirazioni.
Questi nomi sono eminentemente adatti al settenario divino. Innanzitutto perché questi due nomi si addicono allo Spirito Santo stesso. Spirito, in quanto procede dall’amore per “spirazione”, secondo il termine teologico, e per impulso d’amore. Dono, perché l’amore è comunicativo di se stesso, e il primo dono dell’amore è il cuore dell’amico, unito all’amato, presente in chi lo ama.
I doni hanno la funzione di perfezionare le virtù: vengono, per così dire, a lucidare, a dorare e a far risplendere le virtù in quei fini che non si raggiungono da soli. Perché la fede sola ci lascia in una certa oscurità; ma con l’aiuto del dono dell’intellietto, la fede diventa contemplativa e penetra più facilmente i misteri della fede.
Quaggiù non possiamo contemplare perfettamente in virtù della sola fede, tutt’al più siamo irrorati da una leggera rugiada, e questa rugiada stessa è quasi oscura. È quindi necessario che, per non venir meno, il cielo sia un po’ socchiuso davanti a noi, e questo fa lo Spirito Santo attraverso i doni dell’intelletto, della scienza e della sapienza.
Questi doni celesti sono chiamati anche spiriti perché sono ordinati in noi dall’ispirazione divina, poiché questa parola designa un certo impulso proveniente dall’esterno. Ogni creatura, per operare bene, ha bisogno del moto divino, soprattutto nell’ordine soprannaturale. Perché l’uomo diventi capace di agire ad un livello che va oltre la virtù, è necessario che riceva uno spirito (o forza) più nobile dal quale sia mosso da un impulso esterno che lo elevi.
Infine, i doni si chiamano spiriti perché l’anima li riceve come il soffio stesso di Dio quando egli l’adorna dei suoi doni, insuffla in essa il suo Spirito, affinché tutte le virtù dell’anima siano rese più perfette ed elevate ad un grado superiore di operazione.
il dono dell’intelletto
San Tommaso paragona il dono dell’intelletto alla luce innata che Dio mette in noi per scoprire la verità, chiamata intelletto dei primi principi o anche “intelligenza”. Questo dono, spiega, “ci fa vedere chiaramente che nulla di ciò che appare all’esterno ci permette di deviare dalla fede”. Il frutto di questo dono è la fede, non una virtù teologale, ma una speciale certezza di fede.
Così la mente viene perfezionata in modo tale da procedere senza confusione o senza alcuna mescolanza di errori. Ecco perché, tra le beatitudini, è la purezza del cuore che, secondo san Tommaso, corrisponde al dono dell’intelligenza. Purezza qui significa prendere le distanze dalle rappresentazioni sensibili e dagli errori, affinché le verità su Dio siano recepite correttamente.
Sant’Agostino racconta così nelle sue Confessioni che, in gioventù, quando era già uscito dall’errore manicheo, non poteva “concepire altra sostanza che quella che si vede con gli occhi” e intendeva Dio come “una sostanza corporea che penetra nel mondo in tutta la sua estensione, e diffondendosi, fuori dal mondo, nell’infinito”. Da questo errore egli venne gradualmente liberato, liberazione che va attribuita in parte al dono dell’intelletto.
Il dono dell’intelletto è ordinato alla contemplazione
Il dono dell’intelletto è particolarmente utile per la contemplazione, perché attraverso di essa lo Spirito Santo acuisce l’intelligenza, la rende più fine e le permette di avanzare nella luce, anche quando si muove nelle tenebre della fede. Per contemplazione non bisogna immaginare i grandi mistici: è destinata a tutti coloro che possiedono questo dono e ne assecondano le ispirazioni.
Il dono dell’intelletto illumina l’intelligenza in modo tale che essa conosce e penetra direttamente le cose spirituali per una certa connaturalità ed esperienza. Questa connaturalità si ottiene attraverso l’affetto: questo è ciò che produce il dono. Così dice il salmo: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore” (Sal 33,9).
Così il dono dell’intelletto permette di conoscere misticamente le cose spirituali in virtù dell’amore che connaturalizza e unisce a Dio, e di sperimentare le cose divine: questa mozione dello Spirito Santo per suo dono tende all’esperienza mistica e sperimentale, o affettiva.
A quali oggetti si estende il dono dell’intelletto? Sugli oggetti “nascosti”, nei quali la luce naturale della nostra mente non penetra sufficientemente. Ad esempio la percezione che, nella santa Eucaristia, sotto gli accidenti del pane (dimensione, sapore, colore, ecc.) non c’è più pane. Oppure i vari significati della Sacra Scrittura. O anche la redenzione attraverso la passione di Cristo.
I doni dello Spirito Santo sono sempre presenti in Cielo
I doni dello Spirito Santo in generale, e il dono dell’intelletto in particolare, rimangono in patria, cioè in Cielo. Non produce più esattamente la stessa azione, ma partecipa alla perfetta conoscenza di Dio, a seconda che sia conosciuta dai suoi effetti o nei suoi effetti. È una conoscenza “complementare” alla visione beatifica, da cui deriva.
Dalla visione di Dio scaturisce l’intimo amore di Dio e la gioia che ne deriva: da questa gioia scaturisce una certa conoscenza affettiva ed esperienziale non solo di Dio in se stesso (che è la visione beatifica), ma di Dio come gustato e vissuto o toccato dentro di noi.
il dono della sapienza
San Tommaso fa prima di tutto un accostamento tra il dono della Sapienza e la virtù intellettuale che porta lo stesso nome, che giudica le cause supreme delle cose; ed afferma che appartiene al dono del Sapienza il giudicare, come fa la virtù.
Ma mentre la virtù della Sapienza compie questo giudizio tramite le conoscenze acquisite, il dono della Sapienza permette di giudicare in modo retto in virtù della mozione particolare con cui l’anima unita a Dio segue prontamente l’ispirazione dello Spirito Santo e secondo una certa connaturalità con le cose divine, nonché un certo «gusto» sperimentale di queste cose.
In tal modo, il dono della Sapienza conosce le cause supreme tramite una esperienza interiore di Dio e delle realtà spirituali. Essa possiede una certa affinità con le cose divine e con le cause e ragioni divine. Ma queste non conosciute in sé stesse, cosa che è riservata a Cielo, ma tramite una connaturalità e una unione intima.
Dunque, il modo in cui il dono della Sapienza coglie la causa suprema – che è Dio – è la conoscenza sperimentale che l’anima possiede di Lui, nella misura in cui Egli è unito a noi, abita nell’anima in stato di grazia e si dona a noi.
L’Intelletto percepisce che ciò che è sperimentato nell’affetto è più alto e più eccellente di qualsiasi considerazione della fede: questo comporta un nuovo modo di essere conosciuto, cioè come unito al soggetto e da esso sperimentato.
A che si estende il dono della Sapienza ?
Il dono della Sapienza giudica tutto ciò che appartiene alla fede. San Tommaso interpreta queste parole dell’Apostolo: «l’uomo spirituale giudica ogni cosa» (1Cor. 2, 15) dal dono della Sapienza. Così, questo dono verte sulle stesse verità della fede teologale, ma esso le coglie tramite una sorta di contemplazione esplicita, mentre la fede le propone in maniera velata e più o meno oscura.
E’ per questo che l’Aquinate conclude: «questo dono riguarda principalmente le cose divine, e da esse può giudicare tutte le altre». Ecco perché il dono della Sapienza si estende anche alle cose umane, sia in maniera speculativa sia in maniera pratica.
Questa «scienza», questa Sapienza mistica e affettiva, è chiamata la scienza dei Santi, perché essa risiede solo in chi la riceve da Dio, e questa Sapienza non abita nell’anima di mala volontà. Ecco perché il dono della Sapienza è sovranamente contemplativa, sia quaggiù, dove è regolata dalla fede, sia in Cielo, dove è regolata dalla visione beatifica.
il dono della scienza
Il dono della Scienza dev’essere prima di tutto considerato in rapporto con la virtù intellettuale che porta lo stesso nome: la Scienza ci fa giudicare con evidenza a partire dalle cause e dagli effetti. Quando questo giudizio è effettuato a partire dalle cause inferiori e create, abbiamo la Scienza in senso stretto.
Come abbiamo già visto, quando si tratta delle cause supreme e divine, abbiamo la Sapienza.
San Tommaso insegna che «il dono della Scienza riguarda le cose umane e le altre cose create». Il dono della Scienza non si limita a conoscere solo la fede in sé stessa, a seconda che sia una certa cosa temporale nell’anima del credente, ma si estende a ogni cosa creata che può essere conosciuta dalla fede.
Il dono della Scienza è anche una conoscenza mistica e affettiva.
Nella Scrittura essa non è chiamata Scienza in modo generico, ma «spirito di scienza» e «scienza dei Santi», perché si trova solo in coloro che hanno la grazia.
Essa è fondata su una certa mozione dello Spirito Santo che guida l’Intelletto, non con una luce pura che manifesta la verità come è al di fuori, come farebbe una scienza infusa data da Dio, come si trovava in Cristo, ma con un’esperienza interiore e come una connaturalità affettiva e soprannaturale.
Questo dono gusta ed esperimenta primariamente le realtà divine, ma al tempo stesso gusta ed esperimenta le creature. In questo modo, l’anima si forma un retto giudizio su di esse, che la porta, da un lato, a conoscere la loro povertà e la loro miseria, in modo da non essere condotta da esse in maniera contraria all’ordine della carità, e dall’altro lato ad amare le creature nella giusta misura, ordinandole a Dio.
Come tutti i doni, il dono della Scienza partecipa strettamente alla vita contemplativa: essa permette di comprendere il niente delle creature confrontandole con Dio.
E’ così che San Tommaso, durante la sua ultima malattia e durante la Messa, vedeva il mondo come se fosse stato raccolto in un raggio di luce, e non voleva più scrivere nulla, perché tutto ciò che aveva scritto gli sembrava «come paglia».
Questo dono, pur riguardando inizialmente le cose create, persiste – come tutti gli altri doni – nella patria celeste. Esso agisce allora in dipendenza della visione beatifica e partecipa alla conoscenza di Dio al di fuori di questa visione – conoscenza chiamata vesperale, in opposizione alla visione, chiamata mattutinale.
il dono del consiglio
Il dono del Consiglio corrisponde alla virtù della prudenza, perché spetta alla persona prudente consigliare. Ma si chiama dono di Consiglio più che di Prudenza, per meglio sottolineare l’ispirazione divina che caratterizza i doni dello Spirito Santo.
San Tommaso spiega. “Nei doni dello Spirito Santo l’anima umana si comporta meno come un principio che come un soggetto di movimento; inoltre è opportuno che ciò che corrisponde alla prudenza venga chiamato non precetto [con cui l’anima è comandata a tale azione], o giudizio, ma Consiglio, per significare il movimento con cui uno spirito guida un altro spirito” (S Th. II-II, 52, 2, ad 1).
Il dono deli Consiglio regola le nostre azioni, non per ragioni umane, ma per ragioni divine, conosciute attraverso l’intima esperienza delle realtà divine, istruisce l’anima in tutto ciò che è necessario alla salvezza, senza però escludere la ricerca, guidata dallo Spirito Santo, che, secondo la promessa di Cristo, ci insegnerà tutta la verità, quanto all’indagine, al giudizio e all’azione.
Le facoltà pratiche possono essere perfezionate misticamente ed affettivamente, grazie all’unione con Dio, che dà loro una migliore disposizione e le rende più perfette nel giudizio prudenziale. I mezzi da utilizzare saranno allora valutati non secondo ragioni umane, ma secondo la fiducia in Dio, che è potente nel disporre tutti i mezzi e nel superare ogni difficoltà.
Il dono del Consiglio si fonda quindi soprattutto sulla Speranza divina, perché ha a disposizione molti mezzi che possono essere attuati solo grazie all’aiuto divino e all’onnipotenza di Dio, sulla quale si appoggia soprattutto la Speranza.
A quali oggetti si estende il dono del Consiglio?
Si estende direttamente a tutte le azioni che sono oggetto dei doni che regolano ciò che è affettivo, cioè i doni di forza, pietà e timore. Come la prudenza regola tutti gli atti delle virtù cardinali, così la prudenza dello Spirito Santo o dono del Consiglio ha per oggetto diretto di regolare e dirigere le operazioni che procedono dai doni dello Spirito Santo perfezionando le facoltà appetitive.
Indirettamente, e in modo secondario, il dono del Consiglio può orientare ciò che rientra nell’ambito delle regole comuni, in quanto queste devono essere soggette e subordinate alle regole divine. E non solo le cose di consiglio, ma anche quelle di precetto possono essere dirette dal dono del Consiglio.
E’ da notare che, se il dono del Consiglio agisce sempre sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, tuttavia, la soluzione non sempre viene consegnata immediatamente a ciascuno dallo Spirito Santo, ma spesso attraverso l’intermediazione di altri uomini, con i quali si vuole che ci consultiamo su ciò che deve essere fatto. Così, attraverso il dono del Consiglio, lo Spirito Santo ci porta a consultare gli altri, per poi accogliere e realizzare ciò che è stato ben esaminato.
Santa Giovanna d’Arco stupiva spesso con le sue decisioni i generali di Carlo VII.
Così a Orléans, Dunois e i suoi luogotenenti credevano di aver fatto abbastanza per liberare una sponda del fiume: “No, no, diceva Giovanna. Voi avete seguito il vostro consiglio e io ho seguito il mio. Credete che il consiglio del mio Re e Signore prevarrà sul vostro. Domani sarete in piedi con l’esercito”.
il dono della pietà
San Tommaso dice che il dono della Pietà riguarda Dio come Padre. Nel Commento alle Sentenze egli spiega: «Benché la virtù di religione si rivolga a Dio, essa è misurata con qualcosa di umano, cioè i benefici ricevuti da Dio. Ma il dono della Pietà è misurato con qualcosa di divino: esso rende onore a Dio che è degno di ogni onore, essendo di per Sé tutta la Sua gloria».
La virtù di religione infusa è basata in qualche modo sulla nozione di debito: noi consideriamo i benefici di Dio e cosa Gli dobbiamo per tali benefici (Cfr. Ps. 116, 12: Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato?)
Il dono della Pietà, lasciando da parte la misura di questa generosità di Dio e di ciò che Gli dobbiamo in cambio, onora e magnifica Dio per Sé stesso, che Egli ci dispensi dei beni o dei mali; spogliato di ogni altra considerazione, esso vede solo la grandezza divina in se stessa.
L’anima considera Dio come la sua eredità eterna, si unisce a Lui immediatamente, Gli rende culto e Lo venera in Sé stesso. Quest’anima onora Dio col dono della Pietà – poiché aderire a Dio è la meta verso cui tende il dono della Pietà, come dice San Tommaso – e l’onora nella buona e nella cattiva sorte.
La Beata Vergine dice nel suo Cantico: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della Sua serva».
Il motivo per cui si magnifica Dio e si esulta in Lui non è altro che la stessa grandezza di Dio in questa profondissima umiltà, piuttosto che le sublimi grazie concesse a Maria.
A quali oggetti si estende il dono della Pietà ?
L’ambito a cui si estende il dono della Pietà è innanzi tutto ciò che attiene al culto filiale di Dio: «Voi avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: “Abbà, Padre!”» (Rm. 8, 15). Noi siamo figli adottivi per la grazia e aspettiamo l’eredità della gloria.
E dal momento che nell’ordine umano la virtù che porta a onorare i genitori si chiama pietà, il dono che le corrisponde nell’ordine soprannaturale si chiama anch’esso Pietà.
Il dono della Pietà si estende anche a tutte le creature con le quali l’anima può comunicare nella grazia – cosa che non fa la virtù di religione. La Pietà considera nei genitori il fatto stesso che essi sono fonte ed origine, e porta a venerare il padre in quanto egli ha la dignità di principio. E’ per questo che ovunque si trovi questo carattere di origine, deve essere esercitata la Pietà.
Con la Pietà noi onoriamo non solo i genitori, ma tutti quelli dello stesso sangue, ciò che riguarda il carattere di origine e di generazione. Da cui consegue che il dono della Pietà esige che venga esteso agli uomini in quanto sono figli di Dio, in forza dell’immensità della Sua gloria.
Ora, la gloria di Dio deve essere considerata non solo in quanto è comunicata ai figli di Dio, resi partecipi della natura divina; appartiene alla grandezza del Padre, autore della grazia, condurre alla gloria un gran numero dei suoi figli. Ora, le creature spirituali, salvo i dannati, sono figli di Dio o possono diventarlo: per questo il dono della Pietà si estende a tutte queste creature.
il dono della fortezza
La considerazione di questo dono è una buona occasione per ri-scoprire che Gesù Cristo, nostro Salvatore e nostro modello, ha posseduto tutti doni dello Spirito Santo e li ha usati, così come possedeva in maniera personale la grazia divina nella Sua anima umana.
La Fortezza è una certa fermezza d’animo per affrontare o sopportare dei grandi mali. Ora, le forze umane sono molto limitate e fragili, soprattutto per perseverare nella lotta e superare tutti i percoli di questa vita, specialmente per pervenire al fine eterno, che presuppone che abbiamo trionfato su tutti i mali. Per tutto questo, non basta la comune virtù della forza.
La virtù cardinale della fortezza procede secondo il modo limitato proprio dell’uomo, presupponendo che gli aiuti divini siano ricevuti e limitati secondo tale modo.
Ma il dono della Fortezza è talmente rivestito della virtù dall’alto che fa sua, per così dire, la potenza di Dio; respingendo ogni infermità naturale, esso opera con la sola virtù della divinità.
In tal modo, la virtù e il dono della Fortezza differiscono al pari della fortezza umana e della Fortezza divina. Il dono della Fortezza perfeziona e aiuta la virtù laddove essa potrebbe fallire.
Certo, la virtù della Fortezza può affrontare anche la morte, in ragione del fine soprannaturale e con l’aiuto soprannaturale. Tuttavia, nel soggetto operante essa affronta le prove più terribili con una certa limitatezza e un certo tremore.
Ed è proprio questa limitatezza e questo tremore che il dono della Fortezza elimina; perché esso opera tramite la mozione e l’ispirazione dello Spirito Santo, rivestendoci della virtù dall’alto, di modo che con questo dono noi agiamo come poggiati sulla pietra irremovibile.
Il dono della Fortezza ci predispone verso le opere ardue in maniera tale che rafforza la limitatezza del soggetto per virtù dello Spirito Santo che assiste l’anima.
E’ così che Gesù Cristo ha inizialmente tremato nella Sua Passione, mostrando la limitatezza della natura umana con la virtù della Fortezza che procedeva secondo il modo umano – compatibile con questi tremori; ma, essendo ricorso a Dio, è subito tornato alla Sua perfetta fermezza, per l’operazione del dono e della forza divine.
L’ispirazione e la mozione dello Spirito Santo, sulle quali poggia il dono della Fortezza come sulla sua ragione formale, consistono in una nuova costanza e in una nuova fermezza dell’anima, prodotte dallo Spirito Santo, che rende l’uomo capace di superare qualsiasi difficoltà.
A quali oggetti si estende la virtù della Fortezza?
San Tommaso, nel Commento alle Sentenze dice espressamente che: «Benché il dono della Fortezza riguardi soprattutto le opere più ardue, esso si estende anche alle altre difficoltà alle quali si applica generalmente la virtù della Fortezza, ma non allo stesso modo, (…)
Il dono della Fortezza si estende a tutte le difficoltà che possono incontrarsi nel corso della vita umana».
Ma sebbene il dono della Fortezza possa correggere ogni limitatezza del soggetto, non significa che esso sia sempre accompagnato dall’aiuto efficace della grazia; perché, sebbene possa, se si considera la mozione dello Spirito Santo: il rafforzare ogni limitatezza, esso non lo fa sempre, a causa della debolezza e della mutevolezza della nostra volontà che le fa da ostacolo, non facendo sufficiente ricorso a Dio.
il dono del timor di Dio
San Tommaso insegna che ci sono vari timori e che non riguardano tutti il dono. Dice nel Commento alle sentenze che questa diversità deriva dal fatto che il timore è definito come la “fuga dal male”. Ora, il male è duplice: il male della colpa o del peccato, e il male della punizione. Vi è dunque un duplice timore, l’uno che fugge soprattutto dal male della punizione, l’altro dal male della colpa.
Il timore mondano fugge il male del dolore, ma questo non si può fare senza peccato: come negare la fede per paura del supplizio. Questo timore è umano e negativo. Il timore servile fugge il castigo della colpa, soprattutto il castigo eterno; evitando di commettere la colpa, evita la pena che la punisce. Questo timore è buono e contrario al timore mondano.
Per il timore filiale l’anima fugge dal peccato, non a causa della pena, ma per evitare di offendere Dio e di separarsi da Lui. Può essere imperfetto se vi è mescolata la paura della punizione e si chiama timore iniziale. È perfetto quando la carità ha scacciato ogni timore del castigo. Il timore filiale, reverenziale e casto, teme solo di offendere Dio e rimarrà in Paradiso.
Né il timore mondano, né il timore servile sono il dono del timore: il dono del timore non può essere che timore filiale perché si fonda sulla carità, riverisce Dio come Padre e teme la separazione da Lui mediante il peccato. Questo timore non differisce essenzialmente dal timore iniziale. L’anima piena di timore filiale sa quanto è grande il peccato e non può più considerare buona alcuna cosa creata.
Il dono del timore è legato da un lato alla virtù teologale della speranza, dall’altro alla temperanza. La materia del dono del timore, per quanto riguarda la temperanza, è tutto ciò che necessita di moderazione. Perché ciò che il timore fa soprattutto è trattenere l’anima, allontanarla dal male.
San Tommaso aggiunge: “il dono del timore considera principalmente Dio, che evita di offendere, e come tale corrisponde alla virtù della speranza. Ma si riferisce anche a tutte le cose che l’anima fa per evitare il peccato. Ora, l’uomo ha particolarmente bisogno del timore divino per fuggire le cose che più lo attraggono e che sono oggetto della temperanza; ecco perché il dono del timore corrisponde anche alla temperanza“.
Così, il timore, preso in tutta la sua universalità, ci porta innanzitutto a riverire Dio e a sottometterci a Lui, e a immergerci nella nostra piccolezza di fronte a questa immensa grandezza. In secondo luogo, ci porta a fuggire il male per non separarci da Dio a causa del peccato. In terzo luogo, trattiene e controlla l’anima, impedendo così l’espansione della concupiscenza.
In sintesi: il dono del timore, attraverso l’oggetto che venera e al quale è soggetto, corrisponde alla speranza teologale, e reprime la presunzione che ad essa si oppone; ma quanto alla colpa o offesa di Dio, che esso fugge ed evita, può corrispondere a qualsiasi virtù, perché conduce ad evitare ogni peccato. Ma per l’effetto che produce nell’anima corrisponde soprattutto alla temperanza.
Un bell’esempio di questo dono è dato da santa Maria Goretti, la quale, animata dal timore di Dio, preferì morire piuttosto che offenderlo.
Il casto timore, che porta l’anima a fuggire ogni male che la separerebbe da Dio e a sottomettersi a Dio come alla grandezza somma e infinita, fa scomparire ogni orgoglio, e così gli corrisponde la beatitudine dei poveri in spirito. Il timore reprime anche ogni esuberante piacere della carne, producendo così la tristezza che corrisponde alla beatitudine di quelli che piangono.