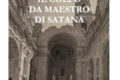fonte fides-et-ratio.it 3-4/06/2022
Autore Francesco Lamendola
Introduzione al tomismo le XXIV tesi. Le prime 7 dedicate alla metafisica. Le XXIV tesi della filosofia di san Tommaso d’Aquino opera di padre Guido Mattiussi esperto di filosofia tomista e teologo vicino San Pio X
Diversi amici ci hanno chiesto se esiste un modo semplice, ma al tempo stesso appropriato ed efficace, per accostarsi, da profani, a quella immensa cattedrale che è il pensiero filosofico di san Tommaso d’Aquino, e specialmente alle due somme: la Summa contra Gentiles e la Summa Theologiae. In sostanza ci chiedono se uno che non ha mai letto san Tommaso, o che lo ha letto fuggevolmente, magari al liceo, possa affrontarne lo studio affidandosi a una qualche guida della quale sia possibile fidarsi, come uno che non si è mai arrampicato in montagna si affida a una guida alpinistica per raggiungere una certa vetta. Dopo aver riflettuto, ci è parso che una tale guida esista e che possa fornire un valido sostegno ai principianti: si tratta dell’encomiabile lavoro fatto dal padre gesuita Guido Mattiussi (nato a Vergnacco, frazione di Reana del Rojale, in provincia di Udine, nel 1852, ma trasferitosi con la famiglia a Gemona fino all’età di dieci anni, e morto a Gorizia nel 1923), solido friulano trapiantato a Milano, che si distinse negli anni difficili della battaglia antimodernista intrapresa da san Pio X a partire dal 1907 colla pubblicazione del decreto Lamentabili sane exitu, del 3 luglio 1907, e poi dell’enciclica Pascendi Dominici gregis, l’8 settembre successivo.
Ai modernisti il pensiero di san Tommaso d’Aquino non piaceva troppo, e per indebolirne l’autorevolezza ormai consolidata (Leone XIII lo aveva raccomandato formalmente come autore della più perfetta sintesi della filosofia cristiana, con l’enciclica Aeterni Patris del 4 agosto 1879), invece di attaccarlo frontalmente, fecero leva sulle divergenze d’interpretazione che esistevano, ed erano sempre esistite, fra i suoi studiosi e ammiratori, ma anche fra i suoi detrattori, in modo da creare confusione e riaprire vecchie ferite, ad esempio le parziali condanne subite dal tomismo ad opera del vescovo di Parigi, Stefano Tempier, nel 1277, pochi anni dopo la morte dell’Aquinate, il quale era stato però canonizzato da papa Giovanni XXII nel 1323, e dichiarato Dottore della Chiesa da san Pio V nel 1567, con la bolla Mirabili Deus. San Pio X era molto preoccupato da tale situazione, che rischiava di offuscare il più solido punto di riferimento speculativo contro le mene dei modernisti, e si rivolse ad alcuni esperti di filosofia tomista affinché venisse redatta una sintesi la più fedele possibile del pensiero del Dottore Angelico. La scelta cadde infine sul padre Mattiussi, uomo aperto e coltissimo, ricco di un notevole bagaglio di esperienze d’insegnamento non solo nell’ambito della filosofia ma anche della fisica e della matematica, sia in Italia, presso l’Università Gregoriana, sia all’estero.
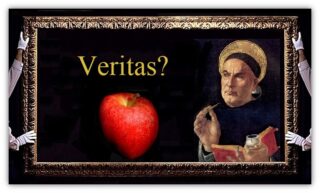
Padre Mattiussi si era già segnalato come autore di numerose pubblicazioni, fra le quali faceva spicco una che già nel titolo mostrava il suo carattere battagliero ed era destinata a dispiacere non solo alla cultura laica, allora intrisa di neokantismo, ma anche a settori di quelle cattolica: Il veleno kantiano. Nuova e antica critica della ragione, pubblicata nel 1907, nel pieno cioè dell’offensiva antimodernista del santo padre, e nel quale il bersaglio non era solo la filosofia di Kant, ma un po’ tutta la filosofia moderna, colpevole, a suo dire (e noi siamo perfettamente d’accordo con lui), di essersi allontanata dalla coincidenza tomista di essere, vero e bene. Mattiussi era un gesuita della vecchia scuola e un uomo tutto d’un pezzo, tanto che godeva di scarse simpatie fra i suoi stessi confratelli perché giudicato, come oggi (in clima neomodernista) si dice, troppo rigido o addirittura, come appare dalla voce a lui dedicata dall’Enciclopedia Treccani, un integralista; mentre essi avrebbero preferito un approccio più morbido alle posizioni degli oppositori, occulti e palesi, del tomismo; e il frutto di tale atmosfera a lui poco favorevole fu che non gli vennero mai riconosciuti i suoi meriti, indubbi e tutt’altro che modesti, di pensatore e di studioso: laddove un altro, più gradito ai settori progressisti della Chiesa, a parità di meriti avrebbe fatto certamente una ben diversa carriera accademica. Il vescovo di Milano, poi, Andrea Carlo Ferrari, occulto simpatizzante del modernismo moderato (sic), tanto fece che ne ottenne l’allontanamento dalla sua diocesi.
Dunque padre Mattiussi, fra il 1914 e il 1916, pubblicò, con l’incoraggiamento e il pieno sostegno di san Pio X (che però, come è noto, morì, forse di dolore per non aver potuto fermare la catastrofe della Prima guerra mondiale, il 20 agosto 1914), a puntate, su La Civiltà Cattolica, la sintesi che stava tanto a cuore al pontefice: Le XXIV tesi della filosofia di san Tommaso d’Aquino, opera poi raccolta in un volume e pubblicata, con l’approvazione della Sacra Congregazione degli Studi, dall’Università Gregoriana di Roma, nel 1917. A noi è sembrato che sarebbe utile, per quanti sono digiuni, o quasi, di una conoscenza diretta della filosofia di san Tommaso, patire da qui, dalla sintesi fatta da Guido Mattiussi; e pertanto dedicheremo tre o quattro articoli per esporre e commentare le 24 tesi, corredandole, una per una, di un nostro breve commento.
Ci avvaliamo, ringraziando fin d’ora, di quanto pubblicato sul sito della Società Internazionale Tommaso d’Aquino, http://www.sitaroma.com/wp/le-24-tesi-della-filosofia-di-san-tommaso/. In questa prima parte tratteremo le prime sette tesi, dedicate alla metafisica; dall’ottava alla dodicesima, si tratta della cosmologia; dalla tredicesima alla ventunesima, della psicologia razionale; le ultime tre sono dedicate alla teologia naturale.

LA METAFISICA
I. La potenza e l’atto dividono l’ente in modo tale che tutto ciò che esiste o è atto puro o è necessariamente composto di potenza e atto come di principi primi e intrinseci.
Meravigliosa semplicità, essenzialità e chiarezza espositiva. Vi sono solo due tipi di enti: quelli che hanno in stessi la potenza e l’atto, e quelli che sono atto puro. A rigore, il solo ente di questa seconda categoria è Dio. Tuttavia vi sono enti che sono formati dalla potenza e dall’agire proprio, per cui passano da se stessi dalla potenza all’atto; ed enti che ricevono l’atto, passivamente, ma non se lo danno da sé. Per fare un esempio: l’uomo può pensare una certa cosa e poi tradurla in azione, passando all’atto da sé stesso; la statua invece resterà sempre in potenza, nella materia del legno, del marmo, ecc., finché uno scultore non venga a darle una forma, traducendo in atto la potenza di cui è suscettibile.
II. L’atto, in quanto perfezione, non è limitato se non dalla potenza, che è capacità di perfezione. Quindi, nell’ordine in cui l’atto è puro, è illimitato e unico. Infatti l’atto di per sé dice solo perfezione ed esclude il limite. Se dunque ci sono enti limitati e molteplici, significa che essi sono sempre composti di potenza e atto.
L’atto è perfetto, nel senso di compiuto, realizzato. L’atto puro, cioè l’atto perfettamente realizzato, non è più delimitato da alcuna potenza, da alcuna possibilità: è così e non potrebbe essere altrimenti; nulla può esservi aggiunto o sottratto o modificato. L’atto puro è quindi sia illimitato, sia unico: se ve ne fosse più d’uno, essi si limiterebbero a vicenda. Da tale definizione risulta che il solo atto puro è Dio.
III. Nell’ordine dell’essere solo Dio è atto puro, unico e semplicissimo (cioè non composto); tutte le altre cose, che partecipano dell’essere, hanno una natura in cui l’essere è ricevuto e limitato, e sono costituite di essenza e atto d’essere (esistenza) come di principi realmente distinti.

Dio, atto puro (come per Aristotele), è una sostanza semplice: non vi è in Lui nulla di composto, proprio perché è perfetto e quindi essenziale. Negli altri enti vi è qualcosa di essenziale e qualcosa di accidentale: qualcosa che si può togliere – o aggiungere, o comunque modificare – senza tuttavia cambiarne la natura, e qualcosa che li caratterizza quanto alla loro natura, che ovviamente non può essere tolto, né aggiunto, né modificato. Inoltre negli altri enti l’essenza e l’esistenza possono essere distinti, ad esempio una casa può esistere realmente, oppure può essere solo pensata, immaginata, descritta in un racconto o una poesia, o dipinta sulla tela; mentre in Dio l’essenza e l’esistenza coincidono assolutamente, cioè non si può immaginare che in Lui vi sia l’una senza l’altra.
IV. L’ente, che viene denominato dall’essere (perché significa “ciò che ha l’essere”), non è detto univocamente (cioè nello stesso senso) di Dio e delle creature; ma neppure in senso equivoco (ossia totalmente diverso). Si dice invece in senso analogico (cioè somigliante, in parte uguale e in parte diverso), con un’analogia sia di attribuzione, sia di proporzionalità.
Sia Dio che le cose create sono enti; ma Dio è l’Ente assoluto, le altre cose sono enti relativi, i quali stanno con l’Atto puro in un rapporto di analogia e di partecipazione. Come Lui esistono; ma Lui esiste perché ha l’essere in Se medesimo, mentre le cose esistono perché partecipano dell’essere, che ricevono da altro da sé.
V. In ogni cosa creata c’è anche la reale composizione tra il soggetto sussistente (sostanza) e le perfezioni accessorie che si aggiungono, gli accidenti. La distinzione reale tra sostanza e accidenti non sarebbe possibile senza la distinzione reale fra essenza e atto d’essere (esistenza).
Le cose create sono fatte di sostanza e accidenti; Dio, Atto puro, è solo sostanza. Pertanto le cose create sono suscettibili di una maggiore o minore perfezione, quanto alle qualità che le caratterizzano: una rosa può essere più o meno rossa, più o meno fresca, più o meno profumata; un cavallo può essere più o meno veloce, ecc. Ora, il fatto che esista una tale possibilità di gradazione, e quindi una scala di perfezione, indica la natura finita degli enti: l’Ente assoluto non ha gradi di perfezione, perché, se li avesse, vi sarebbe qualche altro ente più perfetto di Lui; ma allora non sarebbe l’Ente assoluto.
VI. Oltre agli accidenti detti assoluti (come la qualità e la quantità), ci sono accidenti di “relazione” che mettono in rapporto ad altro. Sebbene queste “relazioni”, secondo la loro natura, non indichino qualcosa di inerente a qualcosa, tuttavia spesso hanno una causa nelle cose, e quindi sono un’entità reale distinta dalla sostanza.
Gli enti creati sono costituiti, oltre che dalla sostanza che è loro propria (potremmo dire dalla loro natura: quel qualcosa per cui ad un cavallo è propria la “cavallinità”, e ad uomo l’umanità), dagli accidenti, i quali a loro volta possono essere assoluti o relativi. Il corpo umano, ad esempio, dispone di due mani: due è il numero delle mani, che sono, in un certo senso, accidenti del corpo (perché il corpo umano sussiste in quanto tale anche dopo un trauma che lo abbia privato delle mani). Al tempo stesso, il fatto che il corpo abbia due mani significa che noi, osservando un corpo umano di profilo e notando, ad esempio, la sua mano destra, ci aspettiamo che possieda, sebbene non visibile in quel momento, anche la mano sinistra: infatti le due mani sono in relazione l’una con l’altra, rimandano l’una all’altra, dal momento che formano una coppia. Il fatto che formino una coppia, e che pertanto siano in relazione reciproca, non corrisponde a qualcosa che inerisce alla mano in se stessa: la mano è la mano, anche se non viene messa in relazione con l’altra.
VII. La creatura spirituale è nella sua essenza del tutto semplice, pur rimanendo in essa la composizione di essenza ed esistenza, e anche la composizione di sostanza e accidente.
Gli enti si distinguono in enti del pensiero, enti materiali ed enti spirituali. Come esempio dei primi, possiamo porre gli enti della matematica, i numeri e le figure; ai secondi appartengono tutte le creature fatte di materia. Un esempio del terzo tipo di enti, quelli spirituali, è offerto dagli Angeli. In essi, pur essendo creature spirituali e perciò semplici (indivisibili), sono compresenti qualità sostanziali e qualità accidentali, mentre l’essenza e l’esistenza in essi sono sì compresenti, ma non in maniera necessaria, perché partecipano dell’essere (che hanno ricevuto, in quanto creature) ma non hanno propriamente l’essere, il quale appartiene necessariamente solo a Dio.
LA COSMOLOGIA
VIII. Al contrario delle creature spirituali, le creature corporee non sono semplici nella loro essenza, ma composte di potenza e atto. La potenza nell’ordine dell’essenza si chiama “materia prima”, e l’atto si chiama “forma sostanziale”.
Le creature dotate di corpo, come l’uomo, sono composte di potenza e atto. La loro potenza risiede nella materia di cui sono fatte, l’atto che le rende esistenti invece è la forma. Analogamente, in una scultura la materia è il marmo, la forma è l’idea della statua che l’artista ha nella mente e che traduce in realtà. Potremmo perciò paragonare il Creatore all’artista che concepisce la sua opera e la realizza, e che dopo averla realizzata se ne compiace. E Dio vide che era cosa buona, dice l’autore del libro della Genesi: tutto ciò che è stato concepito e creato da Dio è in se stesso buono; l’imperfezione, la concupiscenza e la morte sono il frutto dell’uso perverso della libertà umana, cioè di una corruzione della natura causata dal Peccato originale.
IX. Né la materia prima né la forma sostanziale) ha l’essere, o viene prodotta, o si corrompe; e non può essere posta nei predicamenti (che sono i vari modi di dire della realtà), se non in modo riduttivo come principio sostanziale.
La materia prima e la forma sostanziale, nelle creature corporee – proprio perché non hanno l’essere, ma lo ricevono per partecipazione – non possono corrompesi e sparire nel nulla, così come non si generano dal nulla (nell’ambito del mondo naturale), ma si trasformano incessantemente in altro da sé e si scompongono nelle parti di cui sono fatte. Così anche il corpo dell’uomo si disperde, alla morte, negli elementi di cui è costituito; mentre l’anima, che è semplice, non si corrompe, ma si separa dal corpo (in attesa di ricongiungersi con esso, allorché ci sarà la resurrezione dei corpi). Anche l’anima peraltro, avendo ricevuto l’essere e non possedendolo in forma originaria, è soggetta alla volontà di altro da sé, Dio, che è l’Essere come Atto puro, senza alcuna potenza residua, e la Causa prima di tutto ciò che esiste.
X. La sostanza corporea, anche se è sempre estesa, non può tuttavia essere identificata con l’estensione, o quantità. La sostanza è infatti per sua natura fuori dell’ordine dimensivo, e quindi è indivisibile. Perciò la quantità, che dà l’estensione alla sostanza, si differenzia realmente dalla sostanza ed è un vero accidente.
Le creature corporee sono contraddistinte soprattutto dall’estensione e dalla quantità. Tuttavia né l’estensione né la quantità risolvono interamente la sostanza delle cose corporee, perché vi è, oltre ad esse, un “sostrato” rispetto al quale estensione e quantità sono accidenti o, usando una terminologia filosofica più moderna, delle qualità primarie. Anzi, poiché il numero è una variante dell’estensione (in un mucchio di sassi non è il loro numero che conta, e che oltretutto può variare senza che ciò modifichi la sua natura di “mucchio”), e l’estensione è determinata dalla quantità di materia che compone quel determinato ente, si può dire che l’estensione è l’accidente che caratterizza le sostanze corporee, ma non si identifica con la loro sostanza, bensì rimane una loro qualità, ossia un accidente. Infatti una cosa può mutare forma, accogliere (o perdere) degli oggetti senza perciò smettere di essere se stessa; una casa può essere ingrandita (o rimpicciolita), ma resta sempre la casa; e il bambino cresce e diventa adulto, ma resta pur sempre uomo, come il seme di grano diventa pianta, ma resta quel che è, grano.
XI. La materia designata dalla quantità (“signata quanti tate”) è il principio di individuazione della sostanza corporea. Nelle sostanze spirituali, ad esempio negli angeli, questo problema non si pone, poiché ogni angelo differisce dall’altro per la specie.
Il principium individuationis della sostanza corporea è dato dal fatto che essa è contrassegnata dalla quantità: se non ci fosse la quantità, non ci sarebbe sostanza corporea (anche se abbiano visto che la quantità è un accidente della materia e non coincide con essa). E dunque le cose corporee sono più grandi o più piccole, più complesse o più semplici (ma sempre composte), mentre le sostanze spirituali, come gli Angeli, non sono caratterizzate dalla quantità perché ciascuna di esse differisce dalle altre come una specie delle cose materiali differisce dall’altra. Nel mondo delle cose materiali, queste sono raggruppate in specie, e tutti gli individui che appartengono a una classe o specie sono parte di essa, pur differendo a livello individuale (quanto alla quantità, appunto); mentre nella dimensione spirituale ogni individuo, essendo formato di sostanza spirituale, che è semplice e indivisibile, è come se fosse una specie a sé stante.
XII. Quando si dice che un corpo è in un luogo si presuppone che lo spazio sia pieno (non ha senso parlare di un luogo nel vuoto); il luogo quindi è la superficie del corpo ambiente a immediato contatto con l’ente corporeo. È del tutto impossibile che un corpo occupi più di un luogo (multilocazione).
Possiamo anche dire così: in virtù della quantità un corpo occupa un luogo ed uno soltanto. Ad ogni corpo corrisponde un luogo; nessun corpo può occupare simultaneamente più luoghi. Ciò presuppone che lo spazio sia “pieno”, come è confermato dai fisici moderni (anche se non si trovano d’accordo sulla natura di tale “pienezza”), ossia che non esistano luoghi nel vuoto, il che è perfettamente ragionevole. Altrettanto ragionevole è definire un luogo come la superficie di un certo spazio che si trova a contatto con un determinato ente corporeo. Il luogo della nave è definito dallo spazio che la nave occupa, e, occupandolo, sposta un’equivalente quantità d’acqua. Infatti se un corpo non può occupare nello stesso tempo più spazi, l’acqua ove si trova la nave non può occupare lo stesso spazio che occupava prima che la nave fosse lì, ma deve necessariamente occuparne un altro, poiché anche l’acqua è un corpo.
LA PSICOLOGIA RAZIONALE
XIII. I corpi sono di due tipi: alcuni sono viventi (animati) e altri privi di vita (inanimati). Nei viventi la forma sostanziale si chiama anima. In questi enti animati c’è nel medesimo soggetto una disposizione organica, costituita di diverse parti, così che ci sia una parte movente e una parte mossa.
L’anima è la forma sostanziale degli esseri viventi (vegetativa nelle piante, sensitiva negli animali e razionale nell’uomo). L’anima è il principio della vita: dove non c’è anima, come nelle pietre, non ci può essere vita. Nelle creature viventi c’è inoltre una duplice disposizione, a muovere e ad essere mossi. Nel caso della pianta, il suo accrescimento dipende dal fatto che riceve le sostanze nutritive dal terreno, la luce e il calore dal sole, cioè da altro da sé; ma c’è anche la disposizione a germogliare, a passare dallo stadio di seme a quello di germoglio, infine a quello di pianta perfetta, e tale disposizione è interna ad essa, per cui si può dire che, sia pure sotto lo stimolo di un’azione esterna, essa è anche capace di movimento spontaneo.
XIV. Le anime dell’ordine vegetativo e sensitivo non sussistono mai per se stesse, né per se stesse vengono prodotte, ma sono soltanto il principio mediante cui il vivente esiste e vive. Queste anime dipendono in tutto dalla materia e, quando si corrompe il composto, “per accidens” (indirettamente) si corrompono anch’esse.
Piante e animali non sono dotati di un’anima sussistente: la loro anima serve solo a svolgere le funzioni vitali ed è strettamente legata al corpo, cosicché, quando il composto di anima e di corpo si scinde, le loro rispettive anime cessano di esistere. La loro funzione è quella di servire alle funzioni del corpo; ma se non c’è più un corpo da servire, l’anima vegetativa e l’anima sensitiva non hanno ragione di sussistere.
XV. Contrariamente all’anima vegetativa e sensitiva, l’anima umana, che è spirituale, sussiste per sé, e viene infusa in una materia sufficientemente disposta; viene creata da Dio e per sua natura è incorruttibile e immortale.
Diversamente da quella delle piante e degli animali, l’anima umana è spirituale, cioè sussiste anche indipendentemente dal corpo; e dunque allorché si separa dal corpo, non cessa di esistere, poiché essa non serviva solo ad aiutare il corpo a espletare le sue funzioni e a soddisfare le sue necessità. La stessa materia destinata ad accoglierla, il corpo, è stata pensata e creata dal Volere divino in vista di quella funzione ulteriore, che consiste nell’uso della ragione, da cui discendono tutte le funzioni spirituali. Dunque l’anima umana è immortale: essendo sostanza semplice, non si disperde nei suoi composti.
XVI. L’ anima razionale è unita al corpo così da essere la sua unica forma sostanziale; per essa la persona è essere umano, animale, vivente, corpo, sostanza ed ente. L’anima dunque dà all’essere umano ogni grado di perfezione essenziale; e comunica alla materia il suo stesso atto di essere.
L’anima razionale è forma sostanziale del corpo umano in maniera diversa dall’anima vegetativa delle piante e dall’anima sensitiva degli animali. Nelle piante e negli animali l’anima è semplicemente il loro rispettivo riprincipio vitale: non è immortale perché non deve svolgere alcuna funzione oltre quelle legate alla vita del corpo. L’anima dell’uomo invece, che è razionale, ha la funzione di guidare alla ricerca del vero e di sostenere lo sforzo della volontà: il fine dell’uomo infatti è conoscere il vero e servirlo. Pertanto l’anima dell’uomo sussiste anche oltre la separazione del corpo: Dio l’ha pensata e creata per un fine ultraterreno.
XVII. Dall’anima umana emanano, per naturale conseguenza, facoltà di un duplice ordine, facoltà organiche e facoltà inorganiche: le prime, alle quali appartengono anche i sensi, hanno per soggetto il composto, le seconde invece ineriscono alla sola anima. L’intelletto è dunque una facoltà intrinsecamente indipendente da un organo corporeo.
Con questa notevolissima affermazione, la filosofia di san Tommaso d’Aquino tocca uno dei suoi vertici speculativi: l’intelletto è una facoltà indipendente dal corpo; è nella mente, ma non è la mente: è, in parte, una facoltà “inorganica”, nel senso che non dipende dal corpo, non serve solamente il corpo e non finisce con il corpo. La parte dell’anima che dipende dal corpo, ad esempio i sensi, è analoga a quella che si trova negli animali. L’anima umana è dunque un composto: più precisamente, è composta quella parte dell’anima umana che è strettamente legata al corpo; mentre la parte che è indipendente da esso è una sostanza semplice, e proprio per questo non subisce la corruzione allorché si separa dal corpo.
XVIII. La radice dell’intelligibilità è l’immaterialità. Dunque, di per sé, è sommamente conoscente e conoscibile ciò che è più “libero” dalla materialità. L’oggetto adeguato di ogni intelligenza (vale a dire quella delle creature umane, degli angeli e anche di Dio) è l’ente. In particolare l’oggetto proprio dell’intelletto umano, nel presente stato di unione con il corpo, è l’essenza delle cose (la “quidditas”) astratta dalle condizioni materiali in cui si trova.
Il reale è intelligibile, cioè pensabile e comprensibile razionalmente, perché la mente è immateriale; e l’uomo, creatura razionale e spirituale, somiglia, nella sua natura essenziale, agli Angeli e a Dio, pur essendo infinitamente meno perfetto, proprio perché la sua anima è unita ad un corpo fisico (nel corso della vita terrena), che la condiziona, anche se non in modo essenziale. Se lo condizionasse in modo essenziale, l’uomo sarebbe nella stessa condizione dell’animale e della pianta: la sua anima gli servirebbe solo a soddisfare i suoi bisogni naturali. L’uomo invece ha anche dei bisogni soprannaturali, e in ciò si rivela la sua natura spirituale: la sua anima razionale gli è stata infusa da Dio al preciso scopo di realizzare il suo fine specifico, mediante la ragione e la volontà, che è quello di conoscere, amare e servire il Suo creatore.
XIX. La conoscenza inizia dalle realtà sensibili. Poiché però il sensibile non è intelligibile in atto, oltre all’intelletto che intende formalmente, bisogna ammettere nell’anima una virtù attiva che astragga le specie intelligibili dalle immagini sensibili (“phantasmata”). Questa virtù attiva viene denominata “intelletto agente”.
La conoscenza dell’uomo inizia dalla realtà sensibile: nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, «nella mente non c’è nulla che non sia già inscritto nei sensi». D’altra parte il dato sensibile non conduce automaticamente al conoscere, perché, oltre alla facoltà sensitiva, è necessaria all’anima una facoltà ulteriore, che consiste nell’astrarre da ciò che il dato sensibile mostra, qualche cosa d’intelligibile, il pensiero puro. Se così non fosse, la conoscenza dell’uomo non andrebbe più in là di quella dell’animale, al quale basta conoscere quel che gli serve immediatamente per la sua esistenza materiale. Ma la conoscenza dell’uomo va ben oltre: raggruppa i dati sensoriali e li organizza secondo categorie precise e sulla base dei principi della logica, a cominciare dal principio d’identità e quello di non contraddizione. Le immagini sensibili, di per se stesse, non sarebbero altro che qualcosa di labile e contingente, quasi fantasmi delle cose reali: acquistano un significato ulteriore allorché la facoltà razionale li utilizza per andare oltre la loro immediatezza e pensare in maniera astratta, ossia per concetti.
“Intelletto agente”, o attivo, è la facoltà dell’anima razionale di esercitare un’azione combinatoria e astrattiva sul mero dato sensoriale.
XX. Mediante le specie intellettive conosciamo le essenze delle cose in modo universale; con i sensi conosciamo i singolari, che cogliamo anche con l’intelletto mediante il ritorno alle immagini; la conoscenza delle realtà spirituali è possibile mediante l’analogia.
La conoscenza sensibile ci fa conoscere le singole cose, i singoli oggetti; con l’intelletto possiamo “estrarre” da questi ciò che è accidentale (il fatto che un certo individuo sia grande o piccolo, giovane o vecchio) e ritenere ciò che invece è essenziale (ad esempio il fatto che quel tale individuo è un essere umano). Facendo un ulteriore passo avanti, l’intelletto può conoscere anche senza bisogno di riferirsi continuamente (o “ritornare”) alle immagini sensibili delle cose: può conoscere le cose invisibili, che sono l’oggetto più adeguato all’anima razionale, il che è possibile mediante l’analogia fra le cose sensibili e quelle spirituali.
XXI. La volontà segue e non precede l’intelletto: essa vuole necessariamente solo ciò che le si presenta come un bene assoluto che sazia completamente il suo appetito (il desiderio di bene); sceglie invece liberamente tra i vari beni limitati, presentati dall’intelletto, piegando l’ultimo giudizio pratico dell’intelletto verso ciò che vuole.
La filosofia di san Tommaso è fondata sulla ragion pura e non sulla ragion pratica: l’anima razionale è capace di libera scelta, ma per volere nel senso che le si addice, e non in maniera difforme dalla sua natura, deve sapere ciò che vuole e deve volere ciò che le è conforme. Perciò l’anima razionale, capace, essa sola, di astrarre dalle cose sensibili e concentrarsi sulle realtà spirituali, vuole necessariamente, ossia secondo la necessità della sua natura, non questo o quel bene, ma il bene in se stesso, il Bene assoluto. Il dramma dell’uomo è che egli è suscettibile di volere non in maniera necessaria, come accadrebbe se riconoscesse e assecondasse la sua natura razionale e spirituale, ma di volere in maniera estemporanea e capricciosa, cioè soggettiva, dei beni che gli sembrano appetibili e lo lusingano, ma non potranno mai soddisfarlo realmente, poiché sono beni limitati e sensibili. In altre parole, nell’uomo il giudizio pratico tende a prevalere sul giudizio razionale: il che lo porta a tradire la sua natura.
LA TEOLOGIA NATURALE
XXII. Che Dio esista non lo sappiamo né con un’intuizione immediata né a priori. Lo dimostriamo però con certezza a posteriori, cioè partendo dal creato, con argomentazioni che vanno dagli effetti alla causa: 1. dalle cose che si muovono, ma non possono essere il principio adeguato del loro movimento, a un primo motore immobile; 2. da una serie di cause fra loro subordinate a una prima causa incausata; 3. dalle cose corruttibili, che si rapportano ugualmente all’essere e al non essere, a un ente assolutamente necessario; 4. da cose che sono più o meno perfette nell’essere, nel vivere, nell’intendere ecc. a Colui che è sommamente intelligente, vivente, esistente; 5. dall’ordine dell’universo a un intelletto supremo che ha ordinato il creato, armonizzandolo, e lo dirige al fine.
Sono le famose cinque vie di san Tommaso per dimostrare, a filo di logica, l’esistenza di Dio, la quale non scaturisce da un’intuizione immediata né da una certezza a priori (e qui il suo pensiero diverge da quello della filosofia del senso comune, ad esempio di Antonio Livi). Diversi filosofi moderni rivendicano di aver confutato le cinque prove di san Tommaso: a noi non sembra. Che il movimento debba avere un’origine che non sia ancora movimento, bensì motore, qualcosa che muove; che il processo causale rimandi ad un Causa prima, ecc., questi non ci sembrano argomenti che si possano realmente confutare, almeno se si resta sul terreno della logica. Ad ogni modo, la ragione ci porta ad affermare che Dio c’è; ma non ci dice nulla di preciso su di Lui. Per questo è necessaria la Rivelazione.
XXIII. L’essenza divina viene adeguatamente definita come l’essere per sé sussistente. Poiché l’atto d’essere dal punto di vista metafisico è la più alta perfezione, si deve ritenere che il puro atto d’essere, Dio, sia infinito nella sua perfezione.
Dio è l’Essere, perché in Lui l’essere non è partecipato, ma auto-sussistente. La perfezione più alta di un essere consiste nel fatto di esistere (e non di venire, ad esempio, solo pensato): dunque Dio, atto puro, esiste infinitamente e perfettissimamente.
XXIV. Dio (l’Essere per sé sussistente) per la stessa purezza del suo essere si distingue da tutte le realtà finite. Da ciò si deduce: anzitutto che il mondo non è potuto esistere se non per creazione da parte di Dio; poi che la virtù creativa (che in sé riguarda prima di tutto l’ente in quanto ente) non è comunicabile nemmeno per miracolo a una natura finita; infine che nessun agente creato può influire sull’essere di qualsiasi effetto se non viene mosso dalla Causa prima
Esiste una distanza ontologica, un abisso vero e proprio, fra Creatore e creature. Dio, perfezione infinita, si riflette solo vagamente, anche se certissimamente, nella perfezione (relativa) del creato. Dunque se il mondo esiste, esiste perché Dio lo ha creato: non è neppure pensabile che esso esista indipendentemente da Lui. Pertanto la creazione del mondo da parte di Dio è assolutamente libera: Dio, atto puro, è già perfettamente commisurato a Se stesso: non aveva alcuna necessità di creare alcunché, ma lo ha fatto per sovrabbondanza di amore. Sono completamente in errore quanti, e fra essi non pochi sedicenti teologi contemporanei, affermano che Dio ha bisogno dell’uomo e che senza il mondo la sua perfezione sarebbe incompleta, perché, al contrario, l’atto della creazione è totalmente gratuito.
Bergoglio si è spinto ancora più in là: ha affermato, assurdamente, che Dio non è Dio senza l’uomo; ma prima di lui anche don Giussani, per non parlare di padre Turoldo, avevano espresso un concetto pressoché identico. Che dire? Sono affermazioni che si commentano da sé. A tanto si doveva arrivare, dacché si è estromesso il tomismo dai seminari e, di fatto, dalle facoltà teologiche, e si è lasciato che imperversassero i Rahner, i Buber, i Bultmann, i Tillich, i Küng, i Schillebeeckx, i De Lubac, i Congar, i Teilhard, i von Balthasar… Mentre sia Leone XIII che san Pio X avevano raccomandato che si studiasse il tomismo, la più perfetta forma di filosofia e teologia cristiana, per preparare dei buoni sacerdoti.