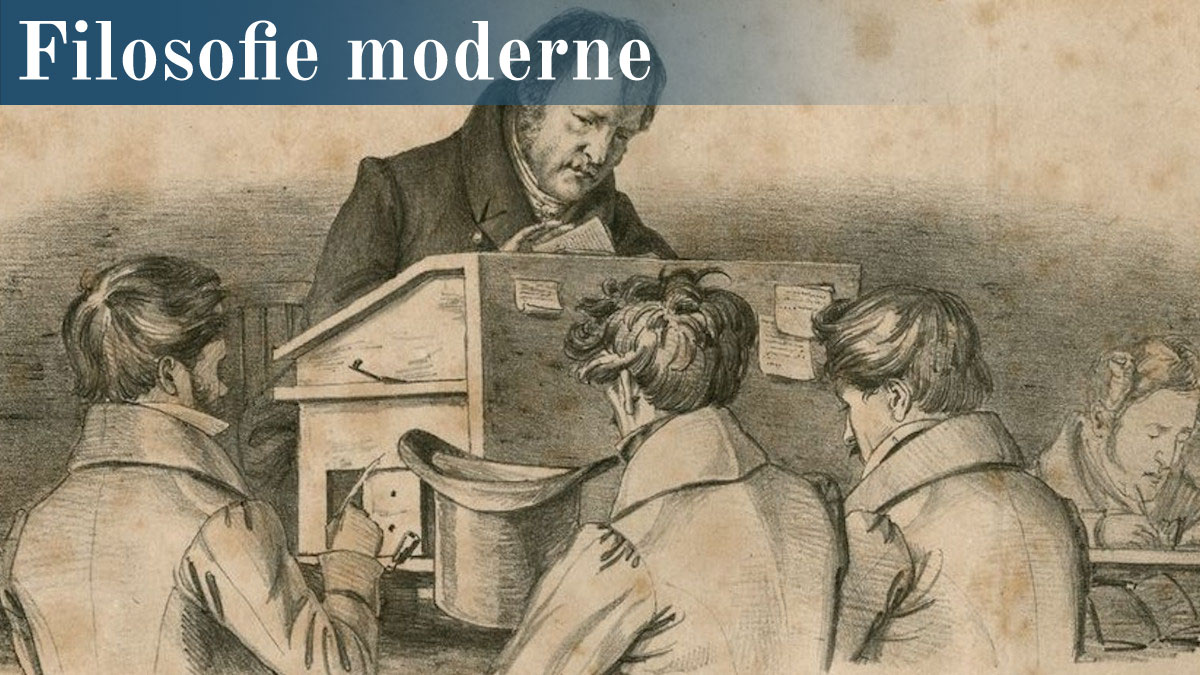L’incanto del mondo si rivela alle profondità del cuore, prima che alla mente
28 Luglio 2015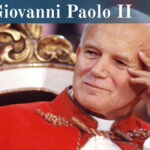
Come si spiega il rifiuto di Pio XI a esaudire la richiesta della Madonna a suor Lucia?
28 Luglio 2015Immaginatevi, per un momento, un giovanotto di buoni studi e di grande ambizione; un giovanotto, però, che non abbia nessuna voglia e nessuna intenzione di lavorare: che intenda vivere solo smerciando i frutti delle sue speculazioni astratte, sotto forma di articoli e di libri, nonché di conferenze o, magari, di lezioni universitarie.
Immaginatevi anche che questo giovanotto sia letteralmente innamorato di se stesso, che la sua anima sia piena fino all’orlo di ego, e che egli non riesca neppure a pensare alcunché, senza riferirlo a se stesso e alla "sua verità"; che si compiaccia di vedere e giudicare il mondo esclusivamente dalla finestra della sua cameretta, senza sporcarsi tropo le mani.
Tanto per cominciare, non vuol saperne di sposarsi e meno ancora di mettere al mondo dei figli: troppa responsabilità, troppe limitazioni, troppi fastidi. Poi, come si è detto, niente lavoro, niente colleghi, niente superiori, niente regole, niente "routine" borghese: tutte cose che disprezza dal profondo, in nome di un anarchismo che gli è tanto più facile e congeniale, in quanto, di solito, egli è un figlio di papà, che ha potuto studiare a arrivare all’età matura senza dover mai sobbarcarsi la minima fatica, oltre quella di fantasticare sui libri.
Immaginate che codesto giovanotto di belle speranze non creda più a niente, alla lettera, se non in se stesso e nella propria "missione" di comunicare al mondo la sua brillante scoperta: vale a dire il nichilismo assoluto; e che, per portare a buon fine tale missione, abbia deciso di sacrificare tutto ciò che potrebbe ostacolarla, ritardarla, intralciala; anzi; che abbia decretato che indugiare in qualcos’altro, nella sua vita, sarebbe "criminale", promuovendo, con ciò, la propria missione ad un ruolo sacro, e se stesso al rango di un piccolo Dio, onnisciente e onnipotente.
Immaginate ancora che codesto giovanotto faccia mostra d’essere aperto e curioso verso ogni cosa e ogni esperienza, ma che, in realtà, abbia già deciso cosa è meritevole di attenzione e d’interesse, e cosa no; in particolare, immaginatevi che scrolli le spalle non appena gli si parli di "metafisica", tanto nel senso specifico del termine, quanto in senso figurato: la metafisica, cioè la ricerca dell’essere in quanto essere, non lo interessa, né lo riguarda, lo irrita addirittura: ha ben altre cose di cui occuparsi, lui, il sacerdote dell’esistenza! Non è mica un perdigiorno come Platone, un acchiappa-nuvole come Aristotele, lui! È una persona seria, che prende sul serio le cose serie e che disprezza le cose che serie non sono. E la metafisica, una cosa seria, non lo è: questo ha deciso, invero senza darsi la briga di dimostrarlo.
Non è ancora finita. Immaginatevi, da ultimo, che questo signore, che disprezza la famiglia, la paternità e la maternità, il lavoro, la società "gerarchia", ostenti pure il massimo disdegno nei confronti degli spiriti "oziosi", ritenendosi non solo un grand’uomo, ma una persona estremamente impegnata, estremamente "calata nel sociale", e, perciò, più di chiunque altro autorizzato a parlare di problemi sociali, politici, economici: cosa che, per lui, equivale a parlare della rivoluzione, perché egli detesta ogni tipo di mediazione, e il cambiamento lo vuole radicale, tutto e subito, senza più chiacchiere o indugi: e avrete il ritratto tipico dell’intellettuale "moderno".
Voi direte che un tipo simile non può esistere, che non è nemmeno pensabile, o almeno che non è pensabile seriamente; e che, se pure esistesse, finirebbe ignorato nel gran calderone della modernità, risucchiato nel grande nulla del relativismo oggi imperante: e invece no, non solo esiste, ma ha fatto scuola; non solo ha fatto scuola, ma ha occupato quasi tutte le posizioni culturali eminenti: fa il bello e il cattivo tempo in ogni ambito della società e del pensiero, dall’urbanistica alla teologia, dalla critica d’arte, al teatro e alla letteratura, passando, ovviamente, per la filosofia, per la politica, per l’etica, per il pensiero scientifico, perfino per i salotti mondani. Ha occupato tutti gli spazi, imperversa ovunque, non è mai sazio di parlare, parlare, parlare, di dare visibilità al suo ego debordante, incontenibile, ipertrofico; di dire tutto e il contrario di tutto, secondo l’opportunità del momento (si veda quel che dicono gli intellettuali di moda, prima e dopo il 1968: sempre le stesse persone, e sempre con la stessa arroganza e con lo stesso tono apodittico), di trinciare sentenze, di lanciare scomuniche, di stroncare ogni forma di autentico pensiero critico, di lanciare guerre sante per i "diritti" (senza mai corrispettivi doveri) e contro ogni forma di "discriminazione" e di "razzismo" (tranne il loro, di cui non sembrano accorgersi neppure).
Un esempio? Fra i mille, potremmo scegliere il ritratto di Jean-Paul Sartre (Parigi, 1905- ivi, 1980), il gran padre dell’esistenzialismo, uno dei pensatori più inconsistenti e uno dei più esiziali cattivi maestri del Novecento; e potremmo farlo, con un pizzico di malizia, servendoci delle parole della sua compagna di vita e di pensiero, Simone de Beauvoir (la quale, a sua volta, è stata salutata perfino da teologi cattolici, come Jean Danielou, come una grande rivelazione del pensiero teologico: perché ad impazzire non è stato solo il pensiero laico, ma anche quello che si dice religioso); ovviamente scegliendo, per carità umana, quelle pagine in cui ella traccia un ritratto alquanto idealizzato dell’uomo col quale ha condiviso equamente innumerevoli amanti di sesso femminile, salvo poi lasciarsi prendere da un forte carica di rancore.
Così Sergio Moravia, attraverso le parole di Simone de Beauvoir, ricorda l’atteggiamento complessivo di Sartre nei confronti della sua missione di scrittore (da: S. Moravia, "Introduzione a Sartre", Bari, Laterza, 1973, pp. 7-8):
«"Viveva per scrivere". "La sua missione era di dar testimonianza di tutte le cose" (da: S. de Beauvoir, "L’età forte", Torino, 1961). Incontrando negli anni degli studi universitari (1924-29) colui che sarebbe diventato il compagno della sua vita, Simone de Beauvoir rimarrà colpita soprattutto dalla straordinaria tensione intellettuale di Sartre, dalla "passione tranquilla e forsennata" con cui egli guardava al suo "destino" di filosofo e di scrittore (cfr. Simone de Beauvoir, "Memorie d’una ragazza perbene", Torino, 1968, pp. 348-9). Il riferimento è tutt’altro che vano. Chi voglia comprendere aspetti essenziali della vita e dell’opera sartriana (anche del Sartre più maturo e vicino a noi nel tempo) non potrà non risalire agi anni della giovinezza. Vi troverà un artista per il quale l’arte si configura come il valore-dovere supremo, un filosofo persuaso che il suo compito sia quello di "esprimere il mondo", un rivoluzionario in attesa della palingenesi (senza mediazioni) della società.
"Certo non si proponeva di condurre un’esistenza d’uomo di studio; detestava le "routines" e le gerarchie, le carriere, i focolari, i diritti e di doveri, tutto il serio della vita. Non si adattava all’idea di far un mestiere, di avere dei colleghi, dei superiori, delle regole da osservare e da imporre; non sarebbe mai divenuto un padre di famiglia, e nemmeno un uomo sposato. […] Non avrebbe messo radici in nessun posto, non si sarebbe gravato di nessun possesso: non per conservarsi oziosamente disponibile ma per sperimentare tutto. Tutte le sue esperienze sarebbero andate a profitto della sua opera, e avrebbe scartato categoricamente tutte quelle che avrebbero potuto diminuirla. […] Sartre sosteneva che, quando si ha qualcosa da dire, ogni spreco è criminale. L’opera d’arte, l’opera letteraria, era per lui un fine assoluto; essa portava in sé la sua ragion d’essere, quella del suo creatore, e forse anche – questo non lo diceva, ma sospettavo lo pensasse fermamente – quella dell’intero universo. Le contese metafisiche gli facevano alzar le spalle. S’interessava alle questioni politiche e sociali, e aveva simpatia per la posizione di Nizan, ma la sua missione era scrivere, il resto veniva dopo" (ivi, p. 349).»
Vorremmo dire che questo è il perfetto ritratto di quel che un intellettuale (se proprio è necessario adoperare questo orribile termine; noi preferiremmo parlare di "uomo di cultura", oppure niente) NON dovrebbe essere. Risulta evidente, difatti, in modo perfino impietoso, che si tratta di un parassita sociale, nonché di un fanfarone e di un pericoloso seminatore di discordia.
Un uomo così, infatti, dice di cercare la verità, ma quello che cerca è la glorificazione di se stesso; e, non avendo abbastanza stoffa per diventare davvero un grand’uomo, preferisce seguire la strada più facile: quella di rimpicciolire il mondo, per far risaltare di più il proprio ego. Solo se il mondo viene dichiarato, tassativamente e irrevocabilmente, una robaccia, un simile intellettuale potrà, in qualche modo, emergere; solo se l’esistenza è assurda, lui potrà, almeno, denunciarne l’assurdità; solo se siamo destinati al nulla, a lui andrà la gloria di aver costruito qualcosa, prima che codesto nulla ci riassorba e ci seppellisca per sempre.
In fondo, si tratta di un caso psichiatrico: ma, in una società impazzita, anche i folli possono mettersi alla guida dei movimenti culturali, oltre che dei sistemi politici: ne abbiamo avuti sin troppi esempi, nella storia del secolo scorso; non c’è bisogno di fare dei nomi.
Riassumendo: l’intellettuale è colui che non lavora, né vuole lavorare, ma pontifica e sproloquia sul senso e sul valore del lavoro; che non si sposa, né vuol mettere al mondo dei figli, ma pontifica e sproloquia sul valore (anzi, sul disvalore) della famiglia e della stessa procreazione; che non vuole gerarchie, né superiori, ma che trova perfettamente naturale essere ascoltato, applaudito, riverito come un autentico "guru"; che non vuole accettare e condividere nulla, assolutamente nulla, del "serio della vita", ma che pretende di dissertare, con la massima serietà, sul significato della vita stessa; che non vuole impegnarsi in alcuna relazione stabile e definitiva, ma che si permette di affermare che "l’inferno sono gli altri". In breve, l’intellettuale è un cialtrone che pretende di vivere alle spalle della società, insultando, ridicolizzando e denigrando tutto ciò che serve a mandarla avanti, ma senza toccare neanche con un dito il più piccolo dovere, la più piccola responsabilità, tranne quelli verso se stesso, dei quali è l’unico giudice autorizzato.
In altre parole: l’intellettuale ritiene di avere una missione decisiva da svolgere nel mondo: quella di rivelare agli uomini la nuda e cruda verità; e si assolve in anticipo se non si occuperà di nulla e di nessuno, all’infuori di questo suo sacro dovere, considerando alla stregua d’un crimine qualsiasi indugio, ritardo o inciampo sulla propria strada. Peraltro, che la "verità" da lui annunciata, sia davvero la verità, lo dice lui solo, e non ha bisogno di nessun altro testimone: gli basta creare una moda, per esempio la moda dell’esistenzialismo, per raggiungere la necessaria legittimazione agli occhi della società. Gli basta, in altri termini, creare un certo clima emotivo, fatto, per esempio, di sigarette fumate con accanimento e di impermeabili sgualciti, di tante ciance sprecate nei "bistrots" in riva alla Senna, e nei crocchi studenteschi del Quartiere Latino, vagheggiando e vaneggiando sulla rivoluzione prossima ventura: ed ecco che nessuno verrà a chiedergli conto delle sue affermazioni, delle sue incoerenze, del suo parassitismo sociale e intellettuale. Perché quando si forma un nuovo paradigma culturale – non importa con quali mezzi e non importa con quanta poca razionalità e saggezza -, non c’è più bisogno di prendersi il disturbo di confutare chi la pensa diversamente: basta gettargli in faccia l’accusa di "superato", di "conservatore", o perfino ("horribile dictu!) quella di "reazionario", e il gioco è fatto. L’odioso esponente del "vecchio" sarà messo a tacere per sempre, seppellito sotto tonnellate di disprezzo e d’ironia: e l’intellettuale "progressista" e "moderno" (ma l’intellettuale, per definizione, è SEMPRE "moderno" e "progressista": nondimeno, giova ripeterlo ogni volta, come fosse una grande novità) rimarrà padrone de campo, e potrà godersi indefinitamente la deliziosa sensazione del potere intellettuale, di essere un profeta cui la storia ha dato, e continuerà a dare, ragione. In fondo, è così delizioso sentirsi, a dispetto dell’aforisma evangelico, dei profeti in patria!
Oggi, la scena della nostra "cultura" (ammesso che si possa ancora parlare di una cultura, nella nostra società) è tutta occupata da tanti piccoli Sartre (ancora più piccoli, ancora più lillipuziani di lui) e da tante piccole Simone de Beauvoir: cattive imitazioni di cattivi maestri, profeti del nulla in sedicesimo, pensatori formato tascabile, autori di libri e saggi usa-e-getta che fanno scalpore per lo spazio d’un mattino e che sono incessantemente rimpiazzati, nel mercato del consumo culturale, da nuovi "imperdibili" e "fondamentali" saggi che dopo un mese sono già dimenticati… Ironia del destino: proprio loro, i grandi accusatori del consumismo, ne sono diventati un elemento decisivo…
Fonte dell'immagine in evidenza: Wikipedia - Pubblico dominio