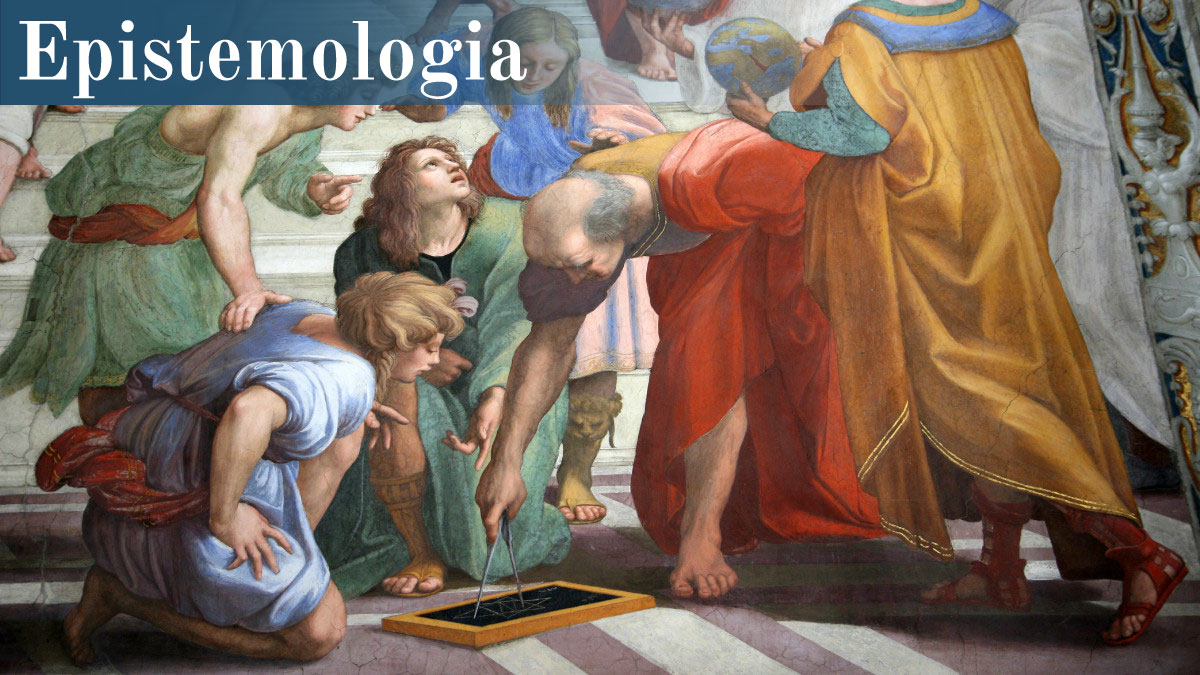Faziosità, ignoranza, ipocrisia: i tre volti del mentire
25 Luglio 2021
Gesù è mistero per credenti e no, ma in sensi diversi
27 Luglio 2021È cosa molto brutta vivere in un mondo che ritiene superfluo il concetto di verità, perché equivale a adattarsi a una condizione profondamente innaturale per l’essere umano: la consuetudine con ciò che è falso, la dimestichezza quotidiana con la menzogna o, nel migliore dei casi, con l’errore, perché un giudizio non vero sulle cose può derivare da due cause, la volontà di affermare ciò che si sa non essere vero o l’inganno di credere vero ciò che non lo è.
Le affermazioni false sono, dice Aristotele, di due tipi: o perché non esistono le cose cui si riferiscono, o perché le cose cui si riferiscono non sono così come vengono affermate. Nel primo caso si tratta, propriamente parlando, di un falso concetto: si attribuisce realtà a qualcosa che invece è irreale, perché non esiste. Affermare che esiste un anno di tredici mesi, o un giorno di venticinque ore, o un triangolo dotato di quattro lati, o due linee rette parallele che s’incontrano, equivale ad affermare la realtà di qualcosa che non esiste perché non può esistere, essendo la sua esistenza logicamente impossibile. Nel secondo tipo di affermazioni false troviamo uno storpiamento della verità: le cose di cui si parla esistono, tuttavia non sono così come vengono descritte, bensì in altro modo. Resta da vedere, naturalmente, se l’affermazione falsa in questo caso è stata fatta in buona o in cattiva fede: nel primo caso colui che l’ha fatta si è ingannato egli stesso; nel secondo non si è affatto ingannato, ma voleva ingannare.
Il caso più complicato, ma in realtà piuttosto frequente, è quello di un’affermazione falsa pronunciata allo scopo non tanto d’ingannare gli altri, ma se stessi: ciò accade quando non si ha il coraggio di assumersi la propria responsabilità e quindi si mente per proteggere la propria coscienza dal peso della colpa. Così, per fare un esempio, il casellante che si è scordato di abbassare le sbarre sulla linea ferroviaria, causando un grave incidente, può convincersi di non aver mancato in nulla ai propri doveri, e ripetere che lui aveva abbassato le sbarre e quindi che quanto è accaduto appare inspiegabile: e lo fa non tanto per essere creduto dagli altri, ma per convincere se stesso, a ciò spinto da un terribile rimorso che gl’impedisce di ammettere la propria negligenza. Il caso di colui che mente a se stesso è molto complesso e quasi irrisolvibile da un punto di vista esterno, perché gli altri possono avere bensì delle opinioni, ma non delle certezze riguardo alla volontarietà del suo mentire. Paradossalmente, l’unico che sa esattamente come stiano le cose, è proprio colui che mente: però nemmeno lui è nelle condizioni di formulare un giudizio esatto sulla propria falsità, perché è come se in lui ci fossero due personalità diverse: una che mente sapendo di mentire e una che mente non sapendo di farlo.
Torniamo perciò ai casi più frequenti: quello di chi dice, o crede, una cosa che però è falsa in se stessa, e quello di chi dice una cosa che potrebbe essere vera, però in quel determinato caso è falsa. Il primo caso è quello del navigante o dell’esploratore che si ostinano a cercare una terra, un’isola, una città, che in realtà non esistono, ma delle quali hanno sentito favoleggiare. L’affermazione che quella terra, quell’isola o quella città esistono è dunque falsa, tuttavia è necessario che qualcuno si prenda la briga di verificare come stanno in realtà le cose: perché prima di liquidare il discorso, dichiarandolo destituito di fondamento, bisogna accertarsene. In effetti, si tratta di un caso classico della logica modale: l’isola potrebbe esistere e potrebbe non esistere; la sua esistenza dunque non è assolutamente vero falsa, ma possibilmente vera o falsa. La sua esistenza dipende da un dato di fatto che, di per sé, non ha nulla d’impossibile. Altro discorso sarebbe affermare che l’isola esiste, in un tratto di mare che è stato esplorato in lungo e in largo, ed è risultato perfettamente deserto: in quel caso si tratterebbe di un’affermazione assolutamente falsa, cioè che non ha alcuna possibilità di risultare vera. Stiamo parlando, necessariamente, in maniera approssimata: perché nel mondo reale le cose raramente sono così chiare e nette come si vorrebbe che fossero discorrendo di logica, una materia per la quale le sole similitudini appropriate sono quelle tratte dalla matematica. Nel mondo reale, un mare può essere ben conosciuto e notoriamente privo di isole, e tuttavia l’isola potrebbe esserci, perché, ad esempio, emersa improvvisante a seguito di un’eruzione vulcanica sottomarina. Ci sono stati casi del genere, per cui si dovrebbe essere molto cauti prima di affermare che una certa cosa è assolutamente impossibile. Ci sono più cosa fra la terra e il cielo di quante ne possa sognare tutta la vostra filosofia, osserva Amleto ad un certo punto; e noi non possiamo che sottoscrivere questa osservazione di Shakespeare.
Scrive Aristotele nella Metafisica (V, XXIX; a cura di Armando Carlini, Bari, Editori Laterza, 1959, pp. 197-199):
Il "falso" dicesi, in un modo, come COSA che è falsa; e questo o perché la cosa non risulta così composta, o perché è impossibile che si componga così: per es., se si dica che la diagonale è commensurabile, o che tu stai seduto: di queste due, l’una è sempre falsa, l’altra talvolta. Dette così, queste cose non esistono. In altri casi, esistono bensì le cose, ma di tal natura da apparire o quali non sono, o quali non esistono: la prospettiva dipinta, ad es., e i sogni: cose, queste, che hanno bensì una loro realtà, ma non quella di cui producono in noi l’immagine. Le cose, dunque, si dicono false, in questo modo: o perché non esistono, o perché l’immagine che producono è di cosa che non esiste.
Un CONCETTO falso è quello che, in quanto falso, è di cose che non sono. Perché ogni concetto è falso se riferito a cosa diversa da quella di cui è vero: per es., il concetto del cerchio è falso del triangolo. In un senso, c’è un concetto unico di ogni cosa, quello della pura essenza; in un altro i concetti sono molti. Poiché la cosa da sé e la cosa con un’affezione è in certo modo la stessa cosa: per es., Socrate e Socrate musico. Il concetto falso, assolutamente parlando, è concetto di nulla. Perciò era abbastanza sciocca l’opinione di Antistene che di nulla si possa parlare salvo che col suo proprio concetto, unico per un’unica cosa: donde seguiva che non è possibile contraddire, e quasi neppure dir il falso. Invece, di ciascuna cosa si può parlare non soltanto il concetto di essa, ma anche cin quello di altra: anche del tutto falsamente, senza dubbio, ma anche in modo conforme a verità: l’otto, poniamo, dico ch’è doppio perché ho il concetto del due.
Queste cose, dunque, si dicono false così. Falso, poi, si dice un UOMO che abbia abilità e predilezione per simili discorsi per nessun’altra ragione che per discorrere così; e chi è capace di produrli in altri, a quel modo che diciamo false anche le cose che producono in noi immagini false. Perciò nell’Ippia" quel ragionamento, che vuol provare come uno stesso uomo è falso e vero, conduce fuori di strada: perché dà come falso chi ha la capacità di dir il falso, ch’è, poi, colui che sa ed è sapiente; e aggiunge ch’è migliore chi è cattivo volontariamente. Questa è la conseguenza di una falsa induzione: chi zoppica volontariamente è migliore di chi zoppica per forza: intendendo per zoppicare l’imitare lo zoppo; ma se uno fosse zoppo volontariamente, egli sarebbe forse peggiore, qui, come in cose riguardanti il costume [Ippia minore, 365 ss: Platone erra, dunque: a) non distinguendo la potenza dall’atto di mentire; b) reputando migliore chi erra volontariamente; per quest’ultimo punto, cfr. Et. Nich., III, 5; n.d.t.].
Un’affermazione è vera, pertanto, allorché coglie l’essenza, o il concetto, del predicato di cui parla. Se dico che la somma degli angoli di un qualsiasi triangolo è centottanta gradi, dico una cosa vera; se affermo che può essere diversa da centottanta gradi, dico una cosa assolutamente falsa, e non c’è bisogno che mi munisca di goniometro per andarla a verificare nei singoli casi. La natura umana, la struttura della nostra psiche, sono fatte per la verità, non per la falsità. La falsità esiste, ma è una manifestazione degenerativa del comportamento umano. Nessuno cerca la falsità per la falsità: neppure il mentitore di professione, perché anche’egli, a suo modo, ha ben chiaro l’obiettivo che si prefigge, e questo significa che nella sua mente esiste il concetto del vero e anch’egli, come tutti, vi si attiene, anche se poi, per delle ragioni sue, afferma il contrario di ciò che è vero. Questo ne fa un uomo falso, ma non attesta che la falsità sia realmente un modo dell’essere, caratterizzato da un proprio sistema di logica. La logica esiste in funzione del vero e non del falso; e la stessa cosa si può dire dell’uomo in generale, che egli è ordinato al vero e non già al falso, anche se poi, nella dimensione pratica, vi sono uomini che calpestano sistematicamente il vero e fanno della menzogna quasi una loro seconda natura. Rispetto al fine cui è ordinata l’esistenza umana, si tratta di vere e proprie aberrazioni: e per quanto frequenti possano essere, non potranno mai dimostrare che l’uomo è ordinato a un fine diverso dalla verità, ma solo che vi sono epoche e società talmente decadenti, da presentare come frequenti, e perfino abituali, dei comportamenti che sono in realtà patologici e intrinsecamente distruttivi. Va da sé, infatti, che se l’essere umano è ordinato al vero, un modo di vivere contrario alla verità comporta un livello crescente di disordine, disarmonia e infelicità, perché queste cose derivano dal vivere secondo il fine che è proprio di ciascuna natura.
Ora prendiamo, a titolo d’esempio, il discorso fatto dal presidente Mario Draghi il 22 luglio 2021:
L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente: non ti vaccini, ti ammali e muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi e qualcuno muore. [Perciò] senza vaccinazione, si deve chiudere tutto.
Vediamo. L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente: non ti vaccini, ti ammali e muori. Queste sono affermazioni false: non è vero che l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, perché i dati statistici non dicono questo, ma tutt’altro; non è vero che chi non si vaccina si ammala, non più di quanto si possa ammalare anche chi si è vaccinato; e soprattutto non è vero che chi non si è vaccinato si ammala e muore, perché non c’è alcun dato di fatto che avvalori una così grave affermazione. Inoltre non si fa alcuna distinzione fra l’essere contagiati, l’essere cioè positivi al virus, e l’essere ammalati, mentre sono due cose totalmente diverse. La maggior parte delle persone sono o sono state contagiate e quindi sono o sono state positive al virus, ma non si sono ammalate, anzi, solo una percentuale piccolissima si è ammalata, e una percentuale ancor più piccola, quasi infinitesimale (qualcosa come lo 0,025) con esito fatale, oltretutto in presenza di gravi patologie pregresse, cui si è aggiunto il Covid-19. Insomma, una serie incredibile di affermazioni non vere, anche se fatte con la massima sicumera e la massima sfacciataggine, al solo scopo d’impaurire, disorientare, colpevolizzare e manipolare la gente, inducendola a vaccinarsi. Ultima falsità: il cosiddetto vaccino non è affatto un vaccino, ma un’altra cosa e ben diversa; è un siero genico in fase di sperimentazione, dunque colui che se lo fa inoculare funge da cavia di un gigantesco esperimento spacciato come soluzione del problema, mentre qualunque medico serio sa che le malattie si sconfiggono con le cure e non con le vaccinazioni preventive, tanto più se sperimentali. E si aggiunga che molte persone sono morte proprio per aver fatto il vaccino, o hanno subito danni gravi e permanenti: come si può tacere una cosa del genere, nel momento in cui un presidente del Consiglio sente il dovere "morale" di spronare i propri concittadini a correre a vaccinarsi? Se perfino un venditore di auto usate verrebbe considerato un emerito truffatore, qualora non dicesse all’acquirente che l’automobile che sta acquistando ha quel tale difetto, cosa pensare di uno statista dalle cui parole e dalle cui azioni dipendono la salute e, in questo caso, la vita o la morte di tantissime persone? Ma non basta: Draghi ha detto ancora: Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi e qualcuno muore. Anche questa affermazione è totalmente falsa. Non solo non è vero che il non vaccinato è, in quanto non vaccinato, pericoloso per gli altri, addirittura pericoloso al punto da causarne la morte se viene a contatto con essi; anche qui senza distinguere il sieropositivo asintomatico, che non è pericoloso per alcuno, da quello sintomatico, che potrebbe esserlo, certo, ma non più di quanto può esserlo il vaccinato. Semmai è vero il contrario: che il vaccinato, essendosi fatto inoculare il virus (come, nessuno lo sa: dal momento che il virus non è mai stato isolato) rappresenta oggettivamene un pericolo per il non vaccinato, in quanto è in condizione di trasmetterglielo. Ma è evidente che lo scopo di questa falsa asserzione è quello di creare lancinanti sensi di colpa nelle persone, specie nei riguardi dei loro familiari e soprattutto dei loro genitori anziani. Ciliegina sulla torta: senza vaccinazione, si deve chiudere tutto. Questa è l’ultima falsità, e probabilmente la più grave di tutte. La frase andrebbe così rovesciata: poiché noi abbiamo deciso di chiudere tutto, non certo nell’interesse dell’Italia, allora dobbiamo imporre la vaccinazione di massa. Ecco, messa così la frase acquista un significato. Non è vero, signor Draghi?
Fonte dell'immagine in evidenza: sconosciuta, contattare gli amministratori per chiedere l'attribuzione