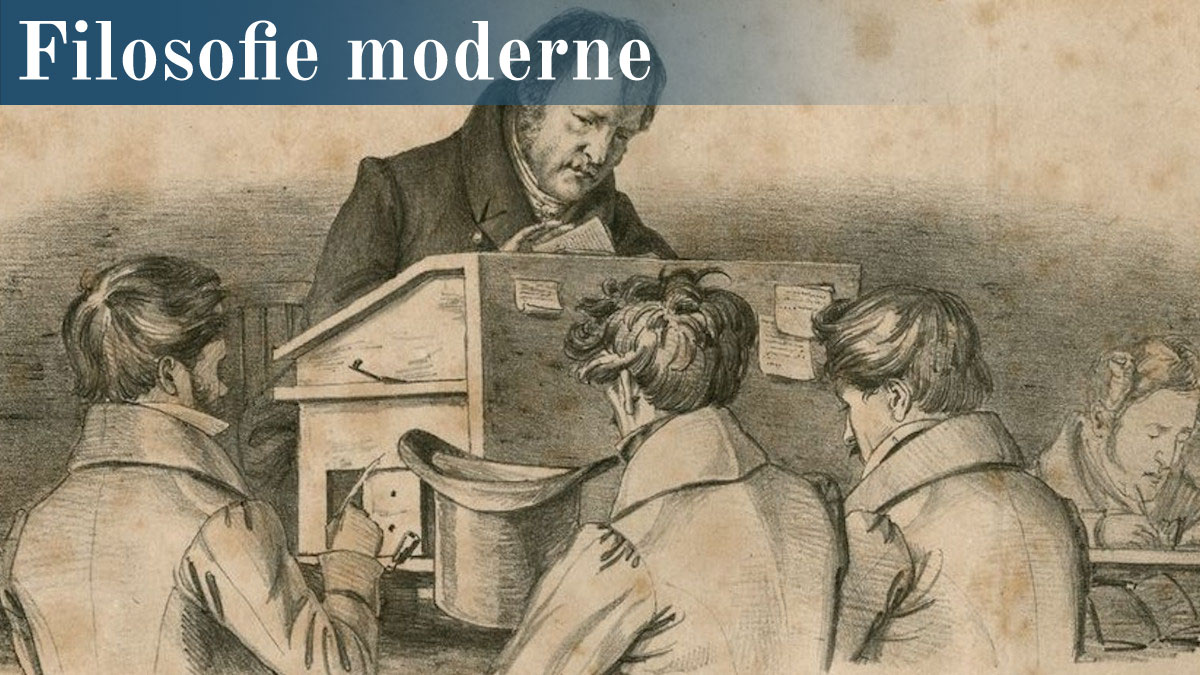Errore o peccato?
19 Dicembre 2018
Omaggio alle chiese natie: S. Caterina d’Alessandria
20 Dicembre 2018Louis Althusser (1918-1990) è stata considerato, già in vita, uno dei massimi filosofi francesi ed europei del XX secolo; il massimo interprete del marxismo-leninismo; il massimo maestro della gioventù universitaria parigina. La sua popolarità è stata immensa, la sua autorevolezza indiscussa. I suoi seguaci, ammiratori, fiancheggiatori e continuatori sono stati legione: da Michel Foucault a Bernard Henry-Lévy, da Roland Barthes a Pierre Klossowski, da Gilles Deleuze a Jacques Derrida. Gli studenti, in particolare, andavano in visibilio per lui, si contendevano ogni suo pensiero, ne facevano oggetto d’interminabili discussioni. Le sue lezioni erano affollatissime, attesissime, vissute con trepidazione inimmaginabile. Solo che all’università ci andava poco. Teneva pochissime lezioni, e in quelle poche parlava ancora meno. Non ha mai tenuto un corso completo e regolare. Ha scritto anche poco: praticamente, nessun vero libro. Il suo libro più famoso, che è stato subito un caso letterario, Pour Marx, è una raccolta di articoli. Era un maestro muto: lo adoravano senza bisogno che parlasse. Nemmeno a tu per tu, nei corridoi, nei bistrot o a casa sua. Non parlava e probabilmente non ascoltava neppure. Per una ragione molto semplice: era pazzo. Pazzo da legare, pazzo pericoloso. Vorremmo parlare con la necessaria pietà della sua malattia, ma non possiamo ignorare che lui e i suoi amici, lui e i suoi colleghi, avevano diffuso la strana leggenda che la follia è una diabolica invenzione della classe borghese per imbavagliare il dissenso: è la teoria di Michel Foucault, uno dei suoi amici-discepoli più intimi. E non possiamo ignorare che questa leggenda ha fatto una quantità di vittime, vittime reali, in carne e ossa, non vittime metaforiche. Fino al tragico epilogo della sua stessa follia: quando, il 16 novembre 1980, strangolò con le sue mani la moglie, Hélène Rytmann, omicidio da lui stesso immediatamente confessato, per poi cavarsela con un non luogo a procedere che gli evitò non solo la condanna, ma perfino il processo. Cose che capitano agli intellettuali di sinistra. Per lui si mobilitarono tutti, ai più alti livelli. Spuntarono amici, pensatori e politici autorevoli, i quali, in coro, chiesero che non si esponesse all’onta del processo un così grand’uomo, un così insigne maestro. Anche il filosofo Jean Guitton si spese per lui: a nome di tutti i cattolici progressisti, Guitton aveva una vivissima simpatia per Althusser e ha contribuito a dipingerlo in maniera fantastica, come un uomo a suo modo molto, molto religioso, circostanza smentita da altri che lo conobbero assai più e assai meglio, come Bernanrd-Henry Lévy. Ma tant’è: Althusser era Althusser, mica un tanghero qualsiasi. Era giusto che la gauche si mobilitasse in sua difesa, e il cattolicesimo di sinistra pure. Così la pazzia, che secondo la cultura da lui promossa non esisteva neppure, lo salvò dal disonore del tribunale.
Una delicatezza che gli intellettuali progressisti non ebbero nei confronti di un grandissimo intellettuale, che pazzo non era per niente, anzi estremamente lucido, il poeta americano Ezra Pound, ma che venne condannato dalle autorità del suo Paese a dodici anni di manicomio criminale, proprio per evitargli la forca o il plotone d’esecuzione. La sua colpa? Essere un intellettuale di destra; aver preso le parti del fascismo italiano; aver fatto propaganda per l’Italia di Mussolini durante la Seconda guerra mondiale. E prima di essere condannato al manicomio criminale, lo avevano chiuso, per molti giorni, in una gabbia di ferro, aperta al sole e alla pioggia, tipo Guantanamo, come una bestia feroce: doveva ben scontare la follia di aver denunciato l’usura, cioè la plutocrazia usuraia che stava gettando i suoi tentacoli sul mondo, perché il "fascismo" di Pound ebbe sempre questa finalità: mettere in guardia contro la congiura mondiale delle banche, della finanza che succhia il sangue dei popoli e della gente che lavora onestamente, produce e risparmia. Ma Altuhusser, vuoi mettere! Altuhusser interpretava Marx: e in effetti, non si riesce a trovare un solo pensiero originale in tutta la sua filosofia. Il suo concetto-chiave, "sovradeterminazione", lo prede in prestito dalla psicoanalisi. Se si dovesse sintetizzare il suo pensiero, non si saprebbe dire un granché. Era un pensiero marxista duro e puro, che insisteva sulla assoluta "scientificità" di Marx, contro tutti gli idealismi e gli umanismi. Per lui, Marx era un grande filosofo e un grande scienziato: in un certo senso, la leggenda di Marx grande filosofo-scienziato, fiorita sui banchi dei licei e delle università d’Europa, anche italiani, negli anni ’70 e ’80 del Novecento, e mai più emendata, si deve in gran pare a lui. Specialmente al suo Per Marx, che è del 1965. Si faccia attenzione al momento storico: c’era stato il XX Congresso del PCUS, c’era stata la denuncia, da parte di Kruscev, dei crimini di Stalin. C’era stata l’Ungheria, che a fatica era stata presentata, ai Partiti comunisti occidentali, come la repressione di una insurrezione fascista. Ora c’era bisogno di un ricostituente, meglio ancora di una riforma del marxismo; ma non nel senso di una sua attenuazione, di un suo ammorbidimento, bensì di un suo irrigidimento. Il marxismo funzionava quando veniva interpretato correttamente, così come il "secondo Marx" – questa la diagnosi di Althusser – lo aveva pensato: una fredda lama con cui incidere la cancrena della società borghese. E per quella purezza quasi ascetica Althusser era diventato famoso: era l’uomo che la cultura di sinistra, in debito di ossigeno, disperatamente cercava. C’era bisogno di uno come lui. Dopo Sartre, chi avrebbe preso la guida ideale della gauche, chi avrebbe indicato al popolo comunista le magnifiche sorti e progressive? Ed ecco spiegato il successo formidabile di Althusser: di un "maestro" che non teneva lezione, che non scriveva libri, che non parlava, che non ascoltava, che vaneggiava: come quando si slacciò le scarpe e le sbatté sul tavolo, per imitare Kruscev: una scena talmente penosa, quasi raccapricciante, che i suoi amici più cari, che lo conoscevano bene, scoppiarono a piangere. Ma la sua fortuna era che il popolo di sinistra che lo adorava, non assistette mai a simili scene: lo vide sempre avvolto da un’aura sacrale. I suoi silenzi parevano sublimi, il segno di una profondità abissale, di una pensosità ciclopica. Invece era semplicemente pazzo. Eppure lo hanno seguito, ciecamente lo hanno amato, lo hanno adorato: erano pronti a giurare su ogni sua parola, a immolarsi per diffondere le sue idee. Lo hanno seguito col fanatismo e la cecità con i quali i nazisti hanno seguito Hitler. Paragone scomodo, non è vero?, ma è un paragone onesto. In entrambi casi, la cecità volontaria di chi non vuol vedere, non vuol sapere, non vuol capire. Di chi si rifiuta di fare due più due. Di chi è troppo pigro per pensare con la propria testa; anzi, di chi è troppo pigro perfino per pensare con la testa di un altro. Marx? Ma quanti studenti della gauche si son mai dati il disturbo di leggere veramente Il Capitale? Althusser, allora? Ma Althusser scriveva poco, quasi niente: molti titoli, pochissima sostanza. Eppure, bastava e avanzava: per le zucche vuote del Quartiere Latino, si capisce. Ma quelli erano gli anni delle zucche vuote, appunto; era la stagione della stupidità, pardon, della fantasia, al potere. Erano gli anni prima, durante e dopo il ’68, quando ogni imbecille si credeva un Aristotele solo perché aveva sempre in bocca Marx e Althusser.
Così scrive, senza troppo imbarazzo, il suo principale discepolo, Bernard-Henry Lévy, in Le avventure della libertà (titolo originale: Les aventures de la liberté, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1991; trad. dal francese di Annabianca Mazzoni, Milano, Rizzoli, 1992, pp. 358-361):
Althusser. Le lezioni di Althusser. Chi, nella mia generazione, può realmente vantarsi di aver seguito una lezione di Althusser? La generazione di una volta, sia. I Balibar. I Rancière. Tutti quegli althusseriani di prima qualità che sono "capitati" in un anno in cui egli stava meglio e, miracolosamente, teneva un corso. E poi, corso… Lo si poteva forse chiamare corso? Una seduta… Due, forse? Un seminario collettivo della durata di un’ora… E poi, niente… Il silenzio… La strana prostrazione in cui ha ritrovato la mia generazione… Althusser era un maestro che non insegnava. Un professore che non teneva corsi. Contrariamente a quanto accade sempre — una parola, non una richiesta — la richiesta c’era, ma era la parola che mancava. Eravamo migliaia e migliaia di althusseriani. Aspettavamo. Spiavamo. Speculavamo all’infinito sulle posizioni che avrebbe o non avrebbe preso. Una parola scatenava le nostre discussioni. Una parola scatenava le nostre discussioni. Un frammento, la nostra felicità. Quando, per caso, qualcuno di noi ritrovava su una vecchia rivista un suo articolo sconosciuto, era una festa! Fotocopie a oltranza! Ce lo rifilavamo come un "samizdat"! Lo veneravamo come una reliquia! Ma per quanto riguarda i corsi, dei veri corsi, quelle lezioni che annunciava, in principio, all’inizio di ogni anno — non era forse, dopo tutto, il nostro "caïman" di filosofia? — non se ne faceva mai niente: regolarmente l’anno si chiudeva senza che il corso avesse preso avvio. Ho trascorso quattro anni all’École Normale. Non ho mai sentito parlare il mio professore. I suoi libri, allora? è ai suoi libri che occorre volgerci per trovare le sue lezioni? Proveniva dai libri la sua influenza? Sì e no. Perché non ci sono nemmeno dei libri di Althusser. Ci sono dei titoli, questo sì. Tantissimi titoli. Era un "titolatore" geniale. Un recordman della titolatura. Era ineguagliabile nell’idearvi un titolo fiammeggiante che ostentava poi come un vessillo. Ma quando si guardava dietro il vessillo, quando osservi, ancora oggi, ciò che sono fisicamente i suoi libri, troviamo una raccolta di articoli ("Per Marx"), un testo di circostanza ("Lenin e la filosofia"), un articolo "gonfiato", come dicono gli editori, per ricavarne un opuscolo ("Réponse a John Lewis"). Troviamo "Leggere il Capitale", il titolo principale, in realtà un libro collettivo; anzi, se vi togliamo i testi dei seguaci, non ne resta che qualche scarna conferenza. Mentre un libro, ciò che si definisce un libro, con un inizio, una fine, un’architettura interna, un’idea su cui poggiare, per contro non esiste. Non che si sia rifiutato di crearlo, del resto. O che l’idea gli ripugnasse. Semplicemente, non era il momento. (…) Un pensiero in movimento, allora? In gestazione? Uno di quei pensieri vivi e forti che non si curano dei sistemi, e filano dritti verso l’infinito? Hmm… Ma non è detto… Perché ciò che contrassegnava l’opera di Althusser era la stabilità. Era un’opera quasi fissa. Come se la malattia l’avesse arrestata, bloccata nel suo slancio, impossibilitata a spiegarsi. (…) Una presenza? Una parola? È attraverso la parola viva che egli regnava? Attraverso il contatto diretto con ciascuno? Una sorta di Socrate? Oppure — il confronto è stato più volte fatto — una sorta di Lucien Herr moderno? Nemmeno questo è certo. Perché Lucien Herr parlava. Perorava. Ha passato ore a convincere Jaurès, Blum, Péguy, dell’innocenza di Dreyfus o dei meriti del socialismo. Mentre Althusser, quando andavate a fargli visita, aveva la parola tanto rara quanto la scrittura. Bussate alla porta. Apre immediatamente. Apre sempre velocemente, come se fosse là, dietro la porta imbottita di cuoio, ad attendere solo voi. Una breve stretta di mano. Il primo sguardo, insistente, un po’ obliquo, pieno di sottintesi. Indossa un paio di pantaloni di velluto a coste. Una camicia di lana. Ha il passo pesante, l’espressione preoccupata di chi è stato interrotto dal proprio lavoro, ma con un urgente bisogno di vedervi. "Scusa. Disturbo? "Sì, stavo scrivendo… Ma entra, su… Capiti a proposito…". Senza una parola, vi indica la poltrona di sinistra. Lui si siede in quella di destra. Sembra un vecchio cospiratore che si esprime con gesti brevi, cenni del capo, smorfie. Allora voi parlate. Del resto siete costretti a parlare, altrimenti regnerebbe il silenzio. E per tutto il tempo del "colloquio", egli resta lì, rannicchiato nella sua poltrona, sognante; vi fossa senza proferir parola, con quel suo bello sguardo azzurro, terribilmente intenso. Chissà se ascolta, perlomeno? È così attento come fa pensare la sua espressione? Voi ne siete convinti, certamente. Altrimenti, perché quella scena? Perché quell’aria di chi la sa lunga? La fronte pensierosa? L’occhio azzurro? Quindi voi cominciate. Farfugliate un po’. Siete intimiditi, per forza, da quello sguardo che vi scruta e che è quello, non dimentichiamolo, del teorico marxista più puro della terra… Ahi, ahi, ahi! Vi ingannate… non siete abbastanza puri… abbastanza ortodossi… penserà che non avete capito niente della ‘rottura’ o della differenza tra materialismo storico e dialettico… Vi troverà frivoli, mondani… dirà: ma no, ma chi è questo? Non ha proprio una faccia da althusseriano. (…) Althusser, in quei momenti, non esprimeva niente di speciale. Se ne fregava totalmente della vostra eventuale eresia. Come poteva curarsene quando il suo unico pensiero era che, tempo un’ora, per discrezione, ve ne sareste andati, lasciandolo nuovamente solo — con la sua infelicità e la sua malattia? Allora, lo sapevamo? Ce ne accorgevamo? Ci dicevamo, tra di noi: Il nostro maestro è malato… il nostro professore è folle?
E la risposta a queste ultime domande, ambigua, sembra essere comunque un no. Perché se fosse stata sì, perfino quelle zucche vuote avrebbero dovuto porsi la domanda: Ma se il nostro maestro è un folle, noi allora cosa siamo? Eppure, quanto bene avrebbe fatto loro chiederselo: da quella mancata domanda sono derivati molti mali. Il più grave dei quali è che costoro, dopo aver seguito dei pazzi, non avendo fatto ammenda né chiarezza in se stessi sulle ragioni di quella infatuazione, continuano a diffondere i germi della pazzia: così, solo perché non sanno come ammazzare la noia…
Fonte dell'immagine in evidenza: Wikipedia - Pubblico dominio