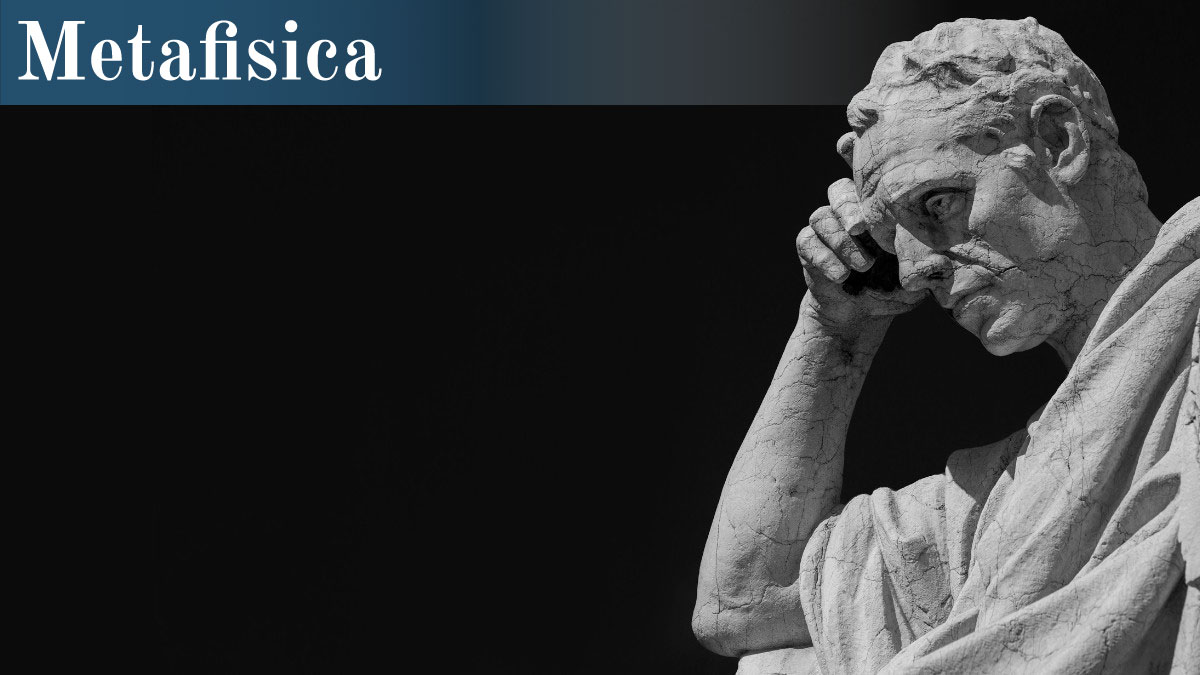Incapace di pensare l’essere, l’uomo moderno vaga da un’illusione all’altra
13 Agosto 2017
Right or wrong, my country…
14 Agosto 2017L’uomo moderno ha smesso di credere in Dio: tutta la cosiddetta civiltà moderna non è altro che una rivolta contro Dio e una esclusione di Dio, sia dal piano della coscienza individuale, sia dal piano della storia, e quindi della politica, dell’economia, dell’arte, della scienza, eccetera. Ma come è nato tutto questo? Come è accaduto che l’uomo, a un certo punto, ha smesso di credere? Meglio ancora: come è accaduto che egli ha trovato impossibile credere? Da dove hanno origine la sua ripugnanza nei confronti dell’idea di Dio, il suo sottile fastidio, la sua segreta irritazione, quando gli si parla di Dio? E come mai l’uomo ha potuto credere in Dio — non solo l’uomo comune, l’uomo lavoratore, l’uomo ignorante – ma anche il più raffinato intellettuale – ha potuto crederci per moltissime generazioni, per secoli e secoli, senza alcuna particolare difficoltà, conciliando perfettamente la fede e la ragione?
A livello razionale, l’uomo moderno risponde a quest’ultima domanda dicendo che l’uomo medievale, l’uomo della società pre-moderna, l’uomo comune, hanno potuto credere, perché ne avevano bisogno e perché non avevamo altro modo di spiegare il mondo; inoltre, che hanno potuto conciliare la fede e la ragione solo perché quest’ultima, allora, era ben poco sviluppata, e specialmente il senso critico era quasi del tutto assente. Tuttavia, non ci vuole un grande sforzo per comprendere che si tratta di spiegazioni decisamente insufficienti. Partiamo dall’ultima affermazione: che la ragione, nella società pre-moderna, è poco sviluppata. Si tratta di una opinione assolutamente gratuita; peggio: di una deliberata falsificazione operata dai seguaci del paradigma della modernità ai danni del paradigma precedente, che potremmo chiamare il paradigma cristiano. Innanzitutto, il Medioevo è stato una grande età della ragione: basterebbe, da sola, l’opera speculativa di san Tommaso d’Aquino, questo gigante delle due discipline reali, la filosofia e la teologia, per smentire la leggenda di un Medioevo intellettualmente rozzo e primitivo, nonché superstizioso e oscurantista. Ma, si dirà, una rondine non fa primavera; e la Summa theologiae di Tommaso s’innalza come la classica cattedrale nel deserto dell’ignoranza e della credulità generali. Nemmeno questo è vero, in realtà: ci sono molte altre menti geniali, nella civiltà medievale, a cominciare da quella di Dante — una mente filosofica e non solo un genio poetico. Ma il punto non è questo. Il punto è che il paradigma cristiano abbraccia il Medioevo e raggiunge, in esso, i suoi vertici di splendore, ma prosegue ben oltre: infatti sopravviveva, e sia pure relegato ormai nelle campagne, fino all’avvento della piena modernità, fenomeno questo che si svolge, nelle diverse parti d’Europa, tra la fine del XIX secolo e la seconda metà del XX. In alcune parti d’Europa, particolarmente isolate, sta arrivando solo adesso (pensiamo a certe zone dei Balcani, per esempio) e, fuori d’Europa, è giunto quasi solo nelle città, anzi, nelle grandi città, che ne sono il bacino di raccolta, per poi diramarsi, ma assai lentamente, nelle città minori, nei paesi e nelle campagne. In Egitto, la modernità è arrivata solo al Cairo; lungo la valle del Nilo sta cominciando appena ad affacciarsi, molto timidamente; nel le oasi del deserto, si può dire che non sia mai arrivata affatto. Nel caso dell’Italia, la piena modernità è arrivata con il miracolo economico degli anni ’50 del Novecento; un po’ più tardi nel Nord-Est, e solo più tardi ancora, ma come fenomeno d’imitazione puramente esteriore, nelle regioni del centro-sud e nelle isole. In Friuli, per esempio, la piena modernità è arrivata solo nel corso degli anni ’70; fino a tutti gli anni ’60, la vecchia cultura contadina, il vecchio paradigma cristiano e pre-moderno, sono sopravvissuti fianco a fianco con i nuovi modi di vivere e di pensare che erano, sostanzialmente un riflesso dello stile di vita americano. Gli Stati Uniti hanno conquistato il mondo con le due guerre mondiali, definitivamente solo con la Seconda; e solo da allora la piena modernità è stata imposta al nostro continente; mentre in Asia, in Africa e nell’America latina sarebbe giunta dopo o non sarebbe giunta affatto, se non nelle sue forme più esteriori, parassitarie e nocive. Ebbene, tornando alla nostra realtà: fino a tutti gli anni ’60, come noi abbiamo visto e possiamo testimoniare in prima persona, il modo di vivere, di sentire, di pensare, di vestire, di lavorare, di giocare, di passare il tempo libero, da parte delle persone, era ancora in equilibrio fra il vecchio e il nuovo paradigma; e, in quel contesto, le persone colte, fornite di laurea, gli intellettuali di professione, non tutte, ma molte, erano ancora perfettamente capaci di conciliare la vecchia fede, la fede in Dio, la pratica devozionale cristiana e cattolica, con le loro conoscenze di greco, di latino, di filosofia, di letteratura, di chimica, di fisica, di matematica, proprio come ne erano state capaci le generazioni precedenti; proprio come ne erano stati capaci sant’Agostino, san Tommaso, Dante, Giotto. Oggi, gli intellettuali danno quasi per scontato che non si possa credere, che non si debba credere, perché credere in Dio, credere in Gesù Cristo, nella Madonna e nei santi, nei miracoli e nel soprannaturale, nel giudizio delle anime e nella vita dopo la morte, sarebbe un tradimento nei confronti della ragione. Ma fino a cinquant’anni fa, nessuno, o molto pochi, avevano un tale modo di pensare; e molti, ripetiamo, non facevano una particolare fatica a conciliare un alto grado di cultura con la fede religiosa.
Il problema, infatti, non è dato dal grado di istruzione — basso, uguale fede in Dio; alto, uguale incredulità e irreligiosità -; nossignori: il vero problema è la cultura moderna, cioè quel particolare tipo di cultura che fa del rifiuto di Dio e della esclusione di Dio la base fondamentale sulla quale erigere tutto il resto, sulla quale edificare tutto il proprio sapere. In pratica, l’intellettuale moderno, vero erede di philosophes illuministi, dei savants e degli idéologues, è un signore che ritiene inconciliabile l’idea di Dio con la propria intelligenza e con il proprio sapere, e che, di conseguenza, ha deciso di sbarazzarsi dell’idea di Dio, così come il pilota di un’aeronave, per potersi librare sicuro nell’aria, a un certo punto lascia cadere nel vuoto i sacchetti di sabbia che costituivano la zavorra. La vera differenza fra un uomo di cultura della metà del XX secolo (lasciando stare, per adesso, le cosiddette avanguardie, veri e propri laboratori della rivolta organizzata e consapevoli pulpiti di propaganda materialista e irreligiosa) e uno dei nostri giorni, è che il primo, per quanta cultura avesse, conservava intatta la fede dei padri e non vedeva ragioni per cui le due cose avrebbero dovuto escludersi a vicenda; mentre l’intellettuale dei nostri giorni — difficile parlare ancora di "uomini di cultura" nell’era della specializzazione esasperata — è talmente convinto che tale incompatibilità esista, che non si prende nemmeno il disturbo di verificare se ciò sia proprio vero. Qualcuno domanderà come ciò sia possibile: stiamo dicendo, infatti, una cosa molto forte; stiamo dicendo che l’uomo contemporaneo è divenuto incredulo per pigrizia intellettuale e conformismo culturale, non per ragioni speculative vere e proprie. Rispondiamo che ciò è possibilissimo, dal momento che oggi, e, in verità, non da ieri, ma da almeno un paio di secoli, non esiste più quella cosa che si chiamava filosofia; il suo posto è stato preso, abusivamente e surrettiziamente, dalla psicologia; dopo di che vi è stato un tacito accordo, per cui tutti hanno continuato a chiamare "filosofia" ciò che, in realtà, è psicologia, e nessuno ha osato denunciare apertamente l’inganno. Ma se la filosofia esistesse ancora, un vero filosofo non avrebbe alcuna difficoltà ad affermare, come faceva, otto secoli fa, san Tommaso d’Aquino, che nella fede in Dio non c’è niente di assurdo, niente che offenda la ragione, niente che vada contro l’intelligenza umana. Ne era consapevole anche un grande intellettuale moderno, Giacomo Leopardi; il quale, pochi giorni prima di morire, guardando la pioggia che cadeva da dietro la finestra della sua camera, e ascoltando l’amico Ranieri che gli diceva come la fede in Dio ripugni alla ragione, tristemente aveva osservato: Ma uomini di grandissima statura non hanno provato alcuna ripugnanza… Ammissione quanto mai significativa, proveniente, com’è, da un ateo, e sia pure con la nostalgia di Dio. Quanto a noi, ricordiamo benissimo alcuni dei nostri professori di un tempo: persone colte, intelligenti, non certo prive di spirito critico; alcuni di loro erano credenti e non avevano complessi nei confronti della cultura moderna, non avevano sensi d’inferiorità, e andavano a Messa con la stessa naturalezza con cui, all’osteria, bevevano con gusto il loro bicchiere di buon vino, mescolandosi a una folla di lavoratori, di persone umili, di contadini, di fruttivendole, di pensionati. Diremo ancora di più: molti membri del clero cattolico erano persone di straordinaria cultura; molti vescovi erano autentici umanisti, molti sacerdoti non avrebbero avuto da temere il confronto, quanto a sapere e intelligenza, con le migliori menti della cultura laica o laicista.
Passando all’altra spiegazione che i moderni intellettuali danno riguardo alla fede delle società pre-moderne, ossia che essa serve a riempire il vuoto di conoscenze, soprattutto scientifiche, e a rassicurare gli uomini nelle incertezze dell’esistenza, anche qui ci troviamo di fronte a una mera ipotesi, oltretutto assai traballante, e non certo a un dato di fatto, a una verità acquisita e positiva. Sono solo i piccoli scienziati, e soprattutto le persone che scimmiottano e mal digeriscono la cultura scientifica, a credere che la conoscenza scientifica escluda, di per sé, la fede religiosa; i veri scienziati — Luigi Fantappiè, Enrico Medi, Antonino Zichichi – sanno benissimo che si tratta di due ambiti differenti, o meglio di due differenti piani di realtà, e che l’ambito della fede non esclude quello della scienza, e viceversa. In secondo luogo, siamo proprio sicuri che il sapere scientifico odierno abbia fugato quel senso d’incertezza, di precarietà, diciamo pure di angoscia, che contraddistingue la condizione umana e che tuba e travaglia la coscienza di tante persone? Secondo noi, no: perché la scienza può arrivare a spiegare una serie di fenomeni, non le ragioni ultime per cui le cose esistono e per cui noi stessi siamo venuti al mondo; né, tanto meno, quale sarà il nostro destino dopo la morte. Il paradigma moderno, anzi, per le sue stesse premesse materialiste e irreligiose, è singolarmente impotente a rispondere a simili interrogativi, perfino a pensarli, e singolarmente incapace di fornire agli esseri umani le rassicurazioni di cui hanno bisogno per condurre una vita serena. Al contrario: la scienza materialista, moltiplicando le domande, ma mostrandosi sempre più inadatta a rendere possibili le risposte ultime, anzi, demolendo la stessa possibilità delle risposte, non ha fatto altro che accrescere il senso d’incertezza, di precarietà, di angoscia. Ha fatto anche di peggio: ha illuso gli uomini di poter introdurre nella loro vita un mutamento radicale di segno positivo, ma questo non è accaduto: la malattia, la vecchiaia e la morte sono rimaste, in tutta la loro indecifrabile drammaticità: ed essi si sono sentiti traditi e abbandonati, più che mai derelitti. Aver spostato di qualche anno in avanti il fatto della morte, e aver trovato una cura per alcune malattie, mentre ne sono comparse di nuove, alcune causate dallo stesso sviluppo tecno-scientifico (si calcola che il 30% delle malattie attuali siano di origine iatrogena, cioè causate dalle cure stesse, o dai medicinali, o dalle inadeguate strutture sanitarie), non ha fatto che accrescere l’angoscia. E la filosofia, trasformatasi in psicologia, ha brillato per la sua assenza: non ha avuto una parola da dire, se non di riflesso, al seguito delle nuove teorie scientifiche. Si è messa a fare le pulci a se stessa: si è trasformata, per esempio, in filosofia del linguaggio. Tuttavia, avendo rinunciato al pensiero dell’essere, si è condannata preventivamente all’impotenza e ha liquidato la sua stessa ragione di esistere. Una filosofia che non pensa l’essere è un qualcosa che non serve a nulla, un contenitore vuoto, una sorgente inaridita.
In realtà, il problema dell’incredulità dell’uomo moderno trova il suo culmine nella rinuncia a Dio, ma abbraccia un ambito assai più vasto della sola dimensione religiosa: è l’impossibilità di credere a qualsiasi cosa che abbia un significato e che non sia percepibile con i sensi. La struttura mentale dell’uomo moderno è l’incredulità, perché l’uomo moderno ha perso l’incanto del mondo. Il disincanto ha portato con sé non l’incapacità — tutta da verificare! -, ma la disponibilità a pensare il mondo incantato, a pensare l’essere, a pensare e sentire la presenza amorevole di Dio. Come abbiamo più sopra accennato, il rifiuto di Dio nasce dalla volontà e non dalla ragione; un forte indizio ci viene dato da quel fastidio, da quella sorda (o palese) irritazione che s’impadronisce dell’uomo moderno, allorché qualcuno tenta di parlargli di Dio, o quando il suo stesso pensiero, i suoi stessi sentimenti lo porterebbero verso di Lui. Egli se ne ritrae con un brivido di fastidio, e in quel brivido c’è la confessione che egli vorrebbe poter credere, come credevano i suoi padri, ma si proibisce di abbandonarsi, perché teme una cocente delusione. Già la scienza, eretta a spiegazione univoca del mondo, cioè a scientismo, lo ha fortemente deluso; così come lo hanno deluso tutte le promesse seducenti della modernità: il progresso, il benessere, le macchine, la felicità che avrebbe dovuto arrivare ma non è arrivata. Un’ulteriore, suprema delusione sarebbe più di quanto egli possa sopportare: perché l’uomo moderno è diventato singolarmente fragile, e si abbatte per cose che non avrebbero turbato di certo i suoi nonni. La ragione di tanta fragilità, paradossalmente, è la superbia. Solo se e quando l’uomo moderno sarà capace di deporre la corazza della superbia intellettuale che ha indossato, e che lo fa guardare dall’alto in basso il mondo intero, egli potrà ritornare a credere…
Fonte dell'immagine in evidenza: sconosciuta, contattare gli amministratori per chiedere l'attribuzione