
A proposito della dottrina sociale della Chiesa e del rapporto dei cristiani con la società
24 Maggio 2016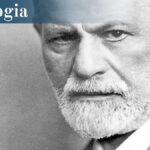
Solitudine, silenzio, paura, sono il destino politico dell’uomo contemporaneo?
25 Maggio 2016Che la figura di Bernard de Fontaine, abate di Clairvaux (nato nel 1090 e morto nel 1153), meglio conosciuto in Italia come Bernardo di Chiaravalle, sia una delle più straordinarie di tutto il Medioevo cristiano, basterà, a farlo capire, il fatto che Dante Alighieri lo sceglie quale guida spirituale nell’ultima parte della terza cantica del suo immortale poema, là dove egli si avvicina a Dio e la visione si fa sempre più luminosa, abbagliante, insostenibile, e vi è quindi bisogno della preghiera e dell’assistenza di un’anima veramente grande. Ebbene, per Dante l’anima più grande di tutte è quella di San Bernardo, guida suprema ai piedi del trono di Dio, nella sommità dell’Empireo, dopo aver visitato e oltrepassato tutti i cieli delle anime beate ed essere giunto alle soglie della meta finale e dello scopo supremo del suo pellegrinaggio ultraterreno.
Monaco cistercense; dottore della Chiesa; canonizzato meno di vent’anni dopo la morte; taumaturgo dalla fama prodigiosa; strenuo lottatore e difensore della fede cattolica contro eretici, liberi pensatori (Pietro Abelardo) e nemici esterni (l’Islam); ispiratore — come pare — della regola dei Cavalieri Templari; alto promotore del culto mariano; predicatore della seconda Crociata; ma, soprattutto, sublime maestro di spiritualità, misticismo e ascesi: si può dire che tutta la sua vita sia stata una battaglia per restaurare, con la mediazione di Cristo, la natura umana, decaduta a causa del Peccato originale, e per ricondurre le anime dall’amore terreno all’amore di Dio. Egli riassume in sé tutti gli aspetti più significativi della religiosità medievale, dei quali riflette ed esprime nel modo più compiuto l’intima essenza.
Nel trattato teologico-pratico De gradibus humilitatis et superbiae, suddiviso in sedici capitoli, San Bernardo distingue, innanzitutto, ed elenca, i dodici gradi dell’umiltà, ai quali contrappone, punto per punto, i dodici gradi della superbia: la curiosità; la leggerezza d’animo; l’allegria inopportuna; la millanteria; la singolarità (il volersi distinguere dagli altri, apparendo superiore); l’arroganza; la presunzione; la difesa dei peccati; la confessione simulata; la ribellione; la libertà di peccare; l’abitudine di peccare. Giunto alla fine, l’Autore si giustifica di aver parlato più della superbia che dell’umiltà, affermando egli non poteva parlare che di ciò che conosceva, e, quanto a se stesso, ritiene di saper più discendere verso il peccato, che salire verso la grazia; perciò invita il lettore, per saperne di più sull’umiltà, di andarsi a leggere San Benedetto, il maestro perfetto. Lui, Beranardo, deve essere letto, in un certo senso, al contrario: deducendo, dai gradi della sua discesa, quelli corrispettivi della salita, proprio come chi si reca in pellegrinaggio a Roma, vede, ma in ordine inverso, i luoghi che San Benedetto ha visto a sua volta, mentre vi si recava.
Nell’opera successiva, De diligendo Deo, tuttavia, San Bernardo tenta di nuovo di parlare del modo in cui bisogna avvicinarsi a Dio, uscendo da se stessi: bisogna abbandonare l’amore di sé e convertirsi all’amore di Dio, e solo in ultimo tornare all’amore di se stessi: ma, questa volta, sarà un amore trasfigurato, nel quale l’uomo ama se stesso non per sé, ma per Dio, per diventare una sola cosa con Lui. I passaggi, o gradi, di questo itinerario spirituale, sono quattro. Al primo livello l’uomo ama sé, per se stesso; nel secondo, l’uomo rivolge il suo amore verso Dio, ma solo per i benefici che ne riceve; nel terzo, l’uomo ama Dio per Dio, senza nulla domandare; nel quarto e ultimo, l’uomo torna ad amare se stesso, ma per Dio. Nell’ultimo capitolo (il nono), peraltro, Bernardo si premura di precisare che il quarto livello dell’amore è inaccessibile all’uomo in questa vita: le anime, infatti, non sono capaci di amare così, ossia di amare se stesse per Dio, prima della risurrezione. Esse, infatti, tendono a ricongiungersi ai loro corpi, o desiderano, o sperano questa ricongiunzione: e ciò sta a dimostrare che esse non sono totalmente mutate da quello che erano prima, non si sono del tutto spogliate dell’amor proprio; ed è appunto quest’ultimo che tende a far deviare, sebbene per poco, la dirittura del loro desiderio. Dunque — egli scrive — finché la morte non sarà riassorbita nella vittoria, e la luce immutabile non avrà invaso ovunque il regno delle tenebre e ne domini tutte le parti, finché la gloria divina non risplenderà anche nei corpi, le anime non potranno uscire totalmente fuori di se stesse e passare in Dio.
Il capitolo forse più affascinante, più denso, più sublime, è, secondo noi, l’ottavo, nel quale San Bernardo descrive, appunto, il quarto grado dell’amore, nel quale l’uomo giunge ad amare se stesso, non per se stesso, ma per Dio; non senza aver precisato che l’uomo, nel corso della vita terrena, solo in rari istanti fortunati, solo in fuggevoli attimi di ascesa mistica e d’ineffabile rivelazione e beatitudine, può pervenire ad un tale stato: dopo di che, il peso della carne, cioè l’unione del corpo con l’anima, lo fanno rientrare in se stesso e lo allontanano da quello stato di pienezza indicibile, che potrà realizzarsi stabilmente solo dopo la morte alla vita terrena e l’ingresso dell’anima, con il corpo glorioso e trasfigurato, nella vita eterna.
Affinché il lettore possa farsene un’idea, ne riportiamo la seconda parte, §§ 28-30 (da: Bernardo di Chiaravalle, I gradi dell’umiltà e della superbia e L’amore di Dio; introduzione, tradizione e note di Gaspare Mura, Roma, Città Nuova Editrice, 1992, e Milano, Edizioni Martello, 1997, pp. 204-206):
Poiché tuttavia la Scrittura ci assicura che Dio ha creato tutte le cose per lui stesso, ci sarà certamente un tempo in cui la creatura si conformerà e sarà in armonia con il suo Autore. Occorre quindi che anche noi, o prima o poi, giungiamo a sentire in questo modo: come Dio ha voluto che tutte le cose venissero all’esistenza per lui solo, così occorre che anche noi non desideriamo di essere stati o di essere nessun’altra cosa, e neanche noi stessi, se non per lui, ossia per la sua volontà e non per il nostro piacere. Sarà per noi una gioia, non il fatto che venga appagata una nostra necessità, e neppure che conseguiamo la nostra felicità, ma il veder compiuta la volontà di Dio in noi e su di noi, come chiediamo nella nostra preghiera quotidiana, allorché diciamo: "Sia fatta la tua volontà, così in cielo, come in terra". O amore santo e casto! O dolce e soave sentimento! O desiderio puro e santo della volontà, certamente tanto più santo e puro, quanto meno v’è misto di nostro, tanto più soave e dolce, quanto più è tutto divino ciò che si prova! Provare questo sentimento, è essere deificato. Come una piccola goccia d’acqua, mescolata a molto vino, sembra scomparire del tutto, perché assume il sapore e il colore del vino, e come un ferro rovente e incandescente diviene molto simile al fuoco e perde il suo aspetto originario, e come l’aria inondata dalla luce del sole si trasforma nella stessa luminosità della luce, a tal punto che non sembra più illuminata ma appare essa stessa luce, così è necessario che nei santi ogni affezione umana si liquefaccia, in qualche ineffabile modo, in se stessa, e che si trasformi totalmente nella volontà di Dio. Altrimenti come potrà avvenire che Dio sarà tutto in tutte le cose, se nell’uomo restasse qualcosa dell’uomo? Rimarrà certamente la sua sostanza, ma sotto un’altra forma, sotto un’altra gloria, sotto un’altra potenza. Quando sarà questo? Chi lo vedrà? Chi lo raggiungerà? "Quando verrò, e apparirò al cospetto di Dio?". Signore mio Dio, "il mio cuore ti ha parlato; il mio volto ti ha cercato; il tuo volto, o Signore, io cercherò". Credi che io vedrò il santo tempio tuo? Io non credo che, prima di quest’ora, sarà perfettamente compiuto il comandamento che dice: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta la tua anima, e con tutta la tuia forza"; prima dell’ora in cui lo spirito non sarà più costretto a preoccuparsi del corpo, e l’anima, che in questo stato gli comunica la vita e la sensibilità, cesserà di attendere a lui, e le sue facoltà, liberate dalle angustie presenti, saranno rinvigorite nella potenza di Dio. Infatti è impossibile che si raccolgano totalmente in Dio tutte queste cose, che si fissino sul suo volto, finché c’è necessità che siano distratte e occupate nel servire questo corpo debole e sofferente. L’anima quindi speri di raggiungere il quarto grado dell’amore — o meglio, speri di esservi portata, perché appartiene alla potenza di Dio concedere ciò a chi vuole e non alla possibilità umana il raggiungerlo — solo quando sarà in un corpo spirituale e immortale, in un corpo integro, pacifico e tranquillo, e soggetto in tutto allo spirito. Allora, ripeto, raggiungerà con facilità il più alto grado dell’amore, o meglio sarà rapita in esso, giacché appartiene alla potenza di Dio donare questo corpo a chi vuole e non allo zelo dell’uomo di ottenerlo. Allora, dico, essa otterrà facilmente il supremo grado, quando si slancerà in una corsa rapida e fervente verso il gaudio del suo Signore, senza che nessuna lusinga della carne la ritardi né alcuna molestia la turbi.
Non crediamo forse che i santi martiri ottennero questa grazia, almeno in parte, quando ancora vivevano nei loro corpi vittoriosi? Tanto grande era la forza dell’amore che aveva rapito le loro anime interiormente, che essi furono in grado di esporre i loro corpi al martirio e disprezzare i supplizi. Anche se, certamente, la sensazione di dolori così crudi non poté non turbare, benché non sconvolgere in profondità, la loro serenità. Ma quale sarà lo stato delle anime finalmente sciolte dal legame dei loro corpi? Io credo che siano totalmente immerse in quell’immenso oceano della luce eterna e della luminosa eternità.
In questa pagina veramente sublime, che ci aita a capire perché Dante abbia scelto San Bernardo per rivolgere alla Madonna la stupenda preghiera del XXXIII canto del Paradiso, grazie alla quale gli è concesso l’ineffabile privilegio di poter vedere, per un istante, la luce di Dio, mentre ancora veste il corpo mortale, noi sentiamo battere il cuore vivo della spiritualità monastica medievale, la quale permeava di sé l’intera società, compreso il mondo profano, che s’inchinava riverente davanti ad essa, e in essa riconosceva la guida necessaria per giungere al fine della vita umana.
Nello stesso tempo, tuttavia, sentiamo anche un’altra cosa: che il mondo moderno, e la stessa Chiesa dei nostri giorni, si sono allontanati a tal punto da una simile spiritualità, da aver elaborato una specie di anti-teologia, nella quale il rapporto fra creatura e Creatore viene interamente rovesciato, e si direbbe che lo scopo della vita cristiana non sia tanto quello di ricondurre l’uomo a Dio, spogliandosi di se stesso, ma di glorificare l’uomo, prendendo Dio quasi a pretesto della santificazione della natura umana, comprese le sue debolezze, trasformate, chi sa come, in cose perfettamente giuste e buone, delle quali l’uomo deve compiacersi, e che non deve rinnegare o mortificare in alcun modo.
Mentre San Bernardo ci insegna, prendendoci per mano, a spogliarci del nostro io e a desiderare solo e unicamente di essere tutt’uno con Dio, a non volere, a non sperare, a non cercare altro da quello che Lui vuole, certi sedicenti teologi cattolici dei nostri giorni, e anche – duole dirlo – certi vescovi e certi sacerdoti, hanno praticamente smesso di usare questo linguaggio e di esprimere questi concetti, mentre non fanno altro che parlare di quello che l’uomo vuole, spera e cerca, e di come il "vero" cristianesimo non consista in altro che nel santificare tutto ciò che è umano, così come è nella condizione attuale: vale a dire, come se la ferita del Peccato originale non fosse stata inferta e la natura stessa fosse pura e innocente come lo era al momento della creazione. Ebbene, coloro i quali insegnano tali cose, sono, puramente e semplicemente, nell’apostasia: perché il Vangelo che predicano non è più il Vangelo di Cristo, e l’amore di cui parlano è unicamente un amore umano, cioè impastato di egoismo, di amor di sé e di ricerca del proprio piacere: l’esatto contrario, e la diabolica contraffazione, del vero amore cristiano, fatto di oblio di sé e di abbandono, fiducioso e incondizionato, all’opera vivificatrice dalla Grazia divina.
Rileggere le opere di Bernardo di Chiaravalle significa tuffarsi nella fresca fonte della genuina spiritualità cristiana: quella di San Francesco d’Assisi, di Santa Chiara, di Santa Caterina da Siena, di Santa Teresa d’Avila, di San Giovanni della Croce, di Santa Teresa di Lisieux; che è, poi, in ultima analisi, la spiritualità del Vangelo, la spiritualità di Gesù, il solo Maestro, il solo modello di perfezione assoluta, il quale era solito ammonire i suoi discepoli, dandone per primo l’esempio: Pregate sempre, senza stancarvi mai (Lc., 18, 1). Ed è ben strano che vi sia, nella Chiesa cattolica, chi pretende di forzare un tale modello per presentarci una diversa immagine dell’autentica spiritualità cristiana, tutta assorbita dalle cose del mondo, quasi che la creazione avesse bisogno di venire corretta e perfezionata dall’azione riparatrice dell’uomo. A ciò siamo stati condotti dalla presunzione e da una falsa scienza, che camuffano l’incredulità con termini pomposi, come "svolta antropologica", per mascherare la verità: la perdita della fede in Dio e il satanico orgoglio umano…
Fonte dell'immagine in evidenza: Foto di Chad Greiter su Unsplash
