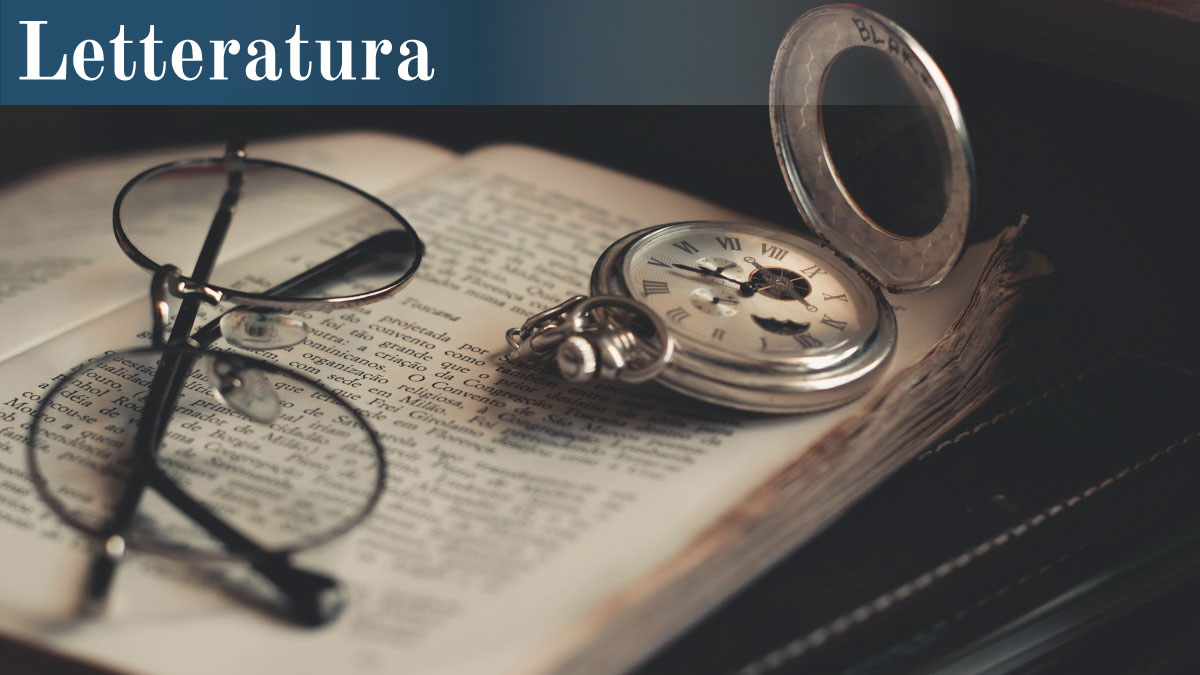Il ricatto ideologico della sinistra continua a pesare su generazioni d’intellettuali
31 Gennaio 2016
Faziosità e conformismo culturale nei manuali di storia: il caso di Armando Saitta
1 Febbraio 2016Henri Bosco, nato da una famiglia italiana (imparentata con San Giovanni Bosco), emigrata in Francia nel XIX secolo, è stato uno scrittore francese che, nei suoi molti romanzi — più di quaranta, in tutto -, ha scoperto e sviluppato il segreto della semplicità, unito alla delicatezza del sentire e alla poesia della natura. È, a nostro avviso, meno conosciuto, ai nostri giorni, di quanto meriterebbe; è un autore di nicchia, come lo sono altri scrittori francesi di origine italiana, quali Jean Giono e Serge Bertino. Nato ad Avignone il 16 novembre 1888 e spentosi a Nizza il 4 maggio 1976, è sempre rimasto fedele, per tutta la sua vita e la sua opera letteraria, al culto degli affetti familiari, dell’infanzia, della campagna, e di quella Provenza, di quella Francia del Sud, piena di luce, di profumi, di dolcezza, che tanto amava e che costituiva la sua patria ideale, oltre che materiale: un paese dell’anima, prima ancora di essere il paese di cui era figlio e cittadino. Suo padre era nato a Marsiglia e sua madre a Nizza (quando questa città, patria di Giuseppe Garibaldi, era ancora parte del Regno di Sardegna). Non possiamo immaginare Henri Bosco altro che in quei luoghi, in quella dolce campagna percorsa dal mistral, inebriata dall’aroma della lavanda, celebrata in tante tele di Vincent Van Gogh, coi suoi incredibili verdi e azzurri, i suoi alberi contorti e rigogliosi, i suoi fantastici cieli stellati, limpidi e animati come lo sono, altrove, quasi soltanto i cieli d’alta montagna.
Bosco è stato il poeta del Mezzogiorno, del Mediterraneo. Dopo la Prima guerra mondiale, cui ha partecipato combattendo su numerosi fronti, si è portato in Italia ed ha trascorso dieci anni a Napoli, insegnando presso l’Institut Français; e lì si è scoperto scrittore, scrivendo il suo primo romanzo, nel 1925: «Pierre Lampédouze». Una vocazione, tutto sommato, tardiva: Henri Bosco aveva, allora, già trentasette anni. Poi, per ventiquattro anni, si è trasferito in Marocco, dal 1931 al 1955, facendo l’insegnante a Rabat e ricoprendo la carica di Presidente dell’Alliance Française. Ha vinto numerosi premi letterari e, in particolare, il Grand Prix National des Lettres, nel 1953, e il Grand Prix du Roman de l’Académie Française, nel 1968, che hanno coronato la sua carriera di scrittore. Come Alphonse Daudet — che era nativo di Nîmes -, alla cui narrativa possiamo, almeno in parte, accostarlo, Henri Bosco è stato tutt’uno con il Sud della Francia: il suo cantore, il suo interprete, quasi il suo sacerdote; e, insieme, il poeta delle cose semplici, dei ricordi, della fanciullezza favolosa. In lui c’è qualcosa di Giovanni Papini, ma senza la sua amarezza; di Marino Moretti, ma senza la sua stoica e malinconica rassegnazione; forse, fra gli italiani della stessa generazione, quelli che più lo ricordano, almeno quanto ai temi e alla sensibilità, sono il fiorentino Bruno Cicognani (1879-1971), per la tenace nostalgia del mondo incantato dell’infanzia, e il ticinese Francesco Chiesa (1871-1973) per la pulizia dei sentimenti e il fresco senso della natura (cfr. il nostro articolo: «Una pagina al giorno: l’arrivo dello zio d’America, di Francesco Chiesa», pubblicato sul sito di Arianna Editrice il 14/04/2009, e su «Il Corriere delle Regioni» il 10/12/2015).
Ecco una splendida descrizione della vasta campagna provenzale, in una notte estiva inargentata dalla Luna, ove l’autore, bambino di sette od otto anni, si è risvegliato, rasserenato e rinfrancato, dopo una fuga precipitosa dalla casa dei vicini presso i quali era stato collocato dai suoi genitori, e dove aveva commesso un guaio (da: H. Bosco, «Tonino»; titolo originale: «Antonin», 1952; traduzione di Jole Fia, Torino, S.A.I.E., 1955, pp. 21-24):
«… Allora dall’oriente la luna si levava, sopra alcuni pioppi, e già biancheggiava fra gli alberi il padiglione solitario. Gli alberi non erano più che neve, e, a tratti, sotto l’alitare impercettibile della brezza, si distaccava da essi una pioggia impercettibile di petali. La luna illuminava i pioppi di una luce azzurrina; ma gli alberi da frutta conservavano tutto il loro candore. Ogni forma illuminata traeva dall’ombra qualche essere più misterioso degli alberi, dei cespugli e delle siepi donde esso usciva. E di quel soffio che separava i petali dagli alberi nulla, se non questo stesso segno, nulla nello spazio, tiepido e calmo, svelava l’invisibile passaggio. L’aria era immobile, il silenzio occupava quell’angolo della notte, e nella campagna, senza che il movimento, sia pure impercettibile, di una sola foglia ne turbasse la fragile serenità… Io non so quando mi sono alzato, quando ho tratto il mio corpo dal nascondiglio. Ricordo soltanto di aver subito pensato alla mia casa; ma non come un fuggitivo spaventato dall’improvvisa coscienza della sua colpa. No. Vi pensavo come una cosa lontana, perduta in mezzo alla notte e, forse, ancora più irreale del frutteto.
Appena ritto intesi i grilli. Più lontano, un uccello si lamentava; più lontano ancora un cane desolato abbaiò. Ma quei richiami, quei lamenti che davano alla vita segreta della campagna un senso più familiare, non turbarono la pace del frutteto lunare. Il silenzio ch’esso proteggeva doveva essere d’una natura inalterabile; e questa sensazione, che nel mio spirito non sapevo definire, si fissò nondimeno nella mia memoria e donde oggi risale con il ricordo della luna cilestrina e dei disegni stellati della notte.
Io sapevo che non si doveva scavalcare la siepe e andare sotto gli alberi. Laggiù, nessuno era mai andato… Nessuno, salvo l’uccello che, per sortilegio, vi aveva creato quella natura strana di giardino separato dal mondo. Ma il solo fatto di averlo veduto attraverso l’intrico dei rami del biancospino, non era già avventura tale da disporre l’anima alla ricerca di altre avventure, che la notte piena di segreti offriva al desiderio? Giacché di ogni dove insieme il desiderio e il timore mi tentavano. Tuttavia non sapevo più verso quale direzione nello spazio occorresse dirigersi per ritrovare la casa di mio padre. Di tanto in tanto passava nel cielo una stella filante che andava a cadere di là degli alberi. Tracciava una lunga striscia di fuoco e sulla punta, lacerando l’aria, sprizzava scintille. Mi pareva che a quell’ira nessuno vegliasse più nella campagna, per guardarla. Ero solo. Mi dicevo che molte cose accadono nella solitudine. Certo, io non formulavo questo pensiero così come lo esprimo adesso; ma l’avevo in me, se provavo un tale stupore nel sentirmi tutto solo nella notte. Di fatto, non avevo paura. Fra la terra e me l’amicizia si era stretta allorché m’ero nascosto sotto il biancospino. In quel momento avevo amato la terra sentendo intorno a me la presenza del suo amore. Il timore mi veniva soltanto dal mio io che, sperduto, esitava sul cammino da seguire. E un tremore anche mi prendeva all’idea delle figure notturne che un passo di bambino può destare, che fatalmente il suo passaggio desta…
Alla fine, tuttavia, mi sono deciso…
Mi ricordo che dapprima ho seguito, rasentando il guardino, uno stretto sentiero. Mi ha condotto in un luogo coltivato. Ho attraversato il campo e ho trovato un ponticello di tavole. Sotto vi scorreva un ruscello che brillava dolcemente fra le erbe. L’ho oltrepassato. Sulla riva crescevano dei giunchi, dei vinchi e dei salici. Sentendomi, una civetta si mosse fra gli alberi e lanciò un melanconico richiamo ad un’altra civetta lontana, che rispose. Ho svoltato a destra. Il cuore mi batteva. Ho preso la strada su cui sboccava il ponte. Affondava tra le siepi; ma era adesso una vera strada e non più un sentiero. Le siepi si susseguivano dappertutto, e come esse creavano dei vialetti d’ombra, prima di avventurar mici, aspettavo d’esser certo che nulla si muovesse tra il fogliame. L’aria era dolce. La strada sinuosa. Andavo senza sapere dove i miei passi, mossi il più leggermente possibile, mi avrebbero condotto. Talvolta un muro di cipressi annunciava un cascinale. Scorgevo la cima delle tettoie e il colmo appena inclinato della vecchia casa. Sulla facciata colorata dalla luna rilucevano le piastrelle di maiolica della colombaia. Scivolavo cin prudenza lungo la siepe per non svegliare il cane da guardia. Ero in un paese di erbe. Si sentiva il rumore dei rivoli colmi che scorrevano attraverso i prati. L’acqua emergeva dal suolo; gonfiava le piante. Ovunque il fresco sentore degli erbaggi teneri si levava vaporosamente dall’argilla bagnata; e quanto più la luna cresceva, tanto più l’evaporazione delle piante umide impregnava l’aria notturna. Più volte credetti di scorgere un uomo; ed ogni volta, in tutta fretta, mi nascosi. L’uomo non si muoveva. Stava appostato al’angolo di una siepe, o dietro un tronco d’albero o addirittura si drizzava nel bel mezzo della strada. Io aspettavo. Tutto rimaneva immobile. In capo ad un istante, gli occhi chiusi, la testa bassa, avanzavo verso di lui. E come non era che una creatura lunare, gli passavo attraverso senza accorgermene; e quando, più lontano, riaprivo gli occhi, sentivo un rospo meravigliarsi gravemente della mia presenza. Ma qualche volta era una raganella che parlava, e allora mi fermavo pel piacere di udirla meglio, ché essa è la voce più pura della notte.»
In questa bellissima e commovente pagina di prosa, Henri Bosco ci trasporta d’un sol colpo, come per magia, in quella vasta, pacifica, trasognata campagna provenzale, inargentata dalla luce della Luna, satura di aromi e di profumi, cullata dal frinire d’innumerevoli grilli, lontani e vicini; e, nello stesso tempo, ci riconduce nel seno della dimensione ancor più misteriosa e poetica, ancor più suggestiva e affascinante, dell’infanzia, quando le cose si sono rivelate agli esseri umani per la prima volta e conservano ancora qualcosa della loro essenza originaria, sacra, inesprimibile a parole: quella del Giardino terrestre, allorquando Adamo ed Eva erano ancora amici di Dio e del creato, e ogni cosa spirava pace e fecondità.
Questo modo di fare letteratura non nasconde le asprezze della vita, i passaggi difficili, i momenti di disorientamento; eppure non smorza l’amore per la vita, non appanna le speranze, non tarpa le ali a quel bisogno struggente di verità, di bontà e di bellezza, che rende la vita umana degna di essere vissuta; aiuta il lettore ad alzare lo sguardo verso il cielo, ad ammirare la volta trapunta di stelle, e a spingere i pensieri ancora più in alto, fino ai piedi del Creatore, per deporvi gli umani affanni e per trarre nuove energie e una rinnovata fiducia nel domani. Scrittori come Henri Bosco devono essere benedetti, perché lodano la vita e ci aiutano ad affrontarla con coraggio, con entusiasmo e con profondo senso di responsabilità.
«Tonino» è, in effetti, un romanzo di formazione; ma non alla triste maniera dei naturalisti, non alla maniera di Flaubert, per il quale "formazione" è sinonimo di disincanto, di vuoto e di stanchezza esistenziale; tutto al contrario, nel senso di una autentica crescita umana, di un aumento della capacità di apertura, di comprensione, di simpatia verso le cose. Robert Musil, che a torto è stato accostato agli "scrittori della crisi", afferma, ne «L’uomo senza qualità», che amare qualcosa significa imparare a vederla; ebbene, Henri Bosco ama le cose e le fa amare al lettore, perché sa vederle, anche quelle più piccole e quotidiane, e possiede il dono rarissimo e preziosissimo di farle vedere ed apprezzare anche agli altri. Dono superbo, quasi divino: magari ce ne fossero di più, di scrittori come lui; e, soprattutto, magari ci fossero più editori, più critici letterari e più professori di liceo e d’università, capaci di farli conoscere al vasto pubblico dei lettori comuni.
Purtroppo, il panorama letterario del Novecento è ingombro di scrittori che non amano la vita, né la fanno amare; che non sanno vedere la magia e l’incanto delle piccole cose, ma che si struggono e si lamentano perché sfuggono loro le grandi (e non sanno che, per essere degni di apprezzare le grandi cose, bisogna prima imparare a vedere le piccole e le minime); che si esprimono in uno stile oscuro ed ermetico, rivolto ad altri scrittori, infelici e sofisticati come loro, e perciò pronti a lodarli, ma non certo alle persone comuni; di misantropi raziocinanti e pessimisti di professione, gonfi di orgoglio e di amarezza, torturati dalla malattia del narcisismo, bramosi di sporcare tutto ciò che non arrivano a capire, perché non sono abbastanza umili da comprenderlo. È un peccato: si fa credere alle giovani generazioni che, per esser degli scrittori grandi e profondi, bisogna essere anche delusi e disamorati della vita, sprofondati nel relativismo, trasudanti rancore e disperazione esistenziale. Gli scrittori come Henri Bosco, come Nicola Lisi, come Eugenio Corti, sono paragonabili alla pioggia benefica dopo una stagione di spietata siccità: la terra spaccata e riarsa la riceve con gratitudine infinita, perché riconosce in essa la benedizione della vita. È pur vero che, per capirli e per sentire che essi, nella loro apparente semplicità, sono profondi — molto più di quegli altri, lodati e incensati in un mondo che corteggia la follia e la morte, e non la sanità e la vita — bisogna che anche il lettore sia stato bambino, almeno una volta, come Tonino, quella notte, nella luce incantata della Luna…
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels