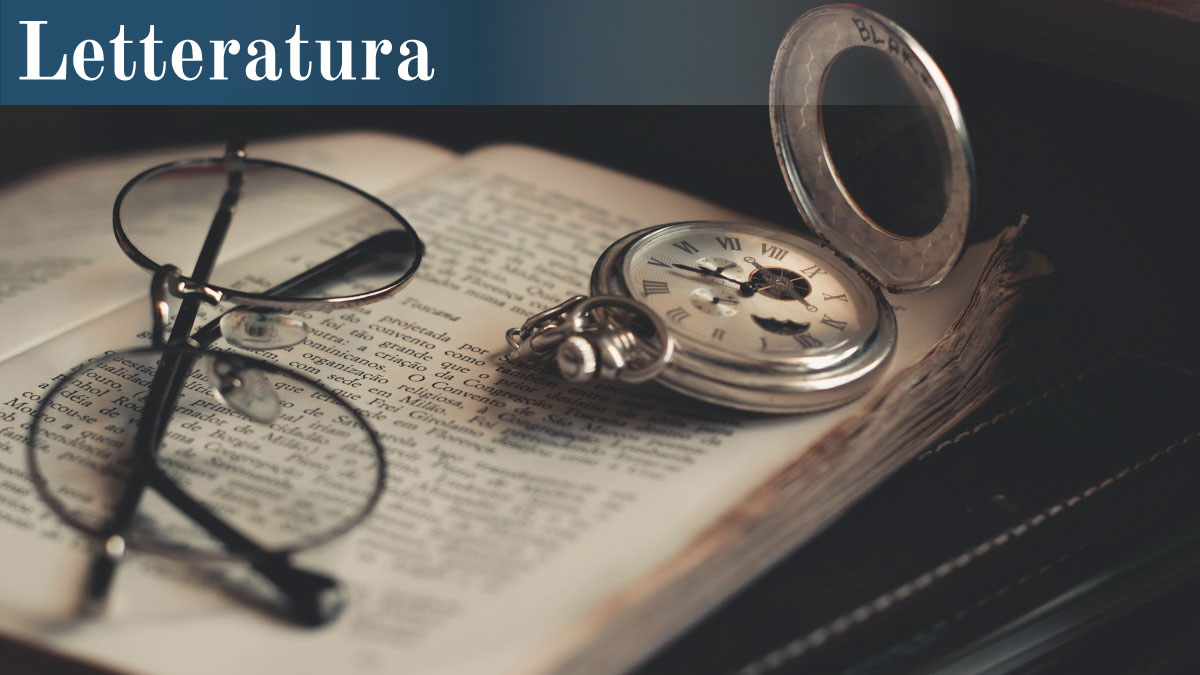C’è un patto scellerato fra alieni e governi nell’ignoranza totale dell’opinione pubblica?
8 Dicembre 2015
La matematica, per Fantappié, è scienza non solo dell’essere, ma del poter essere, cioè metafisica
9 Dicembre 2015L’influenza che un libro può esercitare sulla mente e sul cuore del lettore è semplicemente enorme, tale da cambiare radicalmente, o da orientare in maniera decisiva, e forse irreversibile, la sua vita, i suoi pensieri, le sue azioni. E, se questo è vero per quel che riguarda il lettore adulto, ci si può facilmente immaginare quanto lo sia, a maggior ragione, nel caso del lettore bambino o adolescente, beninteso qualora esistano le condizioni, oggettive e soggettive, che rendano possibile il "contatto" profondo fra la dimensione di chi scrive e quella di chi legge.
Nel caso del bambino, la forza d’urto e le capacità d’impatto di un’opera letteraria sono centuplicate dal fatto che, nell’infanzia, la personalità è ancora malleabile come la cera, l’immaginazione e la fantasia sono vivissime, e la coscienza non ha ancora avuto il tempo, né l’occasione, di creare attorno a se stessa quella sorta di rete protettiva che deriva dall’esperienza stessa della vita, con le sue speranze e le sue delusioni. Lo stupore del bambino davanti al mondo è ancora intatto, o quasi, e la risonanza delle cose che accadono per la prima volta, degli incontri che si fanno per la prima volta (anche degli incontri letterari), è, potenzialmente, illimitata: come se la coscienza infantile fosse una immensa caverna, dalla volta altissima, nella quale anche il più piccolo sussurro, anche il più flebile bisbiglio, vengono trasformati dall’acustica del luogo in una voce possente, carica di un’eco che si ripercuotono innumerevoli volte.
Questo, naturalmente, è uno stato di fatto — e con i fatti non si deve mai litigare; solo cercare di comprenderli -, ma carico di implicazioni psicologiche, culturali, spirituali e anche morali, che rendono delicatissimo il rapporto fra colui che scrive e la coscienza del bambino, allorché essa venga catturata dalla lettura. Così come il bambino che gioca, ed è felice, non si fermerebbe mai, ma continua a giocare fino a quando non crolla per la stanchezza, a meno che qualcosa o qualcuno sopraggiunga, dall’esterno, a interrompere i suoi giochi; allo stesso modo il bambino che ritiene d’aver scoperto un tesoro fra le pagine di un libro, dimentica fame e sete, obblighi e convenienze, amici e familiari, e si sprofonda interamente in quell’altra dimensione, parallela a quella quotidiana, in cui risiede la magia della lettura. In un certo senso, egli viene catturato da una potenza aliena e trasportato in un altrove che è molto simile al Paese delle meraviglie in cui si era smarrita la piccola Alice, l’eroina del romanzo scritto da Lewis Carroll nel 1865.
Scrivere per i bambini, di conseguenza, rappresenta una responsabilità enorme: il che ci dà la misura di quanto sia dimentica del proprio progetto educativo, ammesso che ne abbia ancora uno, la civiltà contemporanea, nella quale la letteratura per l’infanzia è stata praticamente abbandonata o, peggio, sostituita da una fitta schiera di romanzi insulsi e profondamente diseducativi, pubblicati e pubblicizzati esclusivamente in base alle leggi del mercato, che si fanno veicolo di una visione della vita cinica e violenta, oppure immatura e banale, oppure, ancora, ricalcata su quella degli adulti, senza alcun riguardo per la particolare natura della coscienza infantile.
E d’altra parte, non è detto che a esercitare una influenza colossale sulla mente e sul cuore di un bambino sia proprio un libro che è stato pensato e scritto per lui, come fanno, appunto, o piuttosto come facevano, gli scrittori per l’infanzia; specialmente un bambino che sia dotato d’intelligenza e sensibilità superiori alla media, potrà fare da solo la scoperta di un libro "per adulti", frugando sugli scaffali del padre o della madre, oppure adocchiandolo attraverso la vetrina di una libreria, e mettersi a leggerlo per proprio conto, dopo averlo desiderato tanto quanto può accadere a un bambino che desideri ardentemente di poter stringere fra le mani un giocattolo bellissimo.
Questo accade specialmente (ma non solo) ai bambini per i quali l’ambiente familiare rappresenti già, di per sé, un luogo favorevole all’amore per la cultura, per la lettura e per i libri; il genere specifico di lettura verso cui il bambino, poi, concretamente, finirà per orientarsi, diventa così una variabile secondaria di una disposizione interiore molto più ampia: perché l’amore per i libri si trasmette ai bambini soprattutto con l’esempio, e vi sono poche altre cose che colpiscono con altrettanta forza la coscienza del bambino, come il fatto di vedere, ad esempio, i suoi genitori che si immergono con passione nella lettura. Ciò è più che sufficiente a far sì che il bambino si incuriosisca e che divenga predisposto a fare altrettanto — anche se a un padre medico, poniamo, potrà accadere che il proprio bambino si innamori dei libri che parlano delle vite dei santi, o alla madre che ama i romanzi sentimentali potrà capitare che la propria bambina si appassioni alla lettura di manuali che trattano degli animali e delle piante.
Così il grande naturalista anglo-americano Ernest Thompson Seton, il "nonno" dei Boy Scouts – poi fondati da Robert Baden-Powell – ha descritto, identificandosi nel personaggio di Yama, la propria vocazione per la vita all’aperto, per i boschi e per gli animali e le piante che li popolano (da: E. T. Seton, «Due piccoli selvaggi»; titolo originale: «Two little Savages», 1903; traduzione dall’inglese di Piero Pieroni, Milano, Casa Editrice Bompiani, 1979, pp. 13-16):
«Ma in quel periodo si verificò il più grande avvenimento dell’allora tenera età di Yan. I suoi insegnanti gli parlarono di Wilson e di Audubon, il primo e l’ultimo dei grandi naturalisti americani. Yan si chiese perché non fosse nato nessun altro profeta di quella statura. Ma un giorno i quotidiani annunziarono che finalmente era comparso: si trattava di un libro sugli uccelli del Canada, di… e costava un dollaro.
Mai il denaro era apparso a Yan una cosa tanto preziosa, necessaria e nobile. "O, se solo avessi un dollaro!". Si mise a risparmiare e a cercare di guadagnare. Vinse un certo numero di biglie al gioco, le scambiò con trottole, e queste ultime con temperini, seguendo la strana e rigida periodicità dei vari giochi. A loro volta i temperini vennero scambiati con conigli, e i conigli con monetine di poco valore. Trasportò legna per casalinghe sconosciute; guadagnò e guadagnò ancora, raggranellando tutto ciò che poteva. Dopo alcuni mesi era riuscito a mettere da parte novanta centesimi. Ma gli ultimi dieci centesimi sembravano bloccati da una terribile fatalità. Nessuno aveva più strani lavori da affidargli; la fortuna nel commercio lo abbandonò. Ardeva dal desiderio di acquistare quel libro. Nessun di coloro che conosceva si interessava abbastanza a lui per prestargli quel denaro anche agli interessi rovinosi (due o tre volte ogni centesimo) ai quali era disposto a piegarsi. Ci vollero sei settimane prima di raccogliere quegli ultimi centesimi, e da allora Yan non si sentì più la coscienza a posto.
Lui e Alner dovevano spaccare la legna per la cucina. Ciascuno di loro aveva, ogni giorno, il suo quantitativo assieme ad altri compito. Yan eseguiva sempre scrupolosamente il suo lavoro, ma il fratello cercava di evitarlo in ogni modo. Era notoriamente uno scansafatiche. L’indigenza della famiglia non permetteva ad Alner più di un colletto di carta alla settimana, ma in tasca il ragazzo portava una gomma da cancellare con la quale poteva mantenere il suo standard di eleganza. A Yan, invece, dei vestiti non importava un bel nulla, anzi, da questo punto di vista era assai trascurato. Il fratello maggiore, volendo sfruttare la debolezza di Alner, mise in lizza una cravatta da venticinque centesimi, a scelta del vincitore, fra chi avesse eseguito meglio i suoi lavoretti casalinghi per un mese. Per la prima settimana, Yan e Alner tennero lo stesso passo, poi Alner si stancò, sebbene il premio fosse ambitissimo. Ma quel ritmo era troppo per lui. Yan continuò invece a lavorare e ala fine ottenne i promessi venticinque centesimi da spendere in una cravatta. Ma giunto nel negozio, gli venne un’idea brillante e tentatrice. Quindici centesimi erano il massimo che una persona potesse spendere in una cravatta; i restanti dieci gli sarebbero serviti per comprare il libro. Così l’ultima moneta venne aggiunta ai suoi risparmi. Poi, gonfio della gioia e dell’orgoglio di un capitalista, andò in libreria e chiese il volume tanto desiderato.
I sentimenti a lungo trattenuti lo rendevano teso: si aspettava che il libraio gli dicesse che il prezzo del volume era salito a mille dollari, e che aveva ormai venduto tutte le copie ricevute. Ma non fu così. L’uomo si volse in silenzio, estrasse il libro da una pila di volumi, esitò e gli chiese: "Copertina verde o rossa?"
"Verde", rispose Yan senza credere alle sue orecchie. Il libraio gettò un’occhiata alle pagine, poi depose il libro, dicendo con il tono freddo di un uomo di affari: "Novanta centesimi".
"Novanta centesimi!", ansimò Yan. Oh! Se solo avesse conosciuto l’abitudine dei librai di praticare sconti! Per sei settimane questa terra felice gli era rimasta bandita; aveva sofferto la fame; si era appropriato di denaro non esattamente suo; aveva turbato la sua coscienza, e tutto per raccogliere quei dieci centesimi… quei dieci centesimi non necessari!
Con profonda riverenza lesse il libro per tutta la strada fino a casa. Non gli dette ciò che voleva, ma questo era certo colpa sua. Si piegò su quelle pagine, le studiò, le amò, senza mai dubitare di possedere ormai la chiave di tutte le meraviglie e i misteri della Natura.»
Ora, il mondo immaginativo del bambino è dominato dal senso della vista; per cui un libro ha tante maggiori probabilità di colpire la sua viva immaginazione, quanto più sia capace di rivolgersi ad essa attraverso le immagini. Ecco, allora, l’importanza dei disegni, o delle fotografie, o di qualsiasi altro genere di figura, possibilmente a colori, di cui un libro sia corredato, per far sì che esso diventi attrattivo nei confronti dei piccoli lettori: raramente un bambino è incuriosito da un libro del tutto sprovvisto di figure, e sarebbe difficile sopravvalutare l’importanza che possono avere dei disegni ben curati, ben colorati, o delle fotografie che non siano meramente descrittive, ma che siano anche tali da evocare, o suscitare, nel bambino, il senso della vastità, del mistero, dell’incanto, travalicando l’ambito specifico di quella particolare lettura. Infatti, per la coscienza del bambino, la dimensione della fantasia è come un immenso regno incantato, e qualsiasi opera letteraria, o qualsiasi libro (anche di tipo manualistico) che egli si trovi fra le mani, ma che sappia far scattare in lui la curiosità per l’ignoto, può trasformarsi in una porta d’accesso a quella dimensione. Le porte d’accesso, potenzialmente, sono innumerevoli: là dove un adulto vede soltanto un romanzo, o un manuale, o, comunque, un libro che risponde a certi requisiti di tipo intellettuale, il bambino vede molto di più e molto più lontano: coglie, niente di meno, un riflesso dell’infinito.
In un certo senso, ciò è vero anche per molti adulti, che hanno conservato più viva, in loro, la facoltà dell’immaginazione, oltre al pre-requisito della capacità di stupirsi. Un adulto che sia appassionato di montagne, ad esempio, nel leggere il libro di un famoso alpinista, resterà tanto più soddisfatto della lettura, se il libro è corredato da fotografie, possibilmente a colori, delle montagne di cui si parla: e quanto più tali fotografie saranno di valore artistico, quanto più avranno saputo catturare ed esprimere la magia delle cime, della neve, dei riflessi di luce, tanto più avranno contribuito a immergere il lettore in quella dimensione parallela alla realtà ordinaria, in cui le emozioni vissute dall’alpinista diventano anche le emozioni provate dal lettore. Un corredo di fotografie che sia pienamente soddisfacente dal punto di vista documentaristico, tecnico e professionale, ma che sia del tutto sprovvisto delle qualità cui abbiamo accennato, non riuscirà a soddisfare altrettanto il lettore, e forse non lo soddisferà per niente.
Il punto è che, per il bambino, tutto — letteralmente – è ancora rivestito della luce smagliante dell’incanto; ogni cosa è capace di parlargli in un suo linguaggio segreto, incomprensibile all’adulto, il quale lo conosceva un tempo, ma poi lo ha scordato. Per convincersene, basta fare un piccolo sforzo della memoria e ritornare a quando, per la prima volta, da bambini, siamo stati colpiti, e, per così dire, folgorati dalla "scoperta" di un certo libro: il più importante di tutti, quello che per primo ci ha rivelato la magia della lettura; quello che ci ha afferrati con tanta forza e intensità, che, sulle sue pagine, ci eravamo dimenticati di ogni altra cosa — perfino di andare a giocare. Siamo ceti che, novantanove volte su cento, a quel ricordo si associno anche delle immagini visive: i disegni, o le illustrazioni di qualunque genere, che corredavano le pagine di quel libro. Chi, da bambino, non si è sentito fremere e turbare davanti ai disegni di un libro di fiabe – il soldatino di piombo; Pinocchio e la fata Turchina — o di avventure, o di viaggi; chi non è stato trasportato fuori del tempo e dello spazio, grazie a quelle parole e a quelle immagini, in un altrove misterioso, dove tutto diviene possibile… ebbene, forse costui non è mai stato davvero un bambino.
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels