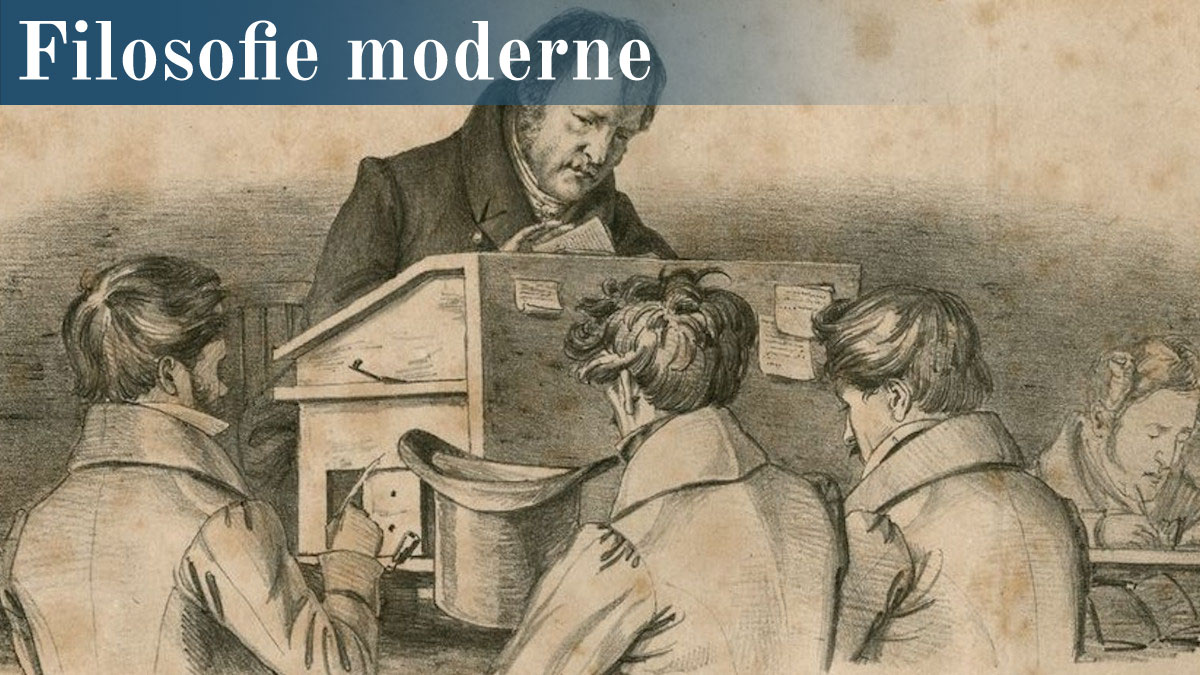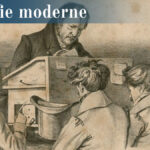
D’Alembert, ovvero la crociata della Ragione contro il preteso oscurantismo religioso
24 Novembre 2015
Per essere credibile, il maestro deve avere un chiaro progetto educativo
24 Novembre 2015Una strana idea, una pericolosa illusione dominano la cultura europea e occidentale, dilagano nell’immaginario collettivo dell’umanità intera: che la tecnica sarà la nostra salvezza, risolverà i nostri problemi e ci provvederà delle macchine mediante le quali potremo assicurarci un futuro fatto di sicurezze, di benessere, di dominio incontrastato sulle cose.
Era pressoché inevitabile che ciò accadesse, vista la piega presa dal pensiero europeo a partire dal XVII secolo, e stante il duplice auspicio dei "padri" della cosiddetta Rivoluzione scientifica: quello di Francis Bacon, secondo il quale «sapere è potere», e quello di Galilei, secondo il quale bisogna «rifare i cervelli» (e non solo il modo di pensare). Tutto quel che è venuto dopo non è stato altro che il prolungamento e l’approfondimento di questa direzione di marcia: l’illuminismo, che vuole portare agli uomini la felicità mediante la ragione e il progresso; il marxismo, che vuol mettere la filosofia con i piedi per terra e rifare il mondo, con l’aiuto delle macchine quali "liberatrici" dalla fatica del lavoro umano; la psicanalisi, con la sostituzione della psiche all’anima e con la pretesa di sostituire il lettino dello psicanalista al confessionale; il positivismo, con la rinnovata fiducia nel progresso tecnico e scientifico; il globalismo e il relativismo, come versioni aggiornate del cosmopolitismo e dello scetticismo illuministici…
Una volta messa la tecnica sull’altare, al posto di Dio, e trasformati gli scienziati, e più ancora i tecnocrati, in altrettanti sacerdoti della nuova religione, e una volta stabilito il principio che non esistono altre forme legittime di adorazione che non siano quelle stabilite dal laicismo democratico e totalitario, fuori dalle quali non v’è salvezza, e nemmeno tolleranza, non rimane alcuna ragione per meravigliarsi davanti allo spettacolo che il dilagare della tecnica, con il suo uso ed abuso di massa, applicato anche alle cose più futili, ha assunto ai nostri giorni: per esempio, del fatto che i bambini abbiano disimparato a sognare e a giocare, cioè abbiano disimparato a essere bambini, perché afferrati dalla dipendenza patologica verso i telefonini cellulari, i computer e gli stessi giochi elettronici (che giochi non sono, ma strumenti di devastazione della mente e del cuore); oppure che dal buono o dal cattivo funzionamento della rete informatica dipendano la pace o lo scoppio della terza guerra mondiale (e sappiamo che già per alcune decine di volte l’umanità ha sfiorato la catastrofe nucleare per gli errori occasionali dei computer preposti al funzionamento degli arsenali atomici delle grandi potenze).
Credendo di semplificare la propria vita, l’uomo si è fatto schiavo del suo stesso tecnicismo: il fenomeno, oggi evidente, non era difficile da preconizzare già alcuni decenni or sono; e infatti poche menti illuminate (quelle sì illuminate, ma non nel senso illuministico del termine) avevano lanciato il loro grido d’allarme, rimasto perfettamente inascoltato, quando non apertamente deriso e sbeffeggiato, dalla maggior pare degli esponenti della cultura dominante, ideologicamente di destra, di sinistra e di centro, tutti d’accordo sul fatto che le macchine rappresentavano il progresso e che il Progresso — divenuto, non si sa come, degno della lettera maiuscola, cioè di essere adorato come un Dio – rappresentava il Bene, dunque che avanzare qualche sia pur timida riserva sulla infallibile efficacia delle macchine quali strumenti della emancipazione umana, era cosa degna dei peggiori nemici dell’umanità, dei trogloditi dell’età della pietra, insomma di quanti non avevano capito nulla della Civiltà e dell’Umanità (e, magari, horribile dictu, non avevano letto, o non avevamo capito, né Voltaire, né Marx, né Freud, e forse nemmeno Gramsci, Marcuse, Adorno, Horkheimer, Sartre, Deleuze, Foucaul, Derrida, Althusser e compagnia bella).
Fra quei rari uomini di cultura e di pensiero che videro e capirono quel che stava succedendo, e quel che ne sarebbe conseguito, e che non subirono il ricatto in base al quale dubitare delle macchine quali punto d’appoggio per l’emancipazione universale equivaleva a opporsi al Progresso e alla Civiltà, vi fu lo scrittore Georges Bernanos (nato a Parigi nel 1888 e morto a Neuilly-sur-Seine nel 1948), autore di una quarantina di volumi, fra i quali spicca il romanzo, giustamente famoso, «Diario di un curato di campagna», pubblicato nel 1936 e poi adattato per il cinema dal regista Robert Bresson (1951).
Così, parlando nell’aula magna della Sorbona nel febbraio del 1947, davanti ad un vasto pubblico, Georges Bernanos, dunque, a un anno dalla morte, benché ancora relativamente giovane (non aveva compiuto sessant’anni), affidava il suo testamento spirituale, che è poi il testamento spirituale di un cristiano, ad una Europa che, pur essendo ancora dolorante per le terribili ferite della guerra, gli appariva già proiettata verso una nuova forma di schiavitù, quella delle macchine (da: Georges Bernanos, «Rivoluzione e libertà»; titolo originale: «La liberté pour quoi faire?»; traduzione dal francese di Gennaro Auletta, Roma, Borla Editore, 1963, pp. 78-81):
«… Noi viviamo in piena frode, siamo vittime d’un inganno. […] Da troppi anni il mondo che Péguy, con una specie di straziante ingenuità chiamava mondo moderno perché non trovava un alto nome, e a dir vero forse non ne merita ancora qualcuno, recita a se stesso la commedia di pretendere di risolvere periodicamente alcuni problemi che è sempre meno capace di porre, per colpa del tempo; perché il tempo è proprio quel che gli manca di più, come se ne avesse diabolicamente ristretto i confini nella stessa proporzione in cui ha avvicinato, con le sue assurde macchine volanti, quelli dello spazio. Noi siamo soffocati dalle menzogne, e non c’è peggior menzogna di un problema mal posto. [..] Questo irrigidimento, questo indurimento, questa sclerosi delle coscienze, questo esaurimento delle profonde sorgenti dell’anima è un fenomeno universale, e da tredici lunghi mesi io l’osservo nel mio paese, in mezzo ai miei, con un’angoscia intima e quasi religiosa, con uno spavento sacro. Dio se ne va, Dio si allontana da noi, e ci lascia a un tempo vuoti e pesanti![…] Prima di osare di parlar di giustizia sociale, cominciate col rifare una società, o imbecilli! Voi avete abbattuto, sotto le bombe, la civiltà di cui avete già distrutto il principio delle coscienze, e la giustizia sociale è per voi un pretesto per liquidare ciò che resta di questo mondo e per depredare finanche i carnai.[…] Quando poco fa dicevo che le peggiori, le più corruttrici menzogne sono i problemi mal posti pensavo proprio a quello che abbiamo la pretesa di esaminare insieme, perché è il tipo stesso del problema mal posto. Una volta c’è stata un’Europa, voglio dire una civiltà europea, e in quel tempo non si parlava o si parlava il meno possibile dello spirito europeo: non ne valeva la pena. A quel tempo le grandi democrazie non avevano ancora inventato il nazionalismo e se i popoli non avevano già molti motivi per amarsi non conoscevano ancora che una piccolissima pare di quelli che avevano per odiarsi. L’avvento dei nazionalismi democratici è stato un colpo fatale per la civiltà europea, l’hanno sommersa e poiché lei non era capace di portare sulle spalle simili mostri, ha cominciato a colare a picco sotto il loro peso. Gli imbecilli potrebbero dire che essa non era abbastanza solida; ma se io avessi voglia di rispondere, direi che una civiltà è stata sempre un’ingegnosa ripartizione di pesi da portare o di problemi da risolvere. Una civiltà umana non potrebbe resistere a qualunque casa, non potrebbe sopportare una qualunque pressione. La civiltà non è solo opera dell’uomo, è l’uomo stesso. Non si può esigere da lei, sia pure col pretesto della giustizia, quel che non è ragionevole esigere dall’uomo. Ma i tecnici non s’imbarazzano per tanto poco; essi sovraccaricano la civiltà umana come gli ingegneri sovraccaricano l’arco maestro d’un ponte per provare il suo punto di rottura. Trovato il punto di rottura, essi ritengono di aver soddisfatto coscienziosamente i termini del loro contratto e ci presentano la nota delle spese. La civiltà europea a somiglianza di tutte quelle che l’hanno preceduta nella storia, era un compromesso tra ciò che è buono e ciò che è cattivo nell’uomo, era un sistema di difesa contro i suoi istinti. Non c’è istinto dell’uomo che non sia capace di rivolgersi contro l’uomo stesso e distruggerlo. L’istinto di giustizia è forse il più pericoloso. Passando dalla ragione all’istinto l’idea di giustizia, per esempio, acquista una prodigiosa capacità di distruzione. D’altronde, in questo caso, essa non è più giustizia come l’istinto sessuale non è l’amore, e on è neanche il desiderio di giustizia ma la concupiscenza feroce e una delle forme più efficaci dell’odio dell’uomo per l’altro uomo. L’istinto di giustizia, quando dispone di tutte le risorse del,a tecnica, si accinge a devastare la terra. Le civiltà corrotte generano dei miti. Si tratta innanzitutto di distruggere questi miti, questi mostri. È ridicolo pretendere di costruire o ricostruire checchessia in un mondo in cui i miti vanno e vengono liberamente facendo tremare il suolo sotto i loro enormi piedi. Se credete veramente possibile edificare una civiltà sulla misura di queste colossali bestie, mi chiedo che cosa stiamo a far qui. Nell’ipotesi un cui un tipo interamente nuovo di civiltà, una civiltà di massa, stesse per uscire dall’anarchia morale e intellettuale d’una società quasi completamente de spiritualizzata, a che pro discutere tra noi dello spirito europeo? Lo spirito dell’antica civiltà europea è condannato per sempre. E quanto allo spirito della nuova, non se ne parla ancora. Per il momento si tratta solo della tecnica. In nessun modo siamo dei tecnici. I tecnici non hanno bisogno di noi. Si tratta di sapere se la storia ha un significato oppure se è la tecnica a dargliene uno. Oppure, per parlare più chiaramente, si tratta di decidere se la Storia è la storia dell’uomo oppure soltanto la storia della tecnica…»
Una civiltà, ammoniva saggiamente Bernanos – mentre quasi tutti gli intellettuali europei si riempivano la bocca con parole d’ordine politicamente corrette, come "tecnica", "progresso", "liberazione", "diritti", "civiltà delle macchine" -, non può sopravvivere se non possiede una essenza spirituale: non può vivere di solo tecnicismo, né di sola economia (e tanto meno di sola finanza, come pure oggi parrebbe che si pretenda).
Lucidissima la sua disamina degli istinti e delle virtù impazzite che diventano schegge destinate a flagellare la nostra civiltà, a sconvolgerla con tutti gli stravolgimenti che l’assenza di "spirito" porta con sé, ad esempio con lo stravolgimento del senso della giustizia, il quale, abbandonato all’ebbrezza di un Logos puramente strumentale e calcolante, senz’anima, senza trascendenza, senza senso del limite, finisce immancabilmente per capovolgersi nella più orribile forma di violenza, nella sete di sangue, nel furore della "santa" ghigliottina, nei totalitarismi folli e negli universi concentrazionari, i quali — rionosciamolo onestamente, una buona volta — altro non sono che l’estrema, lucidissima (e perciò folle) estensione del progetto ultra-razionale, tecnicistico ed efficientistico, di codesto Logos, impazzito per un peccato di orgoglio e di hybris.
Eppure, vien da chiedersi, era tanto difficile — molto, ma molto prima del fungo di Hiroshima, dell’incidente di Chernobyl, delle piogge acide e del buco nell’ozono — era tanto difficile, dicevamo, comprendere che la tecnica non è la soluzione del problema, ma che può esserne l’aggravamento esponenziale, visto che essa è perfettamente insensibile e indifferente ai fini e agli scopi, ma coltiva un progetto di razionalità esclusivamente strumentale? E che, pertanto, nelle mani di una umanità alienata, confusa, smarrita, allucinata, impazzita, si sarebbe trasformata fatalmente in un formidabile mezzo di distruzione e d’imbarbarimento collettivo? Era davvero così difficile prevedere che, se si mettono degli strumenti potentissimi nelle mani di un bambino (cosa che, oggi, sta avvenendo alla lettera), il risultato non potrà essere che catastrofico? E che, pertanto, ciò di cui gli uomini avevano, ed hanno, e sempre avranno bisogno, non è di poter disporre di macchinari sempre più potenti, e di una tecnologia sempre più sofisticata; non è il fatto di saper scindere l’atomo e liberare la sua immensa energia, o inviare satelliti artificiali verso i più lontani pianeti del Sistema solare e anche oltre di esso, nelle immensità della Galassia, ma di pensare e tentar di realizzare un progetto veramente umano, culturale ed educativo, spirituale ed etico, fondato non sulle cose, ma sulla interiorità e sulla coscienza, nonché sulla centralità della persona umana e sul libero arbitrio, cui essa è chiamata?
Come sono stati miopi i nostri intellettuali: credevano di veder lontano, e avevano la vista più corta delle persone umili e semplici. Questo è il più grave atto d’accusa che si possa levare contro di essi, in blocco, come categoria: la loro miopia, il loro piatto conformismo, la loro perfetta inutilità. Sapevano esercitare il loro senso critico solo nei confronti del passato (e con molta esagerazione, ingenerosamente, antistoricamente): mai verso il presente, meno ancora verso il futuro…
Fonte dell'immagine in evidenza: Wikipedia - Pubblico dominio