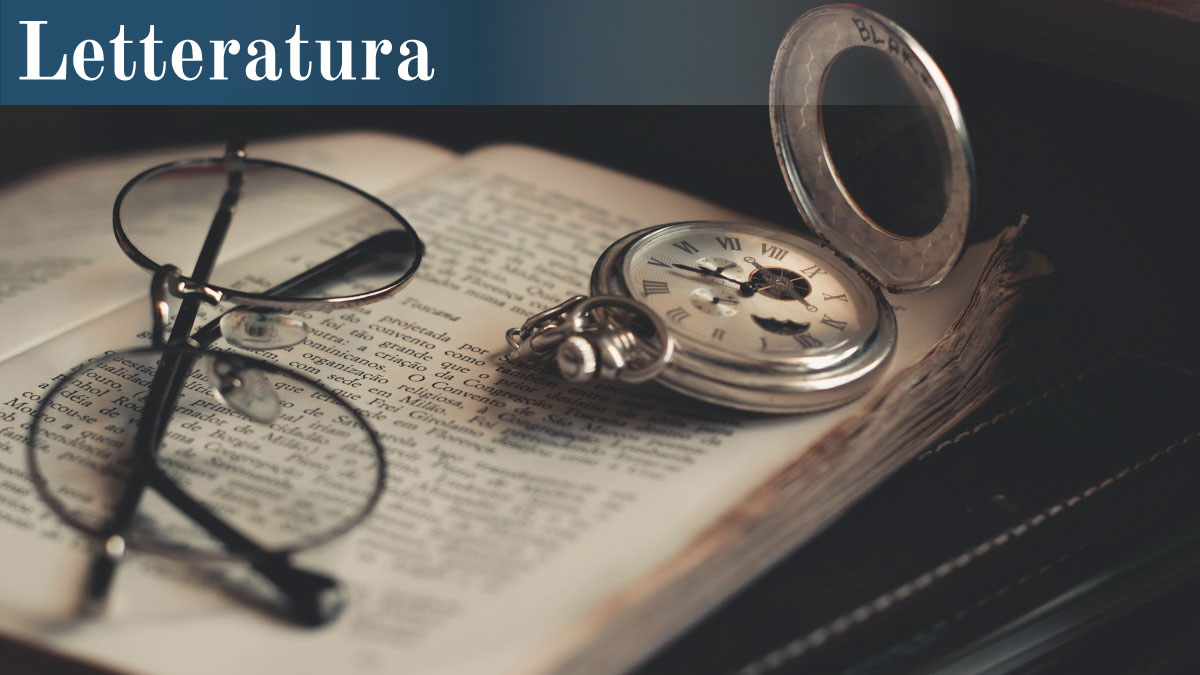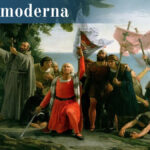
L’Impero ottomano è decaduto perché privo di un’idea e di un’etica
25 Ottobre 2015
Alfred Bassermann, il pellegrino dantesco che rivelò l’Italia di Dante agli italiani
26 Ottobre 2015L’Italia, la sua cultura, la sua arte, la sua poesia hanno sempre affascinato i Tedeschi; specialmente nel XIX e XX secolo vi è stata una autentica fioritura di filologi, storici, dantisti germanici che hanno dedicato all’Italia e ai suoi grandi scrittori una intera vita di studio amorevole ed estremamente accurato e metodico, al punto che si potrebbe affermare che essi hanno addirittura surclassato, per qualità se non per numero, gli stessi italianisti di casa nostra.
Il più grande storico di Roma antica, nel XIX secolo, non è stato un italiano, ma un tedesco: Theodor Mommsen (1817-1903); e i più grandi studiosi della Roma medievale sono stati un tedesco, Ferdinand Gregorovius (1821-1891), e un austriaco, Ludo Moritz Hartmann (1865-1924). Uno svizzero tedesco, Jakob Burchkardt (1818-1897), ha scritto il libro più famoso sull’Italia rinascimentale e un altro sulle maggiori bellezze artistiche italiane; fra i maggiori dantisti della fine del XIX e del principio del XX secolo si sono segnalati altri due tedeschi: Alfred Bassermann (nato a Mannheim il 9 febbraio 1856 e morto a Königsfeld im Schwarzland, nel Baden-Württemberg, il 3 maggio 1935) e Paul Pochhammer (nato a Neisse, in Alta Slesia, il 21 febbraio 1841 e morto a Berlino il 2 marzo 1916).
Di Bassermann, che abbiamo già incontrato nel corso di un precedente lavoro (cfr. il nostro saggio: «Dante e la Venezia Giulia», pubblicato sul sito di Arianna Editrice il 04/05/2006, e, nuovamente su «Il Corriere delle Regioni» il 10/08/2015, oltre che, in formato cartaceo, su «L’Universo», rivista dell’Istituto Geografico Italiano, n. 5, 2006, e sugli «Atti» della Società Dante Alighieri, comitato di Treviso, vol. 5, 2003-2006), intendiamo ritornare con un apposito articolo; ora ci soffermeremo un poco sull’altro dantista germanico, Paul Friedrich Karl Pochhammer, un ufficiale dell’esercito imperiale che dedicò la seconda parte della sua vita a studiare con passione indefessa, ed a far conoscere la «Divina Commedia» ai suoi connazionali.
Il fatto che questo severo ufficiale prussiano si sia totalmente immerso nello studio di Dante dopo aver deposto l’uniforme non è un’eccezione poi così rara (ricordiamo il caso del suo coetaneo, il filosofo Eduard von Hartmann (1842-1906), autore della celebre «Filosofia dell’inconscio», votatosi alla speculazione dopo aver subito un infortunio a ginocchio, che spezzò sul nascere la sua brillante carriera militare) e testimonia l’alto grado d’istruzione del corpo degli ufficiali prussiani ed i loro profondi interessi culturali, contrariamente a quanto il solito cliché antimilitarista e antitedesco vorrebbe far credere; né ci risulta che nel corpo degli ufficiali piemontesi prima, e italiani poi, fossero altrettanto diffusi simili interessi, di tipo non dilettantesco, ma decisamente approfonditi e specialistici.
I Tedeschi, del resto, hanno sempre amato l’Italia, almeno dai tempi di Goethe, che ci ha lasciato un diario di viaggio nella Penisola; e questo amore — ben poco ricambiato – si rifletteva anche nel corpo degli ufficiali prussiani e, poi, in quelli del Reich tedesco (cfr. il nostro precedente articolo: «Germania e Italia, storia di un amore impossibile», pubblicato sul sito di Arianna Editrice in data 03/11/2010, poi su «Il Corriere delle Regioni» il 20/03/2015). Anche Friedrich Nietzsche (1844-1900), ufficiale di artiglieria a cavallo presto passato alla cattedra universitaria (anche per un incidente non meno grave di quello toccato a von Hartmann), amava l’Italia, al punto da averlo eletta a sua seconda patria; e un altro filosofo, Oswald Spengler (1880-1936), ci veniva sovente, prediligendola fra tutti gli altri Paesi d’Europa.
Così Theodor W. Elwert ricorda Paul Pochhammer nella «Enciclopedia Dantesca» (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. IV, 1973, p. 559):
«Traduttore e dantologo tedesco (Neisse 1841 — Berlino 1916); come ufficiale del genio prese parte alle campagne in Danimarca (1864), in Austria (1866), in Francia (1870-71). Iniziato in gioventù allo studio di Dante dallo storico Theodor Paul, negli anni dal 1890 alla prima guerra mondiale operò più di ogni altro tedesco per la diffusione della conoscenza di Dante in Germania. Avendo notato un affievolirsi dell’interesse per Dante dopo il ’70, ne attribuiva la colpa al fatto che i dantisti tedeschi si erano rivolti esclusivamente alle persone di alta cultura; invece il Pochhammer era convinto che la "Commedia" fosse accessibile anche ai meno colti e che occorreva rivolgersi anche a loro. Perciò si accinse a ritradurre la "Commedia" in modo da farne un’opera poetica che equivalesse all’originale, una "Commedia" in veste tedesca, ideale (o miraggio) che animava altri traduttori della sua generazione.
Il Pochhammer scelse l’ottava rima, metro più scorrevole e già provato nella letteratura tedesca, trasponendo liberamente versi e terzine, pur di riprodurre il tono dell’originale. La sua traduzione, cui non si può negare un certo alito poetico, ebbe un notevole successo, con cinque ristampe (1901-1922) della grande edizione (illustrata da H. Vogeler-Worpswede) e cinque ristampe dell’edizione minore 81910-1923). Il Pochhammer compose anche un’introduzione alla "Commedia" in cento stanze che sunteggiavano ciascuna un canto del poema; l’opera fu corredata di cento vignette in stile liberty di Franz Stassen ("Ein Dante-Kranz aus 100 Blättern. Ein Führer durch die Commedia mit 100 Federzeichungen von Franz Stassen", Berlino 1905-1906)Inoltrte pubblicò saggi di carattere divulgativo e apologetico, insistendo sull’affinità tra la "Commedia" e il "Faust" di Goethe.»
Paul Pochhammer si era sposato con una donna più giovane di undici anni, Margarete, che gli aveva dato due figli: un maschio, Hans, nato a Berlino il 14 giugno 1887 (e che sarebbe morto a Eckenförde, nello Schleswig-Holstein, il 7 aprile 1946), e una femmina, Ida. Vale la pena di spendere due parole su Hans, che, come il padre, intraprese la carriera militare, ma che, a differenza di lui, attratto dal mare e dalle navi, entrò nella Kaiserliche Marine, allora in piena espansione per volontà dell’ammiraglio Alfred von Tirpitz (1849-1930), segretario di Stato per il Ministero della Marina; e che fece una brillante carriera di ufficiale, raggiungendo, a soli ventisei anni, l’invidiabile grado di Capitano di fregata e assunse il comandando in seconda d’una splendida unità da guerra, l’incrociatore corazzato «Gneisenau», varato nei cantieri Weser di Brema nel 1906 e gemello dello «Scharnhorst», comandato dal celebre ammiraglio Maximilian von Spee (1861-1914), con il quale formava il nucleo della potente Squadra navale tedesca dell’Estremo Oriente.
Il nome di Hans Pochhammer è abbastanza conosciuto fra gli studiosi di storia militare perché, al termine della Prima guerra mondiale, scrisse un libro in cui rievocava la fantastica traversata del Pacifico da parte della Squadra di von Spee, e le battaglie navali di Coronel e Falkland (rispettivamente del 1° novembre e dell’8 dicembre 1914): «Graf Spees Letzte Seefahrt», pubblicato a Lipsia nel 1924), il quale riveste un particolare interesse memorialistico e documentario, essendo il resoconto del sopravvissuto più alto in grado alla disfatta delle Isole Falkland. Pochhammer, infatti, fu uno dei pochi scampati al naufragio della sua nave e il suo libro, tradotto in numerose lingue, fra cui l’inglese, l’italiano, lo spagnolo, è una delle fonti di prima mano per la ricostruzione di quel glorioso ma, per certi aspetti, ancora oggi un po’ misterioso, capitolo della storia della guerra sui mari (cfr. il nostro saggio: «L’ultima crociera dell’ammiraglio Spee», pubblicato sul sito di Arianna Editrice il 23/08/2007»; e l’articolo: «Con un falso telegramma dello spionaggio inglese von Spee fu preso in trappola alle Falkland», pubblicato su «Il Corriere delle Regioni» il 16/06/2015).
Il «Gneisenau» era partito dalla Germania al principio del 1911 ed era giunto a Tsingtao il 14 marzo, unendosi allo «Scharnhorst» e ai tre incrociatori leggeri «Leipzig», «Emden» e «Nürnberg». Hans Pochhammer lo raggiunse poco prima dello scoppio della guerra e scampò miracolosamente alla morte la sera dell’8 dicembre, quando i marinai britannici dell’incrociatore da battaglia «Inflexible» lo ripescarono dalle gelide acque sub-antartiche, prima che l’assideramento lo paralizzasse completamente, facendolo annegare, come accadde a tanti suoi compagni. Trasportato in Gran Bretagna e rinchiuso in un campo di prigionia, venne poi liberato e poté rientrare in Germania nella tarda estate del 1917, senza aver fatto in tempo a rivedere suo padre, che aveva chiuso gli occhi un anno e mezzo prima, al principio di marzo del 1916. Secondo i dati da lui stesso raccolti durante la navigazione a bordo dell’«Inflexible» (gemello dell’«Invincible», sul quale sventolavano le insegne dell’ammiraglio sir Doveton Sturdee) i sopravvissuti tedeschi erano stati solo 215, su un totale di 2.200 uomini: precisamente, 187 dal «Gneisenau», 18 dal «Leipzig» e 10 dal «Nürnberg», mentre nessuno si era salvato dello «Scharnhorst», compreso von Spee.
Ecco come il giovane Pochhammer ha rievocato, con commosse ma sobrie parole, il rientro in patria, dopo cinque anni di lontananza, circa metà dei quali trascorsi in prigionia, insieme alla figura di suo padre (da: Hans Pochhammer, «L’ultima crociera dell’Ammiraglio Spee. Battaglie navali di Coronel e Falkland»; titolo originale: «Graf Spees Letzte Seefahrt. Sieg und Untergang des Kreuzergeschwaders», Leipzig, 1924; traduzione dal tedesco di Pfüttzer-Gaby-Bauer, Milano, Arti Grafiche Omero Marangoni, 1932, pp. 311-313):
«Approfittai del riposo forzato per scrivere i miei ricordi. E lo feci pensando ai numerosi parenti dei dispersi, coi quali mi era impossibile corrispondere, dato che non ci erano consentite più di due lettere alla settimana. Volli pure esporre i fatti a tutti i nostri fratelli in patria in guisa di renderli edotti con la massima fedeltà possibile, di qualsiasi avvenimento. È molto difficile per un militare combattente, esporre in maniera intelligibile a tutti, quanto si è fatto e sofferto in guerra: si ha quasi il pudore di rivelare qualche cosa di profondamente intimo: tutti i miei camerati, possono perfezionare l’esposizione di questi miei ricordi, ricollegandoli a quanto essi stessi rammentano, per averlo vissuto di persona.
Dopo due anni di cattività, in seguito a uno scambio di prigionieri fui condì dotto in Svizzera e finalmente ricongiunto ai miei. Mio padre era morto in quel frattempo. Il suo vecchio cuore di soldato e di grande ammiratore di Dante ebbe tuttavia l’ultima consolazione di apprendere la nostra vittoria di Verdun. Dopo un nuovo periodo di attesa di 9 mesi, che prolungò la mia assenza dalla patria a cinque anni complessivi, il giorno 1° settembre 1917, potei finalmente varcare la frontiera germanica, a Costanza.
Trovai il paese ben diverso da quando l’avevo lasciato, ma lo vidi agguerrito in ogni particolare, e vittorioso.
Giunsi in tempo per assistere, d’ordine dell’Imperatore, a Danzica, al varo dell’incrociatore di battaglia "Graf von Spee". La possente nave fece il suo ingresso in mare in un giorno di grande vento, simile a quello che aveva soffiato a Coronel. Sua Altezza reale il principe Enrico di Prussia, nel celebrare il battesimo della nuova nave pronunciò queste parole, che io intendo siano pure di conclusione al mio libro.
"Il conte von Spee ha guidato la sua squadra dalla vittoria, sostenendo la lotta per la libertà dei mari. Egli è caduto sulla breccia, e si è immolato con le sue navi e i suoi marinai, combattendo per l’avvenire della Germania".
E che il loro ricordo viva perenne nell’animo del popolo tedesco!»
Può darsi che al lettore del terzo millennio, smaliziato e non più avvezzo al sentimento patriottico, in nome di un cosmopolitismo e di una globalizzazione che sembrano divorare le identità nazionali e le specificità culturali e linguistiche, questo stile risulti un po’ enfatico, sicuramente anacronistico. Dal modo di esprimersi di Hans Pochhammer traspaiono una fierezza, un amor di patria e uno spirito marziale che, oggi, sembrano passati di moda per sempre. Traspare anche il grande amore per la cultura di una colta famiglia tedesca dei primi anni del ‘900, e il vivissimo amore per Dante di un vecchio professore di Berlino, che aveva in cuore anche la pena per il figlio prigioniero.
Questi tedeschi, alla fine, non sono poi così Unni, così malvagi, se visti da vicino: non è forse vero?
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels