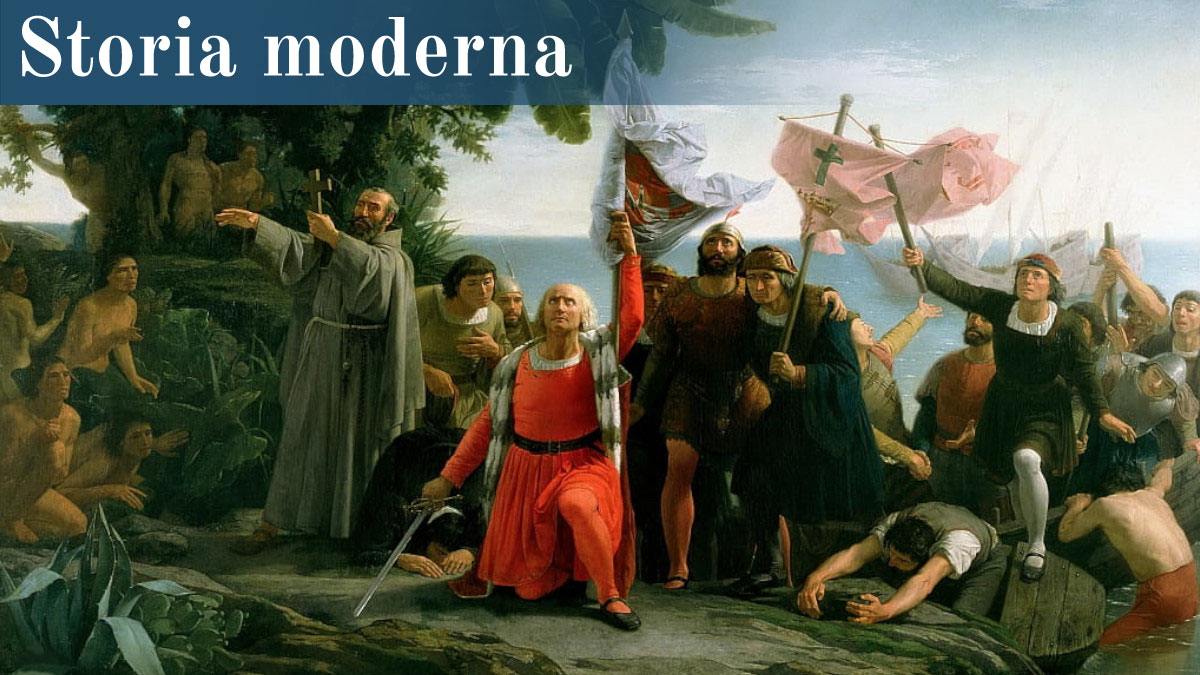La disfatta in Sicilia del 1943 ha schiantato, forse per sempre, l’orgoglio nazionale italiano
23 Ottobre 2015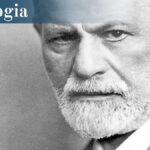
I sogni di don Bosco sono la smentita palese delle teorie freudiane
24 Ottobre 2015Franz Joseph d’Asburgo non amava le novità del mondo moderno e, in modo particolare, la luce elettrica: per cui nel suo grandioso e secolare palazzo della Hofburg le stanze, al crepuscolo, venivano rischiarate con le lampade a cherosene, mentre tutto il resto di Vienna si accendeva alla luce delle lampadine.
Inutile dire che gli storici "progressisti", o che si autodefiniscono tali, hanno visto in ciò la prova provata dell’oscurantismo e dello spirito chiuso e reazionario del vecchio monarca austriaco: perché, per essi, un uomo del XX secolo (ma sappiamo che il XIX secolo si conclude, storicamente, nel 1914) che preferisce le lampade a cherosene all’illuminazione elettrica, non può che essere un nemico del progresso e, dunque, un nemico della civiltà.
Il caso di Franz Joseph e della sua allergia all’elettricità, al telefono, alle automobili, è decisamente emblematico; esso, comunque, permette di porre sul tappeto una questione tutt’altro che oziosa e tutt’altro che secondaria: quali devono, o dovrebbero essere, oggi, le reciproche relazioni fra il mondo della politica e quello della tecnica? È stata una scelta opportuna, quella dei politici, di schierarsi senza riserve dietro le bandiere della tecnica, e di marciare al rullo dei tamburi secondo il ritmo da essa stabilito (e, per forza di cose, continuamente mutato)? O non sarebbe stato meglio se la politica, in quanto tale, avesse assunto una posizione più sfumata e prudente, meno perentoria e impegnativa, evitando di identificare il proprio destino e la propria missione con quella di una realtà ad essa sostanzialmente estranea, come l’evoluzione della tecno-scienza?
Ma, si dirà, la tecno-scienza va avanti comunque, senza chiedere il permesso ad alcuno: e dunque la politica — e qualunque altra realtà umana, individuale o associata — possono solamente scegliere se accodarsi ad essa o scomparire. Non è forse vero che chi non si adegua ai tempi e ai modi della tecnica è destinato ad estinguersi, e in brevissimo tempo, venendo "archiviato" dal divenire storico, proprio come lo furono i dinosauri? Non è forse vero, per esempio, che una politica che non ricorre alla rete informatica — così come una Chiesa che non ricorre alla radio, alla televisione, a Internet — è inevitabilmente destinata a rimanere tagliata fuori? Non è forse vero che perfino i movimenti tradizionalisti e fondamentalisti, come le frange estrema del terrorismo islamico, pur contestando le "diaboliche" novità della tecnica e della scienza, di fatto si servono di esse, ad esempio per diffondere i loro messaggi e i loro filmati?
Ma torniamo a Franz Joseph e alla sua idiosincrasia per la luce elettrica. Ci piace riportare un passo del libro dello storico americano Stephen Kern «Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento» (Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 401-403):
«Trasformazioni sensazionali nel senso della distanza furono create dalla nuova tecnologia dei mezzi di trasporto e delle comunicazioni. Un riconoscimento della minaccia potenziale di quella tecnologia alla società aristocratica dell’impero austro-ungarico è illustrata dalla riluttanza dell’imperatore a consentire i dispositivi di una nuova invenzione nel palazzo imperiale. Educato nel rigido formalismo della vita militare e negli esigenti requisiti di una fra le più antiche dinastie reali superstiti, convinto del suo diritto divino a governare, ostile alle invasioni del governo popolare, socialmente isolato in una cerchia di alta nobiltà e sprezzante verso chiunque fosse di bassi natali, Francesco Giuseppe era una personificazione del mondo gerarchico dell’aristocrazia europea. Nell’Hofburg di Vienna, per seicento anni il palazzo favorito degli Asburgo, egli non consentì le lampadine elettriche e all’illuminazione provvidero le lampade a cherosene. Egli rifuggì l’uso di macchine da scrivere e di automobili e si rifiutò di installare i telefoni. Il telefono, in particolare, era incompatibile con il principio aristocratico che determinate persone, in virtù della loro posizione nella società — in genere la vicinanza al monarca — hanno speciale importanza. I telefoni demolivano le barriere della distanza. In senso orizzontale, attraverso la superficie della terra e in senso verticale attraverso gli strati sociali. Essi istituiscono un’equidistanza di tutti i luoghi dalla sede del potere e di conseguenza un’eguaglianza di valore. La loro istantaneità rendeva superfluo l’elaborato protocollo di presentazioni, biglietti da visita, inviti e appuntamenti; e la penetrazione del loro squillo invadente eliminava la funzione protettiva di porte, sale d’attesa, servitori e guardie. I telefoni penetrano in tutti i luoghi e li rendono così profani: per questo non ci sono affatto nelle chiese. […]
Mentre era soprattutto il telefono a penetrare con invadenza nei santuari del privilegio, numerose altre tecnologie ebbero un effetto analogo, livellando gerarchie tradizionali e creando nuove distanze sociali. Già nel 1913 il cinema fu etichettato come un’"arte democratica", poiché l’occhio della cinepresa penetrava ovunque e i suoi bassi prezzi d’ingresso e la mescolanza nella disposizione dei posti a sedere, inoltre, portavano la cultura intellettuale del teatro alle classi lavoratrici. La bicicletta fu una "grande livellatrice", che colmava lo spazio sociale e rendeva accessibili i viaggi su distanze più lunghe alle classi medie e inferiori, che non potevano permettersi una carrozza o un’automobile. L’effetto democratico dell’automobile fu riconosciuto immediatamente, ancor prima che il suo prezzo si abbassasse alla portata delle masse. L’affollamento delle persone nella città creò un dramma tangibile della nuova democrazia: quando lo status dell’ambiente rurale del mondo aristocratico cedette il passo al nuovo status dell’ambiente urbano della borghesia, si ridusse il valore della distanza nella conservazione del prestigio sociale. Anche la borghesia aspirava ad allontanarsi dalla folla e a ritirarsi nelle tenute in provincia, ma la folla urbana restava, ed era essa a dettare i valori e le nuove norme sociali mentre appiattiva le gerarchie sociali basate sulla distanza.»
Si noti la mancanza di distacco e di oggettività nella ricostruzione del Kern: egli non fa il minimo sforzo per mostrarsi neutrale rispetto alla posizione di Franz Joseph e non esita a istituire la gratuita equivalenza fra il conservatorismo politico (arrivando a dire che la società austro-ungarica è "aristocratica") e il rifiuto della tecnica, percepita dall’imperatore come potenzialmente pericolosa sul piano politico-sociale. E poco importa se Franz Joseph non era affatto un fossile chiuso in una cerchia di alta nobiltà e meno ancora sprezzante verso chiunque fosse di bassi natali: così è necessario che lo dipinga la storiografia "progressista", per renderlo più antipatico e per meglio evidenziare il contrasto con le forze giovani e fresche del Progresso: e dunque è così che il Kern, senza farsi troppo pregare, ce lo rappresenta.
Nella formulazione della sua tesi, vale a dire nella celebrazione del valore "democratico" della tecnica, il Kern gioca costantemente sull’equivoco di suggerire una perfetta coincidenza fra il concetto di aristocrazia in senso sociale ed aristocrazia in senso intellettuale e culturale: di fatto, egli porta il lettore a identificarsi con le istanze democratiche delle masse contemporanee, educate — si fa per dire — alla scuola del liberalismo e delle rivoluzioni americana e francese e convinte che il numero crei il diritto; ma esiste anche un altro modo di concepire la società aristocratica, quello basato sulla convinzione che l’appiattimento delle gerarchie, delle distanze, delle funzioni, sia un male, che non corrisponda affatto agli autentici bisogni e alla stessa struttura delle società umane; e che queste, per sopravvivere e per prosperare, abbiano una estrema necessità, dopo tutto, di vedere realizzata la prevalenza dei "migliori" (tale è il significato originario, in lingua greca, del vocabolo "aristocrazia"), vale a dire dei più creativi, dei più intelligenti, dei più energici, dei più generosi e, in ultima analisi, dei più dotati.
Che l’Europa del primo Novecento fosse ancora il regno dell’aristocrazia in senso economico-sociale, e che, in particolare, lo fosse l’Austria-Ungheria di Franz Joseph, questa è una palese falsificazione storica: ma una falsificazione, come si è detto, necessaria, una volta che si sia stabilito a priori che la democrazia populista e livellatrice è il Bene supremo, vale a dire il Progresso nella sua marcia trionfale, mentre tutto ciò che vi si oppone deve essere, per forza di cose, il conservatorismo, vale a dire il Male.
Il telefono? Ma lo sanno tutti che è un bene, e proprio per le ragioni per le quali Franz Joseph lo detestava: perché introduce un rapporto democratico fra le persone. Chiunque può chiamare al telefono chiunque; le anticamere, i servitori, i tempi d’attesa, vengono scavalcati e annullati: la voce alla cornetta domanda se c’è qualcuno all’altro capo del filo, e può essere la voce di un usciere o di un sovrano, di un plebeo o di un nobiluomo. Chiaro che il telefono ha rappresentato un progresso, se si considera un progresso il fatto che tutti abbiano uguali diritti, indipendentemente dai meriti e dal valore personale. Non c’è bisogno di prendere appuntamenti, per parlare al telefono: esso squilla democraticamente in casa della persona chiamata, a qualsiasi ora, del giorno e della notte, domeniche e feste comprese.
Stesso discorso per l’automobile. Essa ha ulteriormente "livellato" il paesaggio sociale, appunto perché ha messo alla portata di molti (e, alla fine, pressoché di tutti) il fattore spazio: prima, chi non aveva una carrozza a cavalli doveva rassegnarsi a non viaggiare. Perfino la bicicletta può essere vista come l’inizio della democratizzazione pratica della società: grazie ad essa, qualsiasi persona, anche appartenente alla classe lavoratrice, è stata in grado di coprire piccole e medie distanze che, prima, l’avrebbero rinchiusa e confinata nel suo ambito ristretto. Grazie alla bicicletta, un lavoratore residente in campagna poteva recarsi in città al mattino e tornare a casa alla sera: non era più costretto a cercarsi da vivere nei pressi del suo paesello, non era più tagliato fuori dalle opportunità sociali offerte dalla metropoli.
Le distanze, nella società del primo Novecento, investita in pieno dalla "fiumana del progresso" di verghiana memoria, si sono accorciate, secondo gli storici come Spehen Kern, perché ormai il baricentro della vita sociale si era spostato dalla campagna alla città, dall’aristocrazia alla borghesia; e la tecnica, in ciò, ha svolto una funzione di prim’ordine. A quanto pare, al Kern e ai suoi simili non viene minimamente in mente che la tecnica possa avere anche dei risvolti negativi; o che le classi dominanti cambiano e si avvicendano, ma troveranno sempre il modo di annullare l’apparente democratizzazione dovuta al progresso tecnico, mediante il controllo e la proprietà della stessa produzione tecnologica. Nella loro visione ingenuamente manichea, danno per scontato che tecnica, progresso e democrazia siano sinonimi e che la politica debba essere favorevole al trinomio; e lì si fermano, proprio dove sarebbe compito dello storico cominciare a riflettere.
La luce elettrica, certo, è un bene. Però, annullando i tempi naturali del lavoro, rende possibili i turni lavorativi notturni, che non sono un bene per la salute dei lavoratori, né per l’armonia delle famiglie: con mariti e mogli che si incrociano, quasi per sbaglio, solo all’inizio e alla fine dei rispettivi turni e, per il resto, fanno praticamente vita separata e solitaria. Anche il telefono è un bene. Però è innegabile che non è simpatico ricevere dieci o venti telefonate al giorno da parte di ditte o agenzie commerciali che propongono ogni sorta di pubblicità, disturbando il pranzo o il sonno delle persone o creando tensione in chi vive nell’ansia d’una sinistra telefonata dall’ospedale ove ha ricoverati i propri cari. Anche l’automobile è un bene, chi potrebbe negarlo? Però il suo dilagare, la sua invadenza, la sua furia scatenata, indubbiamente causano problemi di traffico, di inquinamento, di rumore, di sovreccitazione nervosa, di pericolo fisico, sia per i conducenti che per i pedoni (sono legione i morti quotidiani sulle strade, sacrificati all’altare del progresso); e il culto che le viene tributato rischia di dar vita ad una nuova religione materialistica, ove si adorano le vetture nuove e scintillanti e si trascurano sempre più le persone, i valori, i sentimenti…
Tutto questo è passatismo? Può darsi. In ogni caso, il compito del politico non è, né può essere, quello di suonare la fanfara per il vincitore del momento. Il fatto che la società odierna sia fortemente caratterizzata in senso tecnologico, non deve farci perdere di vista che la tecnologia non è il fine, ma un mezzo; e che, pertanto, l’atteggiamento che si assume verso di essa non può e non deve essere quello di una adorazione incondizionata, ma quello vigile e critico, che sempre si addice in presenza di cose strumentali: che non sono buone o cattive in se stesse, ma secondo il loro uso…
Fonte dell'immagine in evidenza: Immagine di pubblico dominio