
Può un disegno diventare un essere vivente e uscire dalle pagine d’un libro?
23 Ottobre 2015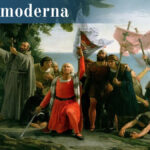
Francesco Giuseppe e l’elettricità, ovvero: quale relazione fra politica e tecnologia?
24 Ottobre 2015La disfatta in Sicilia del 1943 ha schiantato, forse per sempre, l’orgoglio nazionale italiano

C’è modo e modo di perdere una guerra; si può perderla con onore e si può perderla con vergogna: il modo in cui l’Italia ha perso nella seconda guerra mondiale, e il modo in cui le sue Forze Armate sono state sconfitte nell’ultima battaglia, quella di Sicilia del luglio-agosto 1943, appartiene senza dubbio alla seconda tipologia.
Ha osservato Mario De Monte, capo dell’Ufficio B (preposto alle intercettazioni e alla crittografia) del Servizio Segreto della Regia marina durante l’ultimo conflitto mondiale (da: M. De Monte, «Uomini ombra. Ricordi di un addetto al Servizio Segreto navale, 1939-43», Roma, Nuova Editoriale Marinara Italiana, 1955, p. 85):
«Sono passati molti anni da allora, eppure i ricordi sono vivi nella mia mente come se fossero passati solo pochi giorni. Forse la mia vera vita cessò quell’8 settembre 1943, nel quale tanti italiani esultarono perché cessava l’incubo della guerra ed attendevano dai nemici di ieri la Libertà ed il Benessere, e molti di meno piansero, pensando agli inutili morti, agli inutili sacrifici, alle mutilazioni, che ci sarebbero state inflitte, ed all’orgoglio nazionale, infranto forse per sempre.»
Un onesto bilancio della campagna di Sicilia da parte italiana, ma fatto da un saggista anglosassone, è quello di Hanson G. Baldwin (da: H. W. Baldwin, «La caduta di Corregidor; la battaglia di Stalingrado; la campagna di Sicilia»; titolo originale: «Battles Lost and Won: Great Campaigns of World War II», 1966; traduzione dall’inglese di Vittorio Ghinelli, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1971, pp. 220-2):
«Per gli italiani, la Sicilia non rappresentò certo un capitolo glorioso. I tedeschi non nascosero il loro profondo disprezzo nei riguardi degli alleati italiani, e nei loro resoconti post-bellici affermarono addirittura, non senza una certa esagerazione, che in Sicilia gli italiani si erano virtualmente astenuti dal combattere. È indubbio, comunque, che essi fecero ben poco — quanto poco, probabilmente la storia non riuscirà mai a stabilire.
Morison riconosce loro meriti non trascurabili per la sfortunata difesa della Sicilia, meriti peraltro sproporzionati a quelli effettivi (S. E. Morison, "History of United States Naval Operations in World War II", vol. IX, "Sicily, Salerno, Anzio, January 1943 — June 1944", Boston, 1954).
In genere i tedeschi sistemano la faccenda in modo un po’ troppo sbrigativo; tra gli altri spicca per imparzialità il seguente giudizio: "Anche se qualche comandante era ancora desideroso di battersi e se alcune unità italiane (quelle di artiglieria, ad esempio) continuarono a dare buona prova di sé, nulla restava in termini di leadership coordinata e di efficienza di combattimento. Il soldato italiano era esausto, stanco di una guerra di cui non vedeva gli scopi, e indisciplinato. Di conseguenza, sul campo di battaglia quasi tutte le unità italiane si rivelarono più di peso che di aiuto".
Il già citato studio ufficiale "Operations in Sicily and Italy" parla della "defezione generale di truppe italiane che disertavano e si arrendevano alla prima occasione. Nel giro di dieci giorni la Sesta armata italiana cessò di esistere come vera forza di combattimento". Eppure alcune unità italiane si batterono con determinazione e molti contadini in uniforme che ben poco sapevano delle ragioni di quella guerra e del perché essi stessi vi partecipassero, morirono invano.
A quanto pare, nonostante le sue scarse doti di comandante, il generale Guzzoni seppe prevedere con più esattezza di Kesselring le intenzioni alleate. Fu per l’insistenza di Kesselring che pochi giorni prima dell’invasione il grosso della Quindicesima divisione Granatieri corazzarti, in precedenza dislocato nella Sicilia orientale, fu trasferito nelle regioni occidentali dell’isola. Kesselring riteneva che gli Alleati avrebbero sferrato il loro attacco anfibio a ovest, mentre Guzzoni riteneva più probabile la zona sud-orientale. I fatti diedero ragione a Guzzoni, e all’errore di Kesselring risale in parte la responsabilità di "un’iniziale dispersione delle forze dell’Asse che ridusse sensibilmente la loro capacità di opporre un’efficace difesa". Tuttavia a posteriori appare chiaro che le forze dell’Asse disponibili non avrebbero avuto comunque alcuna probabilità di respingere l’attacco alleato: il rapporto di forze era troppo sfavorevole ai tedeschi.»
Sono giudizi per noi mortificanti, ma sostanzialmente condivisi dalla stragrande maggioranza degli storici militari della Seconda guerra mondiale. La verità è che, nonostante alcune lodevoli eccezioni — tanto più lodevoli in quanto così rare — l’esercito italiano, nella sua ultima battaglia in difesa della Patria invasa, diede una pessima prova di sé, e, dopo qualche giorno di resistenza nella zona costiera, praticamente smise di battersi, lasciando ai Tedeschi quasi tutto il peso della lotta per ritardare l’avanzata anglo-americana. Era un bilancio totalmente fallimentare, se si pensa che, nell’autunno precedente, ad El Alamein, le nostre truppe si erano battute, nel complesso, in maniera più che valida, in certi casi perfino eroica, stante l’enorme sproporzione con l’armata britannica di Montgomery; e che appena pochi mesi prima dello sbarco in Sicilia, nella campagna di Tunisia, le nostre truppe avevano scritto nuove pagine di valore, suscitando l’ammirazione sia dei tedeschi alleati, sia dei nemici.
Ora, a parte la questione puramente strategica, se sia stato intelligente oppure no consumare, nella inutile campagna di Tunisia, il meglio di quel che restava del nostro esercito, invece di predisporre e concentrare le forze in vista della difesa del suolo patrio, resta il fatto che, nel luglio del 1943, le operazioni in Sicilia mostrarono un irreparabile livello di degrado, morale prima ancora che materiale, del nostro esercito; una mai vista indifferenza rispetto al fatto che, per la prima volta dall’inizio della guerra, si combatteva non per conquistare, o difendere, delle posizioni su fronti lontani, ma per proteggere il suolo della Patria invasa, mentre ben diversa era stata la reazione dell’esercito nel novembre del 1917, sul Piave, all’indomani del disastro di Caporetto; e che molti reparti, a cominciare dai comandi, mostrarono una deprimente attitudine a consegnare le armi al nemico non appena possibile, ad arrendersi in massa, considerando la guerra conclusa, e quasi salutando l’arrivo dei nemici come fossero dei liberatori. Il tutto reso ancor più tetro e avvilente dal ritorno in forze della mafia, dalla ostentata arroganza dei capi mafiosi, dal loro ingresso, largamente favorito dagli occupanti, nelle amministrazioni locali, prendendo così nelle loro mani il controllo della vita civile nei comuni "liberati".
L’aviazione, intanto, faceva quel che poteva: gli aerei italiani si libravano solitari nei cieli, contro venti, cinquanta aerei nemici: era una lotta eroica, ma assolutamente disperata. Altro discorso per la marina. La marina, nonostante tutto, era ancora potente: a corto di nafta, a corto di munizioni, sprovvista di radar e portaerei, avvilita dalla lunga inattività, o, per dir meglio, dal fatto che le grosse navi di cui andava fiera, le corazzate e gli incrociatori pesanti, da molto tempo avevano rinunciato a uscire dalle loro basi per cercare il nemico e affrontarlo in mare aperto: in pratica, dai tempi della disgraziatissima battaglia di Guado e Capo Matapan. Le ultime due battaglie parzialmente vittoriose, peraltro con il massiccio aiuto germanico, quella di Mezzo Giugno e quella di Mezzo Agosto del 1942, erano state battaglie aeronavali, e la marina vi aveva partecipato soltanto con naviglio leggero e sommergibili.
Ora che, con la fine della campagna di Tunisia, l’invasione dell’Italia era imminente, la marina avrebbe potuto gettare tutto il suo peso per contrastare lo sbarco alleato: quasi certamente sarebbe stata decimata, però avrebbe reso dura la vita agli attaccanti. Li avrebbe ammoniti che la campagna di Sicilia (la campagna d’Italia non era nemmeno nei loro programmi, nel luglio del 1943) non sarebbe stata una passeggiata: che gli Italiani avrebbero lottato con le unghie e coi denti. I Giapponesi, in condizioni analoghe, decisero di gettare nella lotta tutto il peso della loro flotta, nella gigantesca battaglia del Mar delle Filippine (19-20 luglio 1944): flotta che venne in gran parte distrutta, ma il cui sacrificio produsse, se non altro, un effetto morale non indifferente. Per gli Americani, fu un monito: monito rinnovato con le operazioni per la conquista di Iwo Jima (febbraio-marzo 1945) e di Okinawa (marzo-giugno 1945).
Per l’esercito e la marina italiana, il test fu la battaglia per la conquista alleata di Pantelleria (giugno 1943); o meglio, fu la resa inopinata della piazzaforte, senza che una battaglia vi fosse stata, perché il bombardamento aereo fu sufficiente a indurre il comando italiano alla resa, con le difese strutturali ancora intatte e con le scorte di viveri e munizioni più che sufficienti. La marina italiana non si fece vedere: mai una piazzaforte era caduta in maniera più surreale. Un mese dopo, quando fu la volta della Sicilia, gli invasori avevano già una certa idea su che tipo di resistenza, o piuttosto su quale mancanza di resistenza, avrebbero incontrato. E così fu.
Forse nemmeno loro, tuttavia, si aspettavano di vedere lo spettacolo incredibile di un esercito che si liquefa al primo urto; di un fuggi fuggi generale; di una fretta di arrendersi quasi più forte di quella di avanzare dell’esercito invasore (la resa della poderosa piazzaforte di Augusta, senza colpo ferire, fu l’avvilente replica della resa di Pantelleria); di una quantità di cittadini, dalla dubbia moralità pubblica, che corrono ad offrire i loro servigi in qualità di collaborazionisti; di una popolazione civile che non si vergogna di mendicare scatolette di conserva e pacchetti di sigarette, come se fosse la cosa più naturale del mondo correre a mettersi sotto le ali protettive di un nemico che avanza fucilando i prigionieri (perché questo fu ciò che accadde, nei primi giorni dello sbarco, specialmente nel settore americano), bombardando le città inermi e avendo dichiarato – fin dalla conferenza di Casablanca del gennaio 1943 – che non avrebbe concesso alcuna tregua fino alla resa incondizionata del Tripartito, Italia compresa.
Quel che accadde dopo lo sbarco anglo-americano in Sicilia, il 25 luglio e l’8 settembre del 1943, resterà scritto per sempre negli annali del disonore. La vulgata storiografica da allora dominante ha cercato di contrabbandare quelle pagine vergognose come le necessarie premesse della rinascita nazionale; e di falsificare la realtà, asserendo che la "guerra di liberazione", ossia la guerra civile, restituì onore e dignità al nostro esercito e al nostro popolo, consentendo il suo ingresso a testa alta nel novero delle nazioni libere e democratiche. Ma la realtà è che la cosiddetta Resistenza è sempre stata subalterna alla strategia militare alleata, che era la strategia di un esercito invasore ed occupante (e che l’Italia fosse una nazione vinta e occupata, fu sancito dal trattato di pace di Parigi del 1947: altro che essere divenuti amici dei "liberatori"!). Per fare solo un esempio: il tragico rastrellamento tedesco sul Monte Grappa, nel settembre del 1944, fu la conseguenza del cinismo con cui gli Inglesi, per favorire le loro operazioni militari sulla Linea Gotica, distraendo forze tedesche e repubblichine, incoraggiarono ad andare al massacro dei reparti partigiani assolutamente insufficienti e impreparati — e ciò, paradossalmente, dopo che i Tedeschi avevano fatto sapere, per via ufficiosa, che avrebbero consentito a "quei bravi ragazzi" di evacuare la montagna e tornare alle loro case, lasciando un varco aperto prima di cominciare l’offensiva.
Come vide benissimo Mario Del Monte, perdere la guerra in quel modo fu una autentica tragedia per il nostro Paese, in un certo senso ancor più grande che se l’Italia si fosse battuta strenuamente e avesse sofferto quanto soffrirono la Germania e il Giappone nelle ultime fasi della lotta. E ciò, appunto, per almeno quattro ragioni: la prima, che gli Anglo-americani venivano, sì, a portare la Libertà e il Benessere, ma alle loro condizioni: ossia da nemici occupanti e non certo da liberatori; la seconda, che i morti e i sacrifici fatti venivano resi inutili dalla resa codarda e da quel voltafaccia politico, offendendo la memoria dei morti e disprezzando l’eroico impegno dei vivi; la terza, che l’Italia sarebbe stata trattata da Paese vinto, e quindi mutilata, come infatti accadde (con la Venezia Giulia, le colonie, la flotta); la quarta, che l’orgoglio nazionale ne uscì infranto per sempre. Da allora, infatti, non si è più visto un segno di fierezza né da parte dei governanti, né dell’opinione pubblica. La vicenda dei due marò, sequestrati in India tre anni e mezzo fa, è a suo modo esemplare.
Fonte dell'immagine in evidenza: Wikipedia - Pubblico dominio