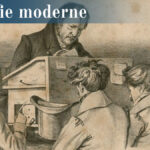
Darwin affronta la religione da uomo piccolo, con idee banali, povere e superficiali
28 Luglio 2015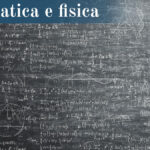
Galilei, padre nobile della scienza sperimentale, non si abbassava a fare gli esperimenti
28 Luglio 2015In che relazione stanno la politica e l’ideologia, da un lato, e la politica e l’utopia, dall’altro? La politica deve fondarsi sul principio di realtà, sulla "verità effettuale" (come voleva Machiavelli; che però non era coerente con se stesso), o sui bisogni e sulle aspirazioni dell’uomo, compresi quelli meno immediati e visibili, ma anche più veri e profondi?
Per Karl Mannheim (Budapest, 1893-Londra, 1947), il celebre sociologo tedesco di origine ungherese, poi naturalizzato inglese – che fu discepolo di György Lukács e si distaccò gradualmente dal marxismo, venendo anche attaccato dalla Scuola di Francoforte – l’ideologia è il sistema di pensiero caratterizzato da valori e da mezzi d’interpretazione che sono validi all’interno di una data cultura, e solamente in essa. Ed è proprio qui che si è consumata la sua rottura con Marx: poiché il marxismo sostiene che tutte le culture sono il prodotto di un certo ambiente economico e sociale, sembrerebbe che solo esso possa trascendere il relativismo delle culture e porsi come norma e valore superiore ad ogni altro: ma questo è impossibile, a meno di entrare in contraddizione con se stesso, perché anche il marxismo è un prodotto culturale e, dunque, non può rivendicare per sé, e per sé solo, una assolutezza e una normatività che lo pongano al di là e al di sopra di tutti gli altri sistemi culturali. Mannheim rifiuta il relativismo, ma rifiuta anche il marxismo come spiegazione universale dei fatti sociali: pertanto non gli resta che opporre a tale relativismo un altro principio normativo, il relazionismo: se ci sia riuscito oppure no, è cosa che qui non intendiamo approfondire.
L’utopia, invece, per Mannheim, è un tentativo di trascendere le condizioni sociali e culturali esistenti, ma realizzando, almeno in parte, la sua carica innovativa ed eversiva; laddove l’ideologia, anche se si propone di trascendere la situazione "de facto", in pratica non vi riesce mai, perché rimane pur sempre all’intero della situazione e, in ultima analisi, è funzionale alla sua conservazione. Mannheim fa l’esempio del cristianesimo, che, se pur nato come trascendimento, se non come eversione deliberata, dell’ordine esistente, nel Medioevo viene "recuperato" dalle forze sociali dominanti, Chiesa e potere feudale, per dirottare verso l’Aldilà le sue istanze di riforma radicale e di completo rinnovamento dei rapporti umani. E qui viene fuori, in tutta la sua greve pesantezza e mancanza di originalità, la "forma mentis" dello studioso marxista, che non sa, non può o non vuole liberarsi da quanto vi è di più ottuso nel pregiudizio marxista nei confronti della religione, e di quella cristiana in particolare.
Il cristianesimo è pur sempre l’"oppio dei popoli", perché, anche se aspira a un ordine umano diverso e più giusto, basato sulla fratellanza e sull’amore, non osa poi tradurre in pratica, coerentemente, i propri principi, e si accontentato di deviare verso la vita futura quel rinnovamento che, in questa vita terrena, viene di fatto negato e sconfessato. Evidentemente, anche Mannhem si immagina che una nuova religione, dopo aver fatto il miracolo di modificare i costumi e l’etica corrente, sino a far entrare nelle coscienze il valore sacrale della vita umana e la sua insopprimibile dignità, possa e debba anche procedere a una riforma politica e sociale, per imporre, con la forza delle leggi o delle armi, la sua concezione del mondo. Non riconosce al cristianesimo il merito di aver fatto abolire i combattimenti dei gladiatori, né quella di aver difeso il principio della libertà morale anche in faccia al potere politico; non considera che la scomparsa graduale della schiavitù possa aver avuto origine (oltre che dalle mutate condizioni economiche e politiche nell’età tardo-antica) anche dalla nuova etica diffusa dal cristianesimo; né riconosce al cristianesimo la condanna, specialmente agostiniana, della guerra ingiusta e del potere ingiusto, perché fondato unicamente sulla violenza. S’immagina che i cristiani, dopo Costantino, abbiano avuto in mano la bacchetta magica per introdurre anche nella società una radicale riforma solidaristica ed egualitaria; ed, evidentemente, imputa a malvolere e ad ipocrita egoismo il fatto di non averlo tentato — dimenticando, fra l’altro, che una religione non è una dottrina politica e che l’Altro mondo, per essa, non è l’evasione nel regno dell’oppio, ma la dimensione vera del reale, rispetto alla quale la dimensione materiale è solo vanità ed apparenza.
Scriveva, dunque, Karl Mannheim nella sua importante opera «Ideologia e utopia» (titolo originale: «Ideology and Utopia», Harcourt, Brace & Co., New York- Routledge & Kegan, London, 1953; traduzione dall’inglese di Antonio Santucci, Bologna, Il Mulino, 1957, pp. 194-198):
«Una mentalità si dice utopica quando è in contraddizione con la realtà presente. Questa incongruenza appare evidente ogni qualvolta un tale atteggiamento si orienta, nell’esperienza, nella riflessione e nella pratica, verso oggetti che non esistono nella situazione reale. Tuttavia, non considereremo come utopico ogni stato della coscienza che contrasta e trascende la realtà immediata (e in questo senso, "se ne allontana"). Utopici possono invero considerarsi soltanto quegli orientamenti che quando si traducono in pratica, tendono, in maniera parziale o totale, a rompere l’ordine prevalente. Nel circoscrivere il significato del termine "utopia" a quel tipo di orientamento che trascende la realtà e insieme spezza i legami dell’ordine esistente, s’impone una distinzione tra gli stati della mente utopici e quelli ideologici. Uno può orientarsi verso oggetti che sono estranei alla realtà e che trascendono l’esistenza attuale — e nondimeno concorrere al consolidamento dell’ordine di cose esistenti. Nel corso della storia, l’uomo s’è più spesso rivolto a fini che trascendono la sua vita che non invece a scopi immediati e presenti e, ciò malgrado, le forme concrete della vita sociale si sono formate sulla base di tali orientamenti ideologici che erano in contrasto con la realtà. Un tale orientamento divenne utopistico solo quando tese a rompere i legami dell’ordine esistente. Di conseguenza, gli esponenti di un determinato asserto sociale non assumono in tutti i casi un’attitudine ostile verso gli indirizzi trascendenti la realtà esistente. Piuttosto, essi hanno sempre mitrato a controllare quelle idee e quegli interessi che non sono utilizzabili nella situazione presente e a renderli socialmente impotenti, così da confinarli in un mondo fuori della storia e della società, dove non possono intaccare lo "status quo".
In ogni periodo della storia vi sono state idee trascendenti l’ordine esistente, ma esse non assolvevano la funzione di utopie: esse costituivano piuttosto, nella misura in cui erano armoniosamente e organicamente integrate con la visione prevalente nell’epoca e non suggerivano possibilità rivoluzionarie, le ideologie più adeguate del periodo. Finché l’ordine medievale, organizzato su basi clericali e feudali, fu capace di situare il suo paradiso fuori della società, in una sfera sovra mondana che trascendeva la storia e attenuava le sue punte rivoluzionarie, l’idea del paradiso rimase ancora un elemento essenziale della società medievale. Soltanto quando certi gruppi sociali trasferirono queste aspirazioni nella propria condotta e cercarono di realizzarle, queste ideologie si tramutarono in utopie. Se, per il momento, seguiamo la terminologia di Landauer, e opponendoci all’usuale definizione, chiamiamo ogni ordine sociale "topia" (dalla parola greca "topos"), queste aspirazioni che assolvono una funzione rivoluzionaria divengono utopie. È chiaro che un determinato concetto della "realtà" e della sua trascendenza , sta alla base della precedente distinzione. […] In quanto l’uomo è una creatura vivente anzitutto in un mondo storico e sociale, la realtà che lo attornia non è mai una "realtà in sé", ma è sempre una concreta forma storica di esistenza sociale. Per il sociologo, l’"esistenza" è data da ciò che è "concretamene effettivo", ovvero da un ordine sociale in atto, che non esiste soltanto nella immaginazione di certi individui, bensì suggerisce reali modelli di comportamento. […]
Tutte quelle idee che non riescono a inserirsi positivamente nella situazione sono "situazionalmente trascendenti" ovvero irreali. Le idee, che invece corrispondono all’ordine concretamente esistente e "de facto", possono venire indicate come adeguate e congruenti. […] Le ideologie sono idee situazionalmente trascendenti che non riescono mai "de facto" ad attuare i progetti in esse impliciti. Sebbene esse speso si presentino cime giuste aspirazioni della condotta privata dell’individuo, quando poi sono tradotte in pratica, il loro significato viene molto spesso deformato. L’idea dell’amore fraterno cristiano, ad esempio, rimane, in una società fondata sulla servitù, un’idea irrealizzabile e perciò ideologica, anche quando il suo significato costituisca, per chi lo intende in buona fede, un fine per la condotta individuale. Vivere coerentemente a questo amore cristiano in una società che non sia organizzata sul medesimo principio è impossibile. L’individuo, nella sua condotta privata, è sempre destinato — finché non risolve di rompere la struttura sociale esistente — a non realizzare i suoi più nobili scopi. […]
Anche le utopie trascendono la situazione sociale, in quanto orientano la condotta verso elementi che la realtà presente non contiene affatto. Ma esse non sono ideologie, non lo sono nella misura e fino a quando riescono a trasformare l’ordine esistente in uno più confacente con le proprie convinzioni. […] Ciò che in un caso appare utopico o ideologico dipende essenzialmente dallo stato e dalle condizioni della realtà cui si applica questo modello. Mentre quegli strati, che rappresentano l’ordine sociale e intellettuale prevalente, concepiranno come una vera realtà quella struttura di relazioni di cui essi sono i sostenitori, i gruppi che si oppongono a tale assetto saranno spinti verso quell’ordine sociale per cui lottano e che si viene realizzando con loro. I rappresentanti di una determinata situazione indicheranno come utopiche tutte le concezioni della realtà che, dal proprio punto di vista, non potranno mai venire attuate. Conformemente a ciò, con il termine moderno di "utopia" s’intende generalmente un’idea che è irrealizzabile in via di principio. […] Noi useremo questo termine in un senso relativo, intendendo per utopia soltanto ciò che sembra inattuabile dal punto di vista di un determinato ordine sociale già affermato.»
Certo, nel clima oggi dominante, quando vediamo che gli stessi intellettuali cristiani parlano del cristianesimo più come di una ideologia, che come di una religione, il discorso di Mannheim appare moderno, aggiornato, fecondo: solo se si demistifica la sua pretesa di equiparare il cristianesimo a una ideologia ci si accorge di quanto sia sbagliato, irrealistico e pretestuoso.
Chi lo dice che le ideologie sono prigioniere dell’esistente, e le utopie no? E, ammesso e non concesso che sia così, chi lo dice che la utopie sono più nobili e più progressive delle ideologie? Non è forse vero che, se qualcuno riuscisse a realizzare la Repubblica di Platone, o la Città del Sole di Campanella — tanto per fare un paio di esempi — avrebbe con ciò creato uno dei peggiori universi totalitari e concentrazionari che mai si siano visti al mondo? Gli utopisti sono dei rivoluzionari-poeti, che sognano un mondo più bello; ma il sogno fa presto a trasformarsi in un terribile incubo (lo abbiamo visto e rivisto, fino alla sazietà), se nasce dalla pretesa di sopprimere le aporie e le antinomie della vita. La vita è piena di aporie e di antinomie, perché l’uomo ne è la quintessenza: impossibile, dunque, che le società umane non riflettano tale ambivalenza.
Non si vuol dire, con ciò, che ogni slancio verso un mondo migliore sia sbagliato in se stesso; al contrario, è un gran bene: e guai a quella politica che non sappia anche sognare, almeno un poco. Ma i sogni di un mondo perfetto lasciamoli ai poeti (e, sia detto per inciso, ai poeti di bassa lega); a chi pensa la politica, tocca il dovere di pensare il reale in termini costruttivi, propositivi, anche idealistici, ma senza mai negare i fatti. I fatti non si negano: e l’imperfezione umana, la sofferenza legata alla condizione umana, sono dei fatti: non bisogna discuterli, ma, semmai, tentare di spiegarli ed assumerli in un più ampio e comprensivo orizzonte di senso.
Ecco perché la politica, come ogni altro sapere, non può non essere una ricerca della Verità. L’uomo è caratterizzato da una tensione ontologica verso l’assoluto: la nostalgia che ha di esso ne è la prova ed il segno inconfondibile. La politica, perciò, deve pensare l’uomo come un essere in cammino verso la sua patria vera, verso la sua dimensione piena: che non è quella terrena. Pertanto, essa non deve sopravvalutare la ricerca del miglioramento delle condizioni di vita materiali; tale ricerca è certamente legittima, ma — soddisfatti i bisogni fondamentali — non è, né deve essere, lo scopo principale dell’esistenza umana; e, dunque, nemmeno della politica. La verità è l’accordo fra la cosa e il giudizio: ora, la politica deve guardare alla condizione umana con verità, ossia riconoscendovi un dover essere, una tensione spirituale, un radicato bisogno di trascendenza. Deve riconoscerlo, non soddisfarlo: perché questo non tocca ad essa, ma alla filosofia; e, prima ancora, alla religione, che parla un linguaggio universale e schiude orizzonti di senso non solo alle persone colte, ma anche alle persone più semplici, compresi i bambini.
Ben venga, dunque, l’utopia: ma, per carità, che essa non esca dalle pagine dei libri e dai discorsi dei poeti: se a proporsi di realizzarla saranno i politici, c’è il rischio che l’uomo venga annientato…
Fonte dell'immagine in evidenza: sconosciuta, contattare gli amministratori per chiedere l'attribuzione
