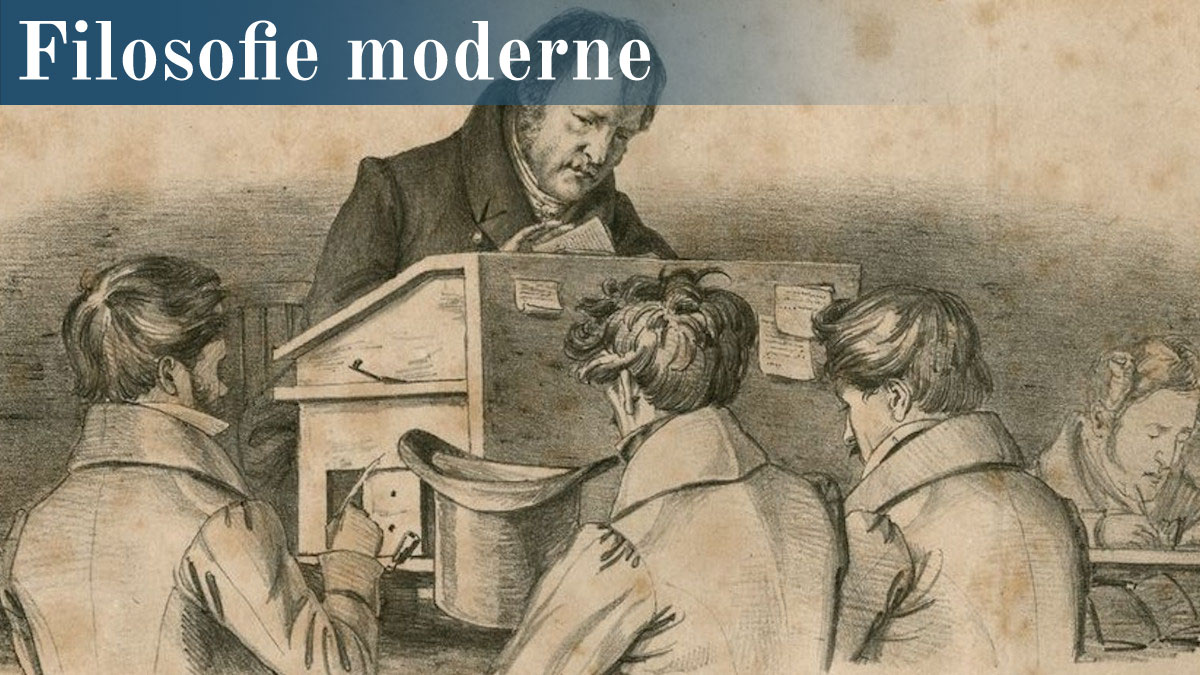Apuleio e Luciano di Samosata, i Dioscuri della dissoluzione
28 Luglio 2015
La politica fra realtà, ideologia e utopia
28 Luglio 2015Darwin e il darwinismo (suo figlio legittimo) sono stati i più intransigenti nemici della fede religiosa e i principali artefici, in ciò perfettamente consapevoli e deliberati, della scristianizzazione della scienza e della cultura moderna; è lecito, pertanto, domandarsi se Darwin e i suoi seguaci si siano presi il disturbo di confutare seriemente la credenza in Dio e quella in Gesù Cristo, o se abbiano saputo vedere una qualche differenza di approccio, di metodo e di prospettiva tra la conoscenza della natura e la conoscenza delle cose divine.
Ebbene, per quanto ciò possa sembrare quasi incredibile, la risposta a entrambe tali domande è "no". Non solo: quel che risulta, esaminando l’atteggiamento di Darwin nei confronti della problematica religiosa, è una rozzezza, una superficialità, una povertà di ragionamento, addirittura desolanti. Appare infatti che il grande scienziato, improvvisatosi teologo e pensatore religioso (o meglio, anti-religioso), non possedeva né la sensibilità, né la profondità, né la pazienza, né il rigore, necessari per sconfinare così palesemente fuori dall’ambito di ricerca che si era scelto: di fatto, egli non spiccava per niente, anzi, era decisamente al livello dell’uomo della strada, e, per certi aspetti, anche al di sotto, allorché si metteva a pontificare circa l’impossibilità dell’esistenza di Dio, e circa la falsità del cristianesimo, sulla base di argomenti e ragionamenti che qualsiasi studentello di filosofia o di teologia avrebbe trovato addirittura imbarazzanti per la loro approssimazione per la loro mancanza di qualunque spessore speculativo.
Ora, non c’è niente di male se uno studioso, che ha dedicato tutta la sua vita ad un ben preciso campo di ricerca, mostra di essere meno che un dilettante in un altro campo (anche se una cosa del genere non sarebbe stata possibile fino a quando, prima dell’Illuminismo, la società sapeva ancora produrre uomini di cultura, e non dei banali e presuntuosi "intellettuali" o degli "specialisti" altrettanto presuntuosi e auto-referenziali); il male è quando codesto studioso, invadendo un ambito di cui non sa nulla, e verso cui non possiede nemmeno la sensibilità e la "forma mentis" adatta, si mette in cattedra e comincia a far lezione. A partire da Darwin (ma gli esordi si notano già in Galilei), questo atteggiamento degli scienziati è diventato quasi normale: colui che è specializzato nella ricerca scientifica si mette a parlare dell’invisibile, del soprannaturale, di Dio, e dell’anima, e ci garantisce, in tutta serietà, che tali cose non esistono, perche… lui non le vede, e nessun altro le può vedere, verificare, sperimentare, con gli strumenti — appunto – della scienza.
Ma ecco come lo stesso scienziato inglese affronta la problematica religiosa, partendo da un approccio personale ed estendendo automaticamente la riflessione ad un piano generale, come se ciò che è divenuto chiaro per lui, non possa non esserlo, automaticamente, per tutto il resto del genere umano (da: C. Darwin, «Autobiografia, 1809-1882. Con l’aggiunta dei passi omessi nelle precedenti edizioni»; titolo originale: «The Autobiography of Charles Darwin (1809-1882). With original omissions restored. Edited with Appendix and Notes by his grand-daughter Nora Barlow», London, 1958; traduzione dall’inglese di Luciana Fratini, Torino, Einaudi, 1962, pp. 67-69):
«Durante quei due anni [ottobre 1836-gennaio 1839] meditai molto sulla religione. Quando ero imbarcato sul "Beagle" ero di un’ortodossia perfetta e ricordo che parecchi ufficiali, nonostante fossero anch’essi credenti, mi derisero perché facevo appello alla Bibbia come a un’autorità inconfutabile su certe questioni morali. Penso che fossero divertiti dalla novità dell’argomentazione. Ma già a quel tempo ero pervenuto, gradualmente, a rendermi conto come il Vecchio Testamento, per la sua storia del mondo così manifestamente falsa, come la Torre di Babele, l’arcobaleno come presagio, ecc., per la sua attribuzione a Dio dei sentimenti di un tiranno vendicativo, non meritasse più fede dei libri sacri degli indù o della credenza di qualsiasi barbaro. Il problema che di continuo si poneva alla mia mente, e da cui non riuscivo a prescindere, era questo: come si può credere che se Dio facesse oggi una rivelazione agli indù permetterebbe loro di connetterla con la fede in Visnù, Siva, ecc., così come il cristianesimo è connesso con il Vecchio Testamento? Francamente ciò mi sembrava incredibile.
Rimuginavo inoltre altri pensieri: che soltanto le prove più palesi potrebbero convincere un uomo sano di mente a credere nei miracoli su cui si basa la fede cristiana; che quanto più conosciamo le leggi della natura, tanto più è difficile credere ai miracoli; che a quei tempi gli uomini erano creduli e ignoranti a tal punto che oggi ci sembra incomprensibile; che non si può dimostrare che i Vangeli siano stati scritti contemporaneamente ai fatti che raccontano; che essi differiscono per molti particolari importanti, troppo importanti per essere considerati come le solite inesattezze di testimoni oculari. Per tutte queste riflessioni, certo prive di qualsiasi valore e originalità, ma molto decisive per me, persi gradualmente la fede nella religione cristiana in quanto verità rivelata. Non potevo non attribuire importanza al fatto che molte false religioni si fossero diffuse come un incendio su vaste aree della terra. E non si può negare che la morale del Nuovo Testamento con tutto il suo fascino deve gran parte della sua perfezione alla interpretazione che noi oggi diamo alle metafore e alle allegorie.
Fui però molto riluttante a rinunciare alla mia fede, e ricordo di aver sognato spesso a occhi aperti che a Pompei o altrove erano state trovate antiche lettere di patrizi romani o manoscritti che confermavano in maniera inconfutabile tutto ciò che era scritto nei Vangeli. Ma col passare del tempo trovai sempre più difficile, pur sbrigliando la mia immaginazione, inventare prove sufficienti a convincermi. Così l’incredulità s’insinuò lentamente nel mio spirito, e finì col diventare totale. Il suo sviluppo fu tanto lento che non ne soffersi, e da allora non ho mai più avuto alcun dubbio sull’esattezza della mia conclusione. In realtà non posso capire perché ci dovremmo augurare che le promesse del cristianesimo si avverino: perché in tal caso, secondo le parole del Vangelo, gli uomini senza fede, come mio padre, mio fratello e quasi tutti i miei amici più cari, sarebbero puniti per l’eternità.
E questa è un’odiosa dottrina.
Benché non abbia pensato molto all’esistenza di un Dio personale fino a un’età piuttosto avanzata, darò qui le conclusioni alquanto vaghe alle quali sono giunto. Oggi, dopo la scoperta della legge della selezione naturale, cade il vecchio argomento di un disegno nella natura secondo quanto scriveva Paley, argomento che nel passato mi era sembrato decisivo. Non si può più sostenere, per esempio, che la cerniera perfetta di una conchiglia bivalve debba essere stata ideata da un essere intelligente, come la cerniera della porta dall’uomo. Un piano che regoli la variabilità degli esseri viventi e l’azione della selezione naturale, non è più evidente di un disegno che predisponga la direzione del vento. Ho già discusso questo tema alla fine del mio libro sulla "Variazione degli animali domestici e delle piante coltivate" [Variation of Domestic Animals and Plants"] e l’argomento che là ho portato non è mai stato controbattuto, ch’io sappia.»
Darwin va avanti per qualche altra pagina sullo stesso tono, e accumula contraddizioni logiche a ripetizione (per esempio, quando afferma che la quantità di felicità degli esseri sensibili prevale, nella natura, sulla infelicità; ma poco dopo sembra inclinare verso l’opinione opposta, laddove sostiene che l’enorme quantità di dolore esistente nel mondo smentisce l’esistenza di un Dio creatore, onnipotente e onnisciente, ma anche amorevole); ma crediamo che questa pagina sia sufficiente per farci un’idea del suo "metodo".
Il racconto biblico relativo alla Torre di Babele e quello dell’arcobaleno apparso a Noè come simbolo della ritrovata amicizia con Dio gli sembrano classici esempi della palese falsità del Vecchio Testamento: non si prende però la briga di argomentarlo minimamente. Non ricorre neppure a una possibile lettura simbolica, come aveva fatto, due secoli prima, Galilei: per lui, evidentemente, la Bibbia va presa alla lettera; e, se la lettera contrasta con le leggi scientifiche, essa va rigettata "in toto", senza la benché minima incertezza o sfumatura.
La presentazione di Dio come un tiranno vendicativo gli sembra un altro argomento probante circa la falsità della Bibbia; e crede di rafforzare tale affermazione qualificando di "barbare" le altre credenze religiose, a cominciare da quelle degli Induisti (che, a giudicare da come ne parla, non conosce affatto, se non per sentito dire); non lo sfiora l’idea che questo non è un argomento, ma un pregiudizio; e che affastellare tutte le religioni in un unico mazzo, riguardo al loro contenuto di verità, è una operazione assurda e sommamente scorretta, non solo quanto ai loro contenuti e alle conclusioni che ciascuno, di fronte ad esse, può trarre, ma anche da un punto di vista semplicemente metodologico, sul versante storico e antropologico.
Poi afferma che i miracoli di cui parla il cristianesimo sono così incredibili, che nessun uomo sano di mente potrebbe prenderli sul serio; e aggiunge che quanto più si conoscono le leggi della natura, tanto meno si può credere ai miracoli. Non tenta di definire cosa sia il miracolo, così come non tenta di definire cosa sia la "natura", e meno ancora se essa abbia realmente delle "leggi". Nel suo universo concettuale, rigido e ottuso, il miracolo è, come per gli illuministi di un secolo prima, come per Voltaire o per Hume, nient’altro che una impossibile sospensione delle leggi di natura. Ma non si domanda se esista, dopotutto, la "natura", o se questo concetto non sia che l’espressione pratica di una esigenza puramente umana, didattica, ossia un bisogno di ordine e regolarità da parte dello studioso (Enrico Medi ricordava, giustamente, che noi non sappiamo cosa sia la "natura", ma solo cosa siano i singoli eventi e i singoli oggetti naturali); né se le tanto decantate "leggi" altro non siano che lo stato attuale delle umane conoscenze, sempre soggette a revisione, sempre provvisorie, e, soprattutto, sempre approssimate rispetto alle cose in se stesse (il "noumeno" kantiano, che allo scienziato, proprio per il tipo di approccio che lo caratterizza, quantitativo e materiale, rimane fatalmente precluso).
Afferma poi che gli uomini, al tempo dei Vangeli, erano straordinariamente creduli ed ignoranti: come dire che erano disposti a prendere per buona qualsiasi panzana. Di nuovo, non sembra minimamente sospettare che, se gli uomini del XIX secolo sono meno "creduli" e "ignoranti" di quelli del I secolo, ciò non costituisce un dato oggettivo e incontrovertibile, ma esprime soltanto e unicamente il punto di vista, ed il relativo giudizio, degli uomini, appunto, del XIX secolo, o, più precisamente, di quegli intellettuali (come lui) i quali hanno deciso di separare il loro sentire ed il loro pensare dal sentire e dal pensare della stragrande maggioranza dei loro contemporanei (mentre gli uomini colti, fino a tutto il Medioevo e oltre, differivano dagli uomini incolti riguardo alla quantità del sapere, non riguardo ai suoi fondamenti: credevano, cioè, fondamentalmente, alle stesse verità ultime in cui credevano le persone semplici e prive d’istruzione). Ora, per gli intellettuali del XIX secolo, e nemmeno per tutti, il moderno paradigma culturale non ammetteva alcuna forma di credenza che non fosse verificabile mediante il metodo scientifico sperimentale; ma la religione, in se stessa, non è "dimostrabile", né con tale metodo, né con alcun altro, sebbene non sia affatto in contrasto con la ragione umana; di conseguenza, essi tacciavano di credulità ed ignoranza i loro predecessori, che avevano avuto un altro approccio conoscitivo. In altre parole, Darwin non si accorge affatto di ragionare all’interno di un paradigma culturale che ritiene vero se stesso a priori, e che ritiene falsi gli altri paradigmi (quelli pre-moderni): e, dall’alto di tale beata inconsapevolezza, non esita a distribuire patenti di credulità e d’ignoranza a uomini come Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino, o come Dante Alighieri ed Erasmo da Rotterdam; ma anche, implicitamente, a uomini come Socrate, Platone e Aristotele (visto che tutti costoro avevano creduto in Dio e non avevano trovato tale credenza per niente in contrasto con il sapere scientifico).
Poi Darwin insinua che i Vangeli non siano stati scritti da testimoni oculari degli eventi in essi narrati, perché, a suo parere, differiscono in maniera decisiva su fatti di somma importanza: e anche questo gli sembra un argomento assolutamente probante contro la verità del cristianesimo. Ci si può domandare, tuttavia, quali siano tali discordanze decisive: perché chiunque abbia letto i quattro Vangeli, anche in maniera piuttosto superficiale, sa che non è così. I tre Vangeli Sinottici raccontano, praticamente, gli stessi fatti, con parole molto simili; solo il Quarto se ne discosta, ma nemmeno i suoi racconti sono in contrasto sostanziale con gli altri. Darwin non fa nemmeno un esempio di ciò che afferma; e dunque ci domandiamo: quali sarebbero codeste contraddizioni, inspiegabili se gli autori dei Vangeli fossero stati realmente dei testimoni diretti di quei fatti? Forse il numero degli angeli apparsi a fianco del sepolcro aperto, dopo la Resurrezione? Sono di questo genere, le gravissime discordanze? Le aveva già segnalate Celso, lo scrittore anticristiano della tarda antichità: ma non ci sembrano differenze così importanti. Di più: ci sembra che alcune differenze nei racconti evangelici si addicano maggiormente a dei veri testimoni oculari, che non a dei falsi testimoni. Questi ultimi si sarebbero accordati per fornire delle versioni univoche: ma la storia dei documenti su cui si basano le ricostruzioni storiografiche ci insegna che una totale concordanza tra fonti diverse è quanto mai sospetta, mentre un certo grado di discordanza è, di norma, il suggello d’un racconto sostanzialmente veritiero.
Darwin sostiene poi che il fascino del Nuovo Testamento deriva in gran parte non da ciò che Gesù ha detto e operato, ma dalle interpretazioni che di quei fatti e di quelle parole sono state avanzate dai moderni. Qui davvero non si capisce di che cosa stia parlando; ma, di nuovo, egli non si abbassa a fare il benché minimo esempio di quel che intenda con una simile affermazione. Sicché, per il lettore, la cosa resta misteriosa: nessuno, in verità, nemmeno i nemici dichiarati del cristianesimo, come Celso, avevano mai avanzato un argomento siffatto. Ci piacerebbe capire che cosa egli avesse in mente: forse che il Sermone della Montagna, o la parabola del Figlio prodigo, o quella del Buon pastore, derivano il loro fascino e la loro profonda suggestione dalla interpretazione che ne è stata data a posteriori? E da chi, e quando? Non si sa: Darwin non lo spiega. Si limita a dichiarare che tutte queste ragioni lo spinsero nella più totale incredulità, ma che egli non ne soffrì molto, perché essa avvenne in un lungo arco di tempo. Questione di opinioni: meno di due anni non ci sembrano poi un tempo così lungo, per passare da una fede cristiana così salda, da ambire a diventare pastore anglicano — tali erano i progetti del giovane Darwin, prima di imbarcarsi sul «Beagle» – ad una radicale e definitiva perdita di quella stessa fede.
L’argomento successivo tirato in ballo a sostegno dell’incredulità religiosa è la crudeltà di una religione che condanna alle pene dell’Inferno i non credenti, senza tener conto del fatto che essi furono, magari, delle ottime persone, e che furono, per giunta, nostri amici (Darwin la mette sul piano personale, come se la questione fosse strettamente privata, tra lui e Dio, e non riguardasse nessun altro; anche se poi tira delle conclusioni univoche e perentorie, che dovrebbero valere per tutte le persone "ragionevoli"). Non lo sfiora l’idea che l’Inferno potrebbe anche non essere un castigo inflitto da Dio, ma semplicemente la condizione di quelle anime che hanno scelto di rifiutare ostinatamente la Verità, pur avendo tutti gli strumenti per credere in essa: vale a dire una auto-punizione, che nemmeno la misericordia divina potrebbe modificare, senza violare il bene prezioso, incommensurabile, della libertà umana. Né gli viene in mente che un simile argomento emotivo si pone al di fuori della logica, criterio che sinora ha cercato di seguire nei suoi ragionamenti; e non ha niente a che fare neppure con la tanto decantata verità della scienza (per la scienza, una cosa è vera, o non è vera, indipendentemente dagli aspetti morali che vi sono implicati).
Da ultimo, Darwin cala il suo asso in favore dell’ateismo: la scoperta della "legge" della selezione naturale; cioè, non troppo modestamente, la scoperta della "sua" legge (e lasciamo perdere che la stessa "legge" era stata ipotizzata da Alfred Wallace; e il modo, non proprio inappuntabile, con cui Darwin aveva scavalcato il giovane studioso, e tradito la sua fiducia, rivendicando "a posteriori" una priorità alquanto dubbia), la quale gli sembra sgominare definitivamente l’idea d’un piano ordinato presente in Natura, e attribuibile ad una Intelligenza superiore. La selezione naturale, infatti, procede per conto suo; e, come se non bastasse, procede a casaccio, dal momento che la selezione dei caratteri "utili" alla sopravvivenza delle specie viventi procede da modificazioni casuali, che solo in un secondo momento vengono "adottate" dagli altri individui di quella determinata specie.
E qui Darwin, decisamente, si fa teologo. «Non è lecito – egli dice, in buona sostanza – credere in un Dio creatore, che sia anche provvidente verso le sue creature, perché io ho scoperto che non è così: che non esiste nessuna intelligenza superiore, che la natura non conosce un ordine predeterminato, e che la selezione naturale procede per le sue vie, senza bisogno di scomodare alcun Dio». È la classica pretesa positivista di stabilire, a partire da ciò che la scienza sa, o crede di sapere, quel che è possibile, e quel che non lo è: vale a dire, prima gli scienziati stabiliscono che cosa è vero, e solo in subordine alle "leggi" da loro determinate, rimane lo spazio per valutare che cosa può essere, e che cosa no (i miracoli, ad esempio, lo si è visto, non sono possibili, per definizione). Che l’ambito del sapere scientifico sia distinto, e non direttamente collegato, alla sfera religiosa; che la fede possa offrire la conoscenza diretta di ciò che la scienza non può, e non deve, tentar di dimostrare o di smentire, perché diverso è il suo statuto epistemologico, diversi i suoi metodi, diverse le sue finalità: tutto questo non gli passa per il capo.
Darwin è arrogante come tutti gli altri fondatori del moderno paradigma scientista: come Galilei, come Freud. In sostanza, egli rivendica l’autonomia della scienza, ma poi cade nel difetto che rimprovera agli avversari, e subordina la verità religiosa a quella scientifica. Se una cosa non è scientificamente dimostrabile, allora non è vera: è solo impostura, fandonia, allucinazione, credulità, superstizione; e un uomo moderno, evoluto e ragionevole, non può abbassarsi a credere ciò che la scienza ha escluso. Darwin estende arbitrariamente le verità scientifiche, oltretutto quelle della sua idea di scienza (che non sono affatto verità, ma ancora oggi, e fino a prova contraria, teorie: come l’evoluzionismo) all’intero spettro del conoscere. È intollerante, totalitario, sprezzante verso chi non si sottomette alle sue vedute. In fondo, egli non si oppone alla religione; si limita a crearne un’altra: la religione della Scienza, all’infuori della quale non esistono verità, né salvezza. È il tipico atteggiamento degli spretati. Persa la fede nella Chiesa anglicana, Darwin si affretta a fondare la nuova chiesa del Sapere scientifico: perché senza una chiesa, quelli come lui non sono capaci di rimanere neanche per un poco. Proprio come fanno quegli eterni innamorati i quali, perso l’oggetto del loro amore, il giorno dopo se ne sono già procurato un altro, che giudicano altrettanto "eterno" e "meraviglioso" del primo. E così via, all’infinito, senza mai pace: se viene a mancare il secondo, subentrano il terzo, il quarto… La verità è che da soli, costoro, non sanno stare: ne hanno un vero terrore. Chissà, forse temono d’incontrare se stessi; e non c’è nulla che li spaventi di più.
Comunque, c’è anche un’altra ragione, che spiega la facilità e la disinvoltura con cui Darwin è transitato da una religione all’altra: il fatto che, della nuova religione, egli sarebbe stato proclamato papa. Esistevano tutte le condizioni a ciò necessarie: un piccolo esercito, molto agguerrito, di discepoli giovani ed entusiasti, tanto inclini a venerarlo, quanto desiderosi di scagliarsi, lancia in resta, contro gli ultimi residui d’ignoranza e superstizione; una diffusa insofferenza verso quel poco che ancora restava della concezione teocentrica del mondo e della vita, verso il clero, verso il passato cristiano dell’Europa, che neppure il Secolo dei Lumi e la Rivoluzione francese erano riusciti a cancellare interamente; il facile ottimismo, l’entusiasmo, la fiducia che la diffusione irresistibile della civiltà della macchina riflettevano sulle possibilità ancora non del tutto espresse dell’intelletto, e sulla capacità dell’uomo di far da solo, di chiarire gli enigmi della natura, di sciogliere qualunque dubbio relativo al mondo e all’esistenza; lo spirito intraprendente, aggressivo, risoluto, della borghesia industriale e finanziaria, compiaciuta dei propri successi e bramosa di mieterne degli altri, sempre più grandi; la convinzione che il sapere metafisico, la dimensione religiosa e spirituale, altro non sono se non inciampi ed ostacoli nella libera esplicazione delle capacità umane, una remora per i soggetti più intraprendenti, lanciati alla conquista del successo; e, insomma, la sempre più diffusa mentalità basata sul principio dell’utile, sul disprezzo per quel che vi si oppone, e la propensione a giudicare gli esseri umani in base ai risultati quantitativi, verificabili, ostensibili, che sono capaci di raggiungere.
Darwin era un ambizioso, e la sua "legge" dell’evoluzione naturale (ché egli fin dal principio la chiama così, e non "ipotesi"), della quale si considerava il vero e, in ultima analisi, l’unico legittimo scopritore, si prestava perfettamente ad incarnare le tendenze culturali allora in pieno sviluppo, anche al di fuori dell’ambito scientifico, ivi compreso quello politico-sociale. Si affermavano le classi ed i popoli dotati di capacità superiori di adattamento; gli altri, soccombevano: questo era il nuovo Verbo, che non conosceva la parola"compassione", un lusso ignoto alla natura. E Darwin ne sarebbe stato il profeta e, allo stesso tempo, il sommo sacerdote. Una tentazione quasi irresistibile…
Fonte dell'immagine in evidenza: Wikipedia - Pubblico dominio