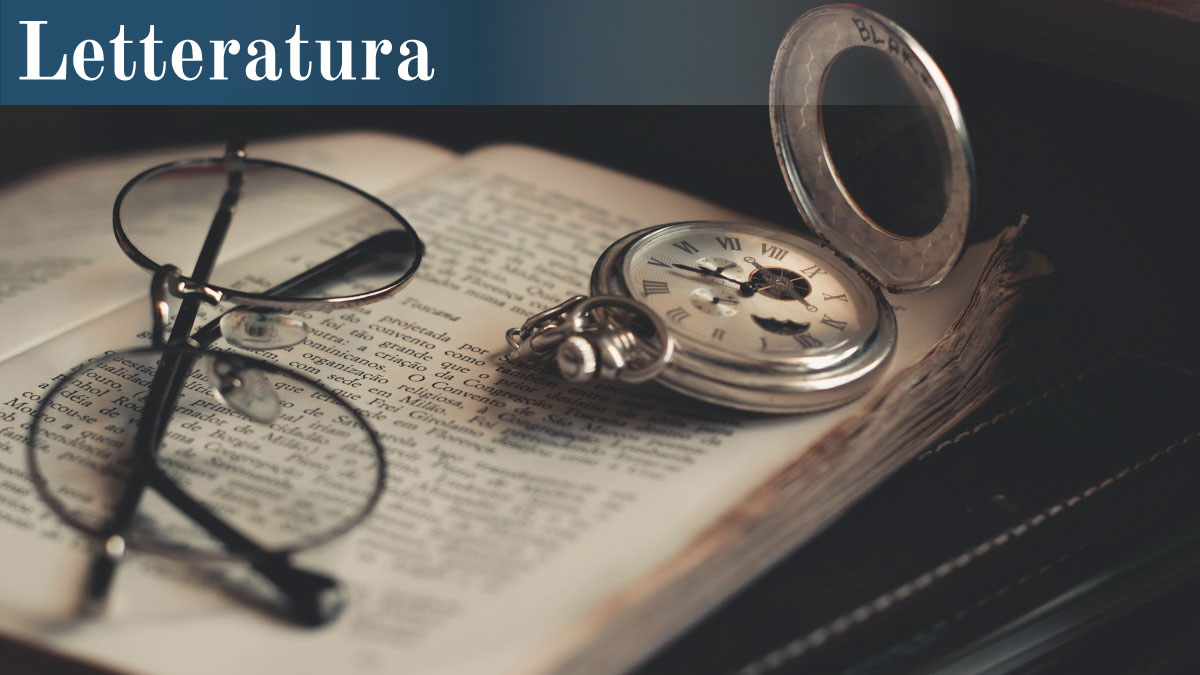La democrazia totalitaria ha iniziato la sua crociata mondiale nel 1917
28 Luglio 2015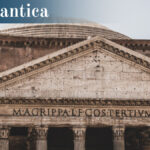
Quale grado di attendibilità dobbiamo accordare alle memorie di Cesare?
28 Luglio 2015Il bosco ed il mondo vegetale come luoghi di rifugio dai dolori, dagli affanni, dalle preoccupazioni della vita: abbiamo infiniti esempi di questa nostalgia, fin dalle letterature antiche; fra gli altri, in quella lettera di Cicerone, umanissima, nella quale racconta come egli s’interni nell’ombra delle piante per nascondere agli occhi di tutti il suo dolore sconsolato per la morte della figlia amatissima.
Anche in Petrarca troviamo il desiderio di isolarsi nel silenzio e nella solitudine della natura, onde sottrarsi allo sguardo indiscreto del "vulgo" e tenere celate le sue pene d’amore — forse immaginarie, forse vere, ma non certo di quella verità che faceva realmente, e non metaforicamente, sanguinare il cuore paterno di Cicerone -, ad esempio in un sonetto famoso come «Solo e pensoso i più deserti campi», che restituisce la verde penombra dei boschi della Valchiusa.
Il dolore amoroso dei poeti – sospiroso, ostentato, vagamente narcisistico e masochista -, abbisogna d’una cornice adatta: la quale deve risultare abbastanza selvaggia da creare una situazione di perfetta solitudine, eliminando qualsiasi elemento estraneo, che sarebbe fonte di distrazione, ma senza esserlo troppo, perché, in tal caso, la natura diverrebbe essa medesima un elemento minaccioso, e distrarrebbe l’anima dalla contemplazione voluttuosa di se stessa, del proprio patimento. Insomma, è necessario creare un luogo che solitario, ma non ostile, non eccessivamente abbandonato, certamente non pauroso, semmai languidamente malinconico: una versione sospirosa e dolcemente raccolta del "locus amoenus" caro alla tradizione bucolica, da Teocrito a Virgilio, e poi su, fino a Jacopo Sannazaro e Torquato Tasso.
Già: il Tasso. Quello della sua Erminia fra i pastori è uno degli episodi che più rimangono impressi nella memoria del lettore della «Gerusalemme liberata»; un episodio che ha suscitato anche l’interesse di non pochi pittori, che lo hanno voluto raffigurare sulla tela: da Annibale Carracci a Paolo De Matteis, da Sisto Badalocchio a Tommaso Minardi, per citarne solamente alcuni.
Quel bosco, quel fiume, quella pace campestre, quella complice ombra delle fronde, e, soprattutto, quel pianto prolungato di Erminia, amante infelice che non osa rivelarsi all’amato, che non osa credere al suo amore, o meglio, che non osa concepire la propria felicità, perché si ritiene meschina e dappoco, e che invece, nel suo cuore generoso, nutre dei sentimenti estremamente profondi, i quali potrebbero costituire un tesoro prezioso per qualunque uomo cui li volesse offrire: chi non ricorda di aver letto quei versi provando dei sentimenti contrastanti, di vaga impazienza, al principio, ma, poco alla volta, d’incuriosito, partecipe interesse, e – alla fine – di vivissima simpatia nei confronti di una fanciulla così romanticamente fragile e infelice?
Nel settimo canto della «Gerusalemme liberata» si rivela appieno l’anima ricca e sensibile della bella Erminia, dolce e malinconica figura femminile, tanto diversa sia dalla procace e sensuale maga Armida, la quale, in verità, non avrebbe neanche bisogno della propria magia per conquistare e manipolare a piacere i cavalieri cristiani, come avviene con il pur valoroso Ruggero), sia dalla vergine guerriera Clorinda, la cui segreta femminilità erompe solo in punto di morte, quando, smessa l’ormai inutile grinta guerresca, ella chiede il battesimo a Tancredi, con nuovi e insospettati accenti di dolcezza; e, più ancora, DOPO la morte, quando il suo bel corpo si distende in quello che sembra un profondo sonno, casto ed insieme conturbante. Erminia è totalmente, disperatamente irretita nel suo impossibile sogno d’amore per Tancredi; e, dopo aver tentato, invano, di raggiungerlo per medicarlo, è costretta a fuggire a precipizio, inseguita da alcuni cavalieri cristiani, i quali, tratti in inganno dall’armatura da lei indossata, l’hanno scambiata per Clorinda; e il suo cavallo, a un certo punto, la conduce in un inatteso «locus amoenus», fra pascoli e boschetti, ove sarà ospite di un pastore, reso saggio dall’età e dalle varie ed intense esperienze della propria vita.
E laggiù, liberatasi dalle ingombranti armi di Clorinda, che non le si addicono, e fattasi pastorella ella stessa, ritrova un po’ di serenità dopo tanti affanni, decidendo di fermarsi presso quei pastori, nella speranza che il tempo e la vita ordinata e pacifica, a contatto con una natura amica, in quel piccolo angolo di paradiso, che pur si trova a sì breve distanza da Gerusalemme e dalla violenza della guerra, possano aiutarla a ritrovare se stessa e la pace dell’anima, e a medicare le dolorose ferite d’un amore non corrisposto.
Ha osservato in proposito il critico letterario Luigi Russo, più conosciuto come acuto interprete di Verga (in: Torquato Tasso, «La Gerusalemme liberata», Milano, Principato, 1958, pp. 125-6):
«È nella fantasia e nella memoria di tutti il principio di questo canto dove è presente "Erminia in fra l’ombrose piante". Il grande favore che in ogni secolo ha goduto questo idillio, il proverbializzamento che si è fatto dei "pastorali accenti" e delle "boscherecce inculte avene", la celebrazione di una morbida vita campestre, ha portato in ogni tempo alla reazione critica verso tali note della poesia del Tasso. Dal Galilei a qualche critico frettoloso di oggi si ripete che il pastore è "pastore da recitare in Arcadia in qualche tragedia pastorale, e non da parlare in un’epica poesia", oppure che questa poesia rispecchia troppo una concezione borghese della vita. E ci si fa forti del giudizio del De Sanctis, che pur non è negativo, là dove questi scrisse che "Erminia pastorella è la madre di tutte le Filli e le Amarilli che vennero poi, lontanissime dal modello". Ma è chiaro che questa critica antiborghese è tutto, fuorché critica di poesia: si può reagire al costume perpetuatosi nelle Filli e nelle Amarilli del Settecento, ma non si può negare che le ottava del Tasso siano poesia. Si batta pure contro il contenuto, ma noi vogliamo far questioni di ritmo, di musica, e questa è musica che torna sempre a battere gradita al nostro orecchio e alla nostra immaginazione. Questo momento idillico tassesco, dove c’è forza e morbidezza, ardire e soavità, è ormai una categoria ineliminabile dalla nostra memoria poetica.
L’episodio ha inizio nel canto VI […]. Erminia già in quelle ottave si delinea come una specie di Olindo fatto donna: è l’amore che tutto brama e nulla spera, l’amore tragico e patetico delle nature petrarchesche che vivono il loro sogno nell’immaginazione. […] La sua figura ci rende visibile e sensibile questa perpetua vita dell’immaginazione, tutta ritirata in se stessa; l’accoramento con cui segue il duello di Tancredi e di Argante è l’accoramento di chi è diviso materialmente dal mondo e tutto contempla e tutti soffre i suoi dolori dalla cella aerea della propria immaginazione. Quella donna è vicinissima ed è pur lontanissima da Tancredi. […] Dopo il duello, ella sogna di vedere l’eroe "lacero e sanguinoso" che le chiede aiuto, e quando si sveglia, "si trova gli occhi e ‘l sen molle di pianto". Ma il passaggio dalla realtà al sogno è soltanto fittizio; noi ci siamo mossi sempre nel mondo del sogno. Questa "rêverie", questo sogno a occhi aperti, spiega la frequenza dei sospiri nell’episodio di Erminia. E in quei sospiri c’è una certa voluttà del dolore. Erminia è proprio una creatura petrarchesca, con un’accentuazione più patetica e più malata; nei soliloqui contempla e sente pietà del proprio amore infelice, ma essa vagheggia e accarezza anche tale infelicità. Il tono petrarchesco s’avverte anche nel tono un po’ da madrigale in cui talvolta è rappresentata la donna ne suoi sospiri. […] Si noti poi che l’amore di Erminia è profondamente diverso da quello, per esempio, di Armida per Rinaldo, perché, a parte la natura tutta sensuale della maga, in Erminia l’amore nasce non per la bella persona di Tancredi, quanto per la cavalleria e nobiltà dell’eroe che, pur avendola prigioniera, fu così umano verso di lei. Il suo è un amore d’origine cavalleresca, e quell’origine dà un particolare carattere alla donna amante, dolcemente sommessa e gelosa del proprio amore, contento in sé e custodito segretamente e pudicamente. Un altro aspetto profondamente distingue l’amore di Erminia dalla passione di Armida. In Armida la passione per Rinaldo si esterna da sé nell’appagamento del desiderio; l’amore di Erminia invece tende a un possesso tranquillo e totale dell’amato, e perciò è inevitabile ch’esso, nell’immaginazione morbida e sentimentale dell’amata, si conclude nel matrimonio e sogni quindi "abbracciamenti onesti e nozze avventurose" (VI, 611-12). Armida poi è cosciente della seduzione che esercita con la sua bellezza e perciò può ribellarsi e trasformarsi in Medea quando Rinaldo l’abbandona, perché si sente offesa nella propria dignità di donna. Erminia è sempre umile e sommessa; sa di essere "debile e molle" e prova quasi vergogna della sua fragile femminilità, d’essere "una del vil femineo volgo; perciò ha invidia dell’eroina Clorinda […]. Si sente di fronte a lei in condizione d’inferiorità e vorrebbe come lei aver sortito una natura forte "onde potessi anch’io la gonna e ‘l velo / cangiar ne la corazza e ne l’elmetto" (canto VI, ottava 83). Ma il Tasso sorride di questi suoi sogni, perché compatisce e idealizza in lei la sua delicata fragilità. […]
Il pastore, che piange al pianto di Erminia, è parte anch’esso della natura. Le sue parole, ricche di esperienza e dettate dal buon senso proprio dei rustici, non ha nulla di convenzionale né è un luogo comune.»
Insomma, se non fosse che piangono un po’ troppo tutti quanti (perfino il pastore, che piange per una sorta di riflesso condizionato), si potrebbe dire che l’episodio di Erminia fra i pastori è fra i più squisiti, delicati e ben riusciti dell’intero poema, la cui sostanza lirica è — come nell’«Eneide» virgiliana, del resto — non già epica, ma elegiaca, e dunque malinconica. La stessa predilezione di Tasso per questa gentilissima figura femminile, che strappa la nostra commozione proprio in quel suo dichiararsi debole e vinta, e nell’essere inconsapevole del proprio valore, che è di un genere diverso, ma niente affatto inferiore, a quello della invidiata Clorinda (in tutt’altre faccende affaccendata, del resto, che siano non l’amore e i sospiri del cuore), si spiega con la sua consonanza con la tonalità poetica dominante dell’intero poema, e rivela profonde affinità, più che con altre parti di questo, con la favola pastorale «Aminta», ove l’anima rinascimentale, serenamente edonistica, dell’Autore, può rivelarsi apertamente, non ancora inviluppata, come avviene nell’opera maggiore, entro le insolubili contraddizioni fra tale dimensione rinascimentale, che comporta una concezione naturalistica dell’amore, e quella severamente morale, controriformistica, che avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni del poeta (ma che tale non è stata, per la sua buona sorte), la cifra dominante della «Gerusalemme».
Tasso, nell’episodio di Erminia fra i pastori, si dimostra poeta moderno, perché ci permette di misurare la lacerazione, e quasi lo sdoppiamento, del suo "io", che è un riflesso, a sua volta, del suo sdoppiamento nei confronti dell’ambiente sociale e culturale che fa da sfondo alla sua vita e alla sua opera: l’ambiente di corte (nel caso specifico, la corte estense di Ferrara nella seconda metà del XVI secolo: ancora splendida, ma non più serena e spensierata come ai tempi di Ludovico Ariosto, circa mezzo secolo prima). È moderno tale sdoppiamento, perché l’uomo moderno è lacerato fra opposte spinte e desideri (come lo è, ripetiamo, l’Enea di Virgilio); mentre non sono moderni, ma classici, Omero e Dante, così massicciamente coerenti con se stessi, così meravigliosamente lineari, pur nella loro stupefacente complessità. L’"io" diviso è il segno distintivo dell’anima moderna: e varrebbe la pena di chiedersi donde provenga la scissione, invece di seguitare a proclamare che essa è la caratteristica di ogni seria e profonda indagine sull’anima umana. Bach non ha un "io" diviso, Wagner, invece, sì; Poussin non ha un "io" diviso, ma Van Gogh ce l’ha; Manzoni no, Leopardi sì. Tutta la storia dell’arte e del pensiero moderni è, nelle sue espressioni migliori, una durissima lotta per riconquistare l’unità perduta, e, insieme ad essa, l’amore e il gusto per la vita.
Il vagheggiamento di una natura amica e rasserenatrice, nel cui grembo posare il capo stanco e alleggerirsi d’un fardello insopportabile di mesti pensieri e di tensioni angosciose, che incontriamo nell’episodio di Erminia fra i pastori, precorre tante altre scene e situazioni analoghe, che troviamo in Carducci e D’Annunzio, ed è lo sviluppo ideale dell’ameno giardino in cui la "lieta brigata" dei dieci giovani novellatori di Boccaccio si riunisce per scordare, all’ombra delle piante e al sussurro delle fontane, la drammatica realtà della peste di Firenze. Il fatto è che la natura non è "amica" dell’uomo, in se stessa; è amica a colui che l’accosta nella maniera giusta, e nemica a chi non lo sa, o non lo vuole, fare. L’uomo moderno ha scelto questa seconda alternativa: ha "deciso", da Francis Bacon in poi, di dominarla, soggiogarla, sfruttarla, da padrone tirannico: dunque non potrà mai trovare in essa alcuna pace, alcun rasserenamento. Si raccoglie quel che si è seminato, dopotutto…
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels