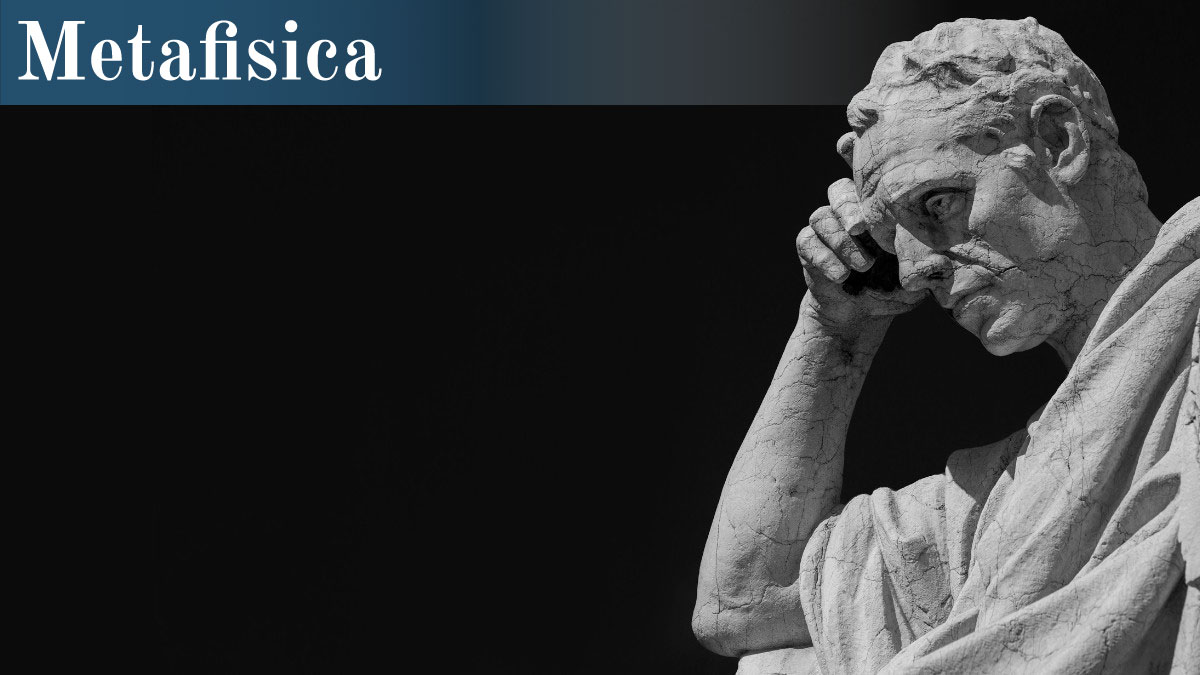La rivolta di Maritz e De Wet nel 1914, preannuncio della rivincita boera sull’Inghilterra
8 Marzo 2011
Le meraviglie della natura sono troppo belle per cederle incondizionatamente a questa scienza
8 Marzo 2011La metafora è, da sempre, un modo di trasmettere conoscenze e valori sia nell’insegnamento individuale, da parte di singoli maestri o agenzie educative, sia in quella grande fucina di conoscenze e valori collettivi che sono i racconti epici dei popoli antichi, dall’«Iliade» all’«Epopea di Gilgamesh», e le grande opere religiose, come i «Veda» o la «Bibbia».
Socrate, Platone, Buddha, Confucio, Cristo, Maometto, spesso parlavano in maniera metaforica, servendosi, ad esempio, di parabole.
Il mito ed il sapere che esso sottende pertengono alla sfera del discorso metaforico; nel mito di Atlantide, ad esempio, Platone sviluppa una metafora sulla "hybris" umana, che conduce le civiltà alla catastrofe; mentre nel mito della caverna, o in quello della biga alata, il filosofo greco delinea una metafora, rispettivamente, sui vari gradi della conoscenza umana e sulle componenti dell’anima, in rapporto alla Verità originaria.
Fedro ed Esopo si servivano di favole per trasmettere concetti morali, rendendoli accessibili e plasticamente efficaci anche per il pubblico più umile e illetterato.
E che altro è la fiaba, questo grandioso filone della cultura popolare, che attraversa i secoli e preserva le più antiche memorie della saggezza patriarcale (o matriarcale), se non una forma di educazione che procede in maniera metaforica?
Anche molte opere filosofiche e letterarie della modernità si possono leggere in senso metaforico: Don Chisciotte è la metafora del contrasto fra il mondo ideale della cavalleria e la prosaica, grossolana realtà quotidiana, mentre il denaro sostituisce i valori aristocratici e cortesi; Robinson Crusoe è la metafora del self-made-man e la sua isola, la metafora della modernità che avanza, con la sua filosofia antropocentrica, basata sul dominio e sulla scarsa o nulla sensibilità ecologica; i viaggi di Gulliver sono la metafora della presunzione e dell’assurdità dei valori di una determinata civiltà in un dato momento storico, allorché pretendono di farsi ideologicamente validi per tutte le altre; e l’elenco potrebbe continuare per pagine e pagine.
Molti romanzi moderni, da «I promessi sposi» di Manzoni a «Madame Bovary» di Flaubert, da «I Malavoglia» di Verga a «Il Maestro e Margherita» di Bulgakov, per non parlare del «Faust» di Goethe, sono interpretabili come altrettante metafore di singoli aspetti della condizione umana; e ciò vale anche per la letteratura per l’infanzia.
Che cos’è «Pinocchio», se non un’unica metafora, sviluppata con estro geniale, del processo di crescita dall’infanzia spensierata all’assunzione delle responsabilità, che è propria della fine di quella e dell’inizio dell’età adulta?
Nell’ambito delle scienze matematiche, è quasi superfluo evidenziare l’importanza del valore metaforico dello zero, questa straordinaria intuizione che permette di attribuire al numero un valore posizionale: per cui, ad esempio, nel numero 1.000, il primo zero vale per le centinaia, il secondo per le decine ed il terzo per le unità.
In ambito specificamente scolastico, un metodo d’insegnamento pedagogico imperniato su una dimensione metaforica sarà suscettibile di vastissime applicazioni nella didattica del processo di apprendimento, tanto più che la metafora presuppone un tipo di comunicazione figurata, che fa appello all’intuizione e si riveste, sovente, di magnifici panni figurativi, in una maniera che è particolarmente vicina alla psicologia del bambino.
Anche la musica si serve volentieri del discorso metaforico, soprattutto in opere come «Le quattro stagioni» di Vivaldi, la «La danza delle ore» di Ponchielli o «Il mattino» di Grieg (all’interno del «Peer Gynt»), che, non a caso, sono particolarmente adatte in un contesto di educazione all’ascolto della musica da parte di un pubblico di bambini o adolescenti, proprio per le loro caratteristiche di imitazione e, al tempo stesso, di metafora della realtà.
Il "pensiero selvaggio" ed il "pensiero bambino" presentano evidenti analogie nella funzione metaforica del discorso: basti solo pensare al ruolo della metafora nel contesto delle religioni animiste, che personificano e deificano i fenomeni e gli elementi della natura, e a quello che essa svolge nel mondo della fiaba, laddove funge sovente da "ponte" fra il mondo ordinario e il mondo del portentoso, del miracoloso e del soprannaturale.
Dal punto di vista strettamente linguistico, la metafora ( dal greco "metaphero", cioè "io trasporto") è una figura retorica che consiste in un trasferimento di significato e si realizza allorché, al termine che normalmente occuperebbe un certo posto nella frase, se ne sostituisce un altro, la cui "essenza" o funzione va a sovrapporsi a quella del termine originario, creando – così – immagini di forte carica espressiva; differisce dalla similitudine per l’assenza di avverbi di paragone o locuzioni avverbiali, ad esempio "come".
Aristotele ha mostrato in che modo la funzione ed il valore della metafora dipendano dalla proporzione, ovvero dall’analogia tra le cose che essa mette in gioco: per esempio, l’immagine poetica della sera come metafora della vecchiaia, si giustifica a partire da una analogia, inespressa ma chiaramente sottintesa, fra l’idea del mattino e quella della giovinezza.
A torto si è creduto, a lungo, che la metafora corrisponda ad un pensiero esclusivamente "poetico", per sua natura scarsamente adatto al ragionamento scientifico.
Mano a mano che il rozzo ed ingenuo positivismo ottocentesco ha fatto spazio a una visione più articolata e consapevole del sapere scientifico, ci si è resi conto che anche in quest’ultimo è presente in larga misura una componente intuitiva, soggettiva e "poetica", il che ha indotto a rivalutare l’utilizzo del discorso metaforico nell’ambito scientifico e, più specificamente, in ambito logico-matematico.
Il pregiudizio secondo cui la metafora non sarebbe stata idonea alla precisione e alla assoluta oggettività del sapere scientifico e matematico nasceva anche, forse, dal pregiudizio razionalista e illuminista nei confronti della cultura medievale, la quale, come è noto, si serviva largamente del procedimento metaforico per veicolare concetti morali o religiosi.
Nella cultura del medioevo, esistevano una serie di metafore, ad esempio quella della vita umana come "navigatio", come perigliosa navigazione tra il mistero della nascita e il mistero della morte, oppure della Chiesa come nave capace di condurre in porto sicuro le anime nel segno di Cristo: metafore le quali erano talmente diffuse e universalmente fruibili, che, ad esempio, incontrandole negli affreschi, nei mosaici, nelle vetrate istoriate o nelle sculture delle cattedrali, il fedele non esitava a riconoscerle, pur essendo, il più delle volte, incapace di leggere e scrivere.
E non parliamo del ruolo importantissimo svolto dal linguaggio metaforico in Dante Alighieri, non solo nella «Divina Commedia», ma anche in un’opera eminentemente psicologica come «La vita nuova» o in una squisitamente filosofica ed enciclopedica, come (e lo si comprende bene già dal titolo) «Il Convivio».
Oggi è stata acquisita definitivamente l’idea che alcune metafore, quelle dette "costitutive" sono, in effetti, né più né meno che idee, che si sviluppano attraverso l’opera di una generazione più di scienziati. Si tratta delle metafore che gli scienziati adoperano per esprimere testi teoriche, per le quali non si conosce, nel momento in cui esse vengono formulate, alcuna parafrasi letterale adeguata.
Fra parentesi, notiamo che questa "rivalutazione" del discorso metaforico anche in ambiti disciplinari tradizionalmente lontani dalla poesia o dalla favola, non nasce tanto dal riconoscimento dei limiti del discorso logico-concettuale, quando da quello della validità dell’intuizione platonica del valore allusivo del mito, ossia di un discorso teso a cercare di esprimere, servendosi di concetti ed immagini della realtà ordinaria, l’ inesprimibile verità dell’Essere.
L’idea della metafora, nella cultura moderna e contemporanea, e specialmente nel contesto della psicanalisi, ha finito per associarsi all’idea della relatività della conoscenza: un’idea ben lontana, quindi, da quella platonica relativa al mito. Essa, nella letteratura e nel teatro degli ultimi centocinquanta anni, oltre che in filosofia, è stata utilizzata sia come generatrice di senso, sia come elemento di trasgressione, volto a demistificarle comode verità convenzionali su cui si regge l’impalcatura della finzione sociale e dell’inautenticità quotidiana.
Nietzsche, ad esempio, alla domanda: «Che cos’è la verità?», rispondeva con sferzante disprezzo: «Un mobile esercito di metafore, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeticamente e retoricamente, che sono stare trasfigurate e abbellite, e che dopo un lungo uso sembrano a un popolo solide, canoniche e vincolanti: le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria».
Resta tuttavia la possibilità che la metafora, invece di essere rinchiusa all’interno del linguaggio per contrabbandare come verità assolute delle affermazioni soggettive, venga intesa e utilizzata come una finestra che si apre su una realtà esterna al linguaggio ordinario, che quest’ultimo non è in grado di esprimere servendosi dei soli concetti logici, ma cui essa può attingere per una via diversa, che pur non essendo "irrazionale" nel senso ordinario del termine, è tuttavia "extra-razionale" o, forse, addirittura "sovra-razionale".
BIBLIOGRAFIA:
Boyd, R. – Kuhn, T. S. (1993) "La metafora nella scienza, Feltrinelli, Milano.
Cacciari, C. (1991), a cura di, Teorie della metafora, Cortina, Milano.
Cierchia, G. – Mc Connet-Ginet, S. (1993), Significato e grammatica. Semantica del linguaggio naturale, Muzzio, Padova.
Fornari, F. (1976), Simbolo e codice, Feltrinelli, Milano.
Ong, W. J. (1982), Oralità e scrittura, Il Mulino, Bologna.
Perelman, C. Olbrechts – Tyteca, L. (1996), Trattato dell’argomentazione, Einaudi, Torino.
Turner, M. – Fauconnier, G., (1998), Miscele e metafore, Puliverso, 7.
Vzezani, B. (2000), I sentieri della qualità, Unipress, Padova.
Fonte dell'immagine in evidenza: sconosciuta, contattare gli amministratori per chiedere l'attribuzione