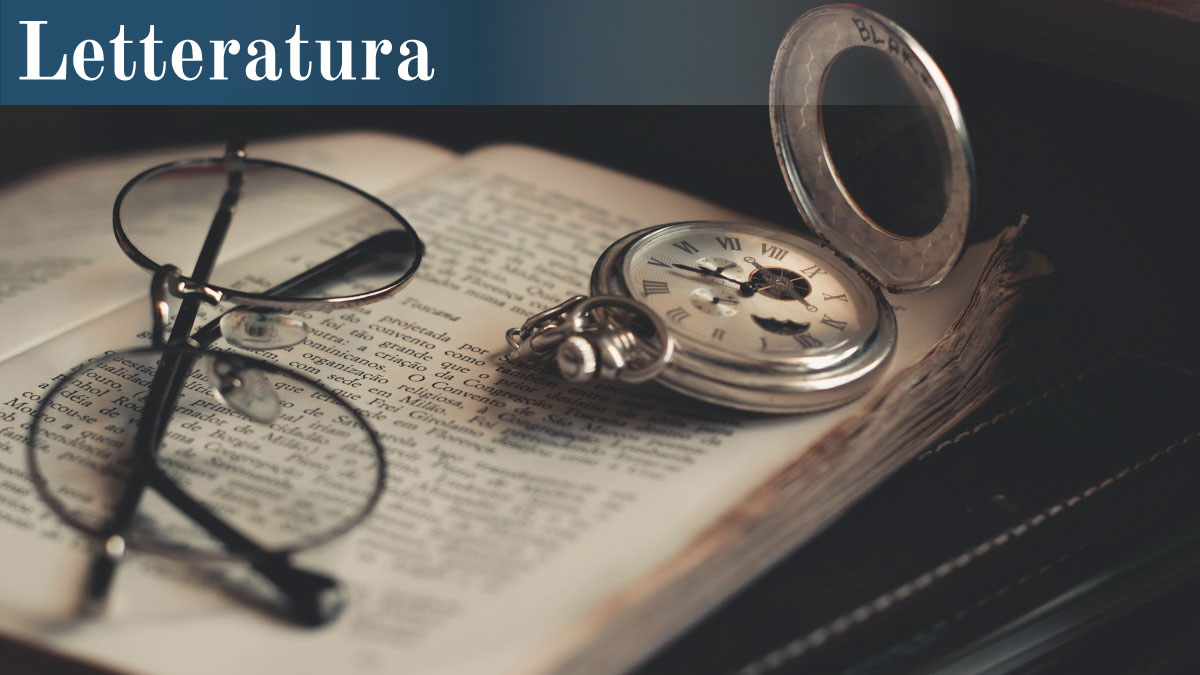Quo usque tandem, Magister Iudaice, abutere patientia nostra?
22 Gennaio 2010
Le notti antartiche 3 – Achernar
23 Gennaio 2010Questo dialogo è il secondo del trittico delle "Notti antartiche"; il primo si intitola "Fomalhaut. Riflessioni su finalismo e casualità", il terzo "Achernar. Riflessioni su amore e morte".
Una versione semplificata e ridotta di questi dialoghi è stata pubblicata sui "Quaderni" dell’Associazione Eco-Filosofica (già Associazione Filosofica Trevigiana) fra il 2003 e il 2006, con il titolo complessivo di "Conversazioni Filosofiche".
SABINA: E quella stella laggiù, un po’ isolata, ma brillante – come si chiama?
ALESSIO: Quella è Alphard, la stella alfa della costellazione dell’Idra femmina: Hydra.
SABINA: è molto bella. Che cosa significa Alpahrd?
ALESSIO: Vuol dire: "la Solitaria".
SABINA: Ah, un nome appropriato. Ma… gli Arabi riuscivano a vedere anche queste stelle del cielo meridionale?
ALESSIO: Certo. Alphard si vede bene anche dall’Italia, figurati dalla latitudine del Cairo, di Medina, di Aden o, addirittura, di Zanzibar.
SABINA: Anche dall’Italia?
ALESSIO: Fino alla latitudine di quaranta gradi sud, si vedono agevolmente tutte le costellazioni del cielo australe, in diversi periodi dell’anno. Poi, naturalmente, vi è una differenza tra le Alpi e la Sicilia. Praticamente, ci restano invisibili solo le stelle poste al di là del 45° parallelo celeste meridionale.
SABINA: E di Alpahard, "la Solitaria", che cosa mi sai dire?
ALESSIO: Che è di magnitudine 1,98 e dista 95 anni-luce. Appartiene alla classe delle giganti arancione e brilla come 110 Soli.
SABINA: Allora, propongo di dedicare a lei questa notte così quieta e luminosa.
ALESSIO: Una "notte di mezza estate" che ha qualcosa di shakespearianamente misterioso: come se, da un momento all’altro, Oberon e Titania dovessero sbucare da qualche angolino remoto della Via Lattea.
SABINA: C’è qualcosa di frizzante nell’aria, lo senti anche tu? Qualcosa di diverso… che cosa può essere?
ALESSIO: Bisognerebbe chiederlo a qualche vecchio lupo di mare. Io mi limiterei a fare una considerazione pratica: la terra non dovrebbe essere molto lontana, laggiù sulla sinistra.
SABINA: La costa dell’Australia, vero?
ALESSIO: Già. E allora, forse questa strana impressione di novità sarebbe semplicemente l’odore della cara, vecchia terra.
SABINA: Un saluto a distanza di antiche foreste…
ALESSIO: … popolate di pappagalli e uccelli-lira.
SABINA: Ma davvero il vento può portarcene gli odori?
ALESSIO: Chissà… forse. Hai nostalgia di casa?
SABINA: Sì, no. Sto fuggendo, non ricordi? …Mi nasconda la notte e il dolce vento.
ALESSIO: Sandro Penna?
SABINA: Lui.
ALESSIO: Fuggire, ma verso l’avventura: un modo creativo di fuggire. Trasformare la sconfitta in una ripresa, come sosteneva Kierkegaard… Cioè, un procedere ricordando.
SABINA: Mutare il destino in un atto di libertà… Magari si potesse. Ma almeno uno ci prova.
ALESSIO: Del resto, a che scopo fuggire? Tanto, da noi stessi non potremo mai evadere: ed è questo che conta.
SABINA: Allora siamo in trappola?
ALESSIO: Semplicemente, penso che non abbia senso trasportare in giro per il mondo i nostri problemi. Perché tanto loro ci vengono dietro, sempre.
SABINA: E allora, che fare?
ALESSIO: Accettare.
SABINA: Accettare cosa?
ALESSIO: Tutto. E noi stessi per primi.
SABINA: Accettare tutto?
ALESSIO: Tutto. Dire di sì.
SABINA: Dire sì alla vita? Anche quando non se ne abbia voglia?
ALESSIO: Alla vita e alla morte; al sole e alla pioggia; al giorno e alla notte…
SABINA: Alla notte lo preferisco… mi è più facile.
ALESSIO: Perché sei una creatura lunare.
SABINA: Già. Ma tu mi capisci: non è meraviglioso starsene qui alla brezza marina, davanti allo spettacolo incantevole di una notte carica di selle?
ALESSIO: È un privilegio unico. Inconcepibile che si possa preferire di starsene inebetiti davanti alla televisione o cose del genere.
SABINA: Se poi sei in perfetta sintonia con qualcuno che "sente" come te, non manca più nulla.
ALESSIO: Sono lieto di sentirti parlare così.
SABINA: Perché?
ALESSIO: Non so, avevo quasi l’impressione che tu cercassi di evitarmi, negli ultimi giorni.
SABINA: E forse era vero.
ALESSIO: Non avevi più fiducia in me?
SABINA: Devi capire; non è stato facile raccontarti di me, l’altra notte. Dopo ogni confessione, si prova una certa vergogna.
ALESSIO: Comunque, da parte mia nulla è cambiato.
SABINA: Sì, lo vedo. Naturalmente, ho avuto torto a dubitare. Tu sei diverso.
ALESSIO: Ma no, sono uno come tanti.
SABINA: Se è così, avrei voluto conoscerli prima, questi "tanti".
ALESSIO: Perché stai ridacchiando?
SABINA: Così, pensavo. Sai come ci chiamano a bordo?
ALESSIO: Chi, gli altri?
SABINA: Marzia, per esempio.
ALESSIO: Non lo so, come ci chiamano?
SABINA: I fidanzatini.
ALESSIO: Ah, sì? Be’, contenti loro.
SABINA: Del resto, bisogna capire.
ALESSIO: Capire cosa?
SABINA: Ma non ti sei mai accorto che Marzia ti gira attorno?
ALESSIO: Va là. No, mai.
SABINA: Quest’uomo, per certe cose, è cieco come un talpa.
ALESSIO: Sentiamo, quand’è così. Tu da che cosa l’avresti dedotto?
SABINA: Semplicissimo: da come mi guarda.
ALESSIO: Da come guarda te?
SABINA: Voglio dire, gonfia di gelosia.
ALESSIO: Mmm…
SABINA: La cosa non t’interessa?
ALESSIO: Marzia è una ragazza simpatica e intelligente, ma non credo che le cose stiano come dici tu. E del resto, se anche fosse, ciò non m’interessa. E tu sai bene il perché.
SABINA: Perché?
ALESSIO: Perché m’interessi tu.
SABINA: Ma io ti ho detto…
ALESSIO: Sì, lo so, lo so. Va bene. Non ti chiedo nulla, non mi aspetto nulla. Sono solo il tuo grande amico.
SABINA. E allora…?
ALESSIO: Niente. Ma se sei innamorato di qualcuno, non è possibile che tu pensi contemporaneamente a un’altra persona.
SABINA: Mi dispiace che sia così.
ALESSIO: Perché?
SABINA: Perché soffrirai.
ALESSIO: Ma no, guarda: le cose stanno così. Anche dopo quello che tu mi hai detto, io non posso semplicemente smettere di provare quel che provavo prima, così, da un momento all’altro. Altrimenti non sarebbe stato un sentimento vero. Ma poiché ti voglio bene, ti accetto e voglio rimanerti amico. Certo, questo non sarebbe stato possibile se tu mi avessi detto di preferire un altro…
SABINA: No, ti dissi – e lo ripeto – che se potessi amare un uomo, quello saresti tu.
ALESSIO: E ciò mi basta.
SABINA: Ti basta?
ALESSIO: Sì.
SABINA: Però, sei strano.
ALESSIO: Davvero?
SABINA: Sei sicuro che non ti manchi qualche rotella?
ALESSIO: Sicuro.
SABINA: Eh, accidenti, che sfortuna!
ALESSIO: Che cosa?
SABINA: Non poter amare uno come te. Chissà; forse, se ti avessi incontrato dieci anni fa, la mia vita sarebbe stata diversa. Ma a che serve pensare a queste cose?
ALESSIO: A niente.
SABINA: Appunto. Perciò, parliamo d’altro.
ALESSIO: Come vuoi. Di che cosa?
SABINA: Ti è mai capitato di aver fame, non di questa o quella pietanza; di aver fame e basta? Io sono affamata di parlare con te. Quel discorso che facevi poco fa, per esempio… sul fatto di accettare l’esistenza. Mi ha incuriosita, e credo che potrebbe fornirci una traccia. Ma vorrei che la discussione rimanesse aperta, che non le fissassimo dei limiti troppo rigidi e precisi.
ALESSIO: Bene. Sono d’accordo.
SABINA: Dunque, accettare. Accettare e accettarsi. Perché l’angoscia nasce proprio dal non accettare, quando invece sarebbe l’unica cosa da fare. Non credi?
ALESSIO: Sì. L’angoscia esistenziale, non di una certa cosa, ma della vita in quanto tale: la prima tappa verso la "malattia mortale" della disperazione. Kierkegaard, però, era convinto che l’angoscia può essere riferita sempre al solo presente; che il passato – se è veramente passato – non ci può più generare angoscia.
SABINA: Che vuol dire: "se è veramente passato"?
ALESSIO: Confesso che questo punto fondamentale del suo pensiero non mi è del tutto chiaro.. Credo che volesse dire che quando una colpa, per esempio, è passata, può generare rimorso o pentimento, ma non angoscia. Per lui, l’angoscia può essere solo angoscia del presente.
SABINA: E per te?
ALESSIO: Io non me la sentirei di fare una distinzione così netta e categorica fra passato e presente. Tanto più che il presente, come osservava giustamente sant’Agostino, a rigor di termini è un punto fra ciò che non è più e ciò che non è ancora: dunque non ha estensione. È una convenzione, non una realtà. Per me, anche il passato può generare angoscia; poco importa se ciò avviene perché non è passato "veramente". Come può tramontare del tutto?
SABINA: Pure, ho letto da qualche parte che tutte le cellule di cui è costituito il nostro organismo si rinnovano totalmente ogni sette anni circa. Vuol dire che il mio corpo, il mio cervello non sono più quelli della Sabina di sette anni fa; vuol dire che, da quando sono nata, è come se le mie sembianze fossero state assunte già quattro volte da altrettante persone diverse…
ALESSIO: Ma è il ricordo, che ci tiene legati al passato; e fa sì che Sabina sia sempre la stessa e unica persona; cambiano le cellule ma lei no, è sempre proprio quella.
SABINA: Ti credevo un materialista.
ALESSIO: E lo sono.
SABINA: Ma allora, come puoi sostenere che una cosa sono le cellule di Sabina e altra cosa è Sabina come persona?
ALESSIO. Materialista, non razionalista cartesiano.
SABINA: Cioè?
ALESSIO: Cartesio postulava due sostanze radicalmente diverse, la res cogitans, il cui attributo fondamentale è il pensiero; e la res extensa, il cui attributo fondamentale è l’estensione. Tutto ciò che non è pensiero, è estensione, ossia materia.
SABINA: E i cani, i cavalli, i delfini?
ALESSIO: Tutta res extensa.
SABINA: Gli animali, res extensa?
ALESSIO: Già. Al punto che schiere di anatomisti di tendenza cartesiana hanno praticato la più massiccia e crudele ondata di vivisezione ai danni degli animali, portando alcune specie canine a un passo dall’estinzione.
SABINA: È allucinante.
ALESSIO: Se gli animali sono solo materia, non possono veramente soffrire. Così, almeno, la pensava Cartesio. Il razionalismo cartesiano ha introdotto la pazzia sistematica nella cultura occidentale.
SABINA: Perché?
ALESSIO: Perché la radicale distinzione tra pensiero e materia ha avuto l’effetto di avallare la politica dell’aggressione e del dominio da parte dell’uomo contro il mondo intero.
SABINA: Pure, è evidente che – nell’uomo – res cogitans e res extensa coesistono.
ALESSIO: È vero. Ma l’aberrazione cartesiana era proprio quella di ammetterlo solo per l’uomo. Animali, piante e, naturalmente, mondo minerale ne erano esclusi.
SABINA: E nell’uomo, come spiegare la loro interazione? Perché se il mio pensiero "decide" che io debba alzare la mano destra, come va che la mano destra si alza in quel momento? Le due sostanze non dovrebbero essere del tutto separate, date le premesse?
ALESSIO: Date le premesse, sì. E Cartesio si è affaticato per tutta la vita a cercare quel punto di connessione.
SABINA: Con quale risultato?
ALESSIO: Pensò di averlo trovato, almeno in via d’ipotesi, nella "ghiandola pineale" del cervello.
SABINA. Perché proprio quella?
ALESSIO: Semplicemente perché era l’unica parte del cervello apparentemente isolata, cioè che non rispettava la simmetria bilaterale. Dunque "doveva" essere qualcosa di speciale, di unico.
SABINA: Questo modo di ragionare mi ricorda un po’, se non vado errata, il metodo deduttivo di Platone.
ALESSIO: È vero, con Cartesio vi fu un ritorno al deduzionismo di tipo platonico: ogni concetto poteva e doveva essere "dedotto" a partire dalle idee chiare e distinte, prima fra tutte quella di identità fra materia e spazio. Tutto ciò che è materia, deve avere un’estensione.
SABINA: Ed è vero?
ALESSIO: Naturalmente no. Se così fosse, il vuoto non potrebbe esistere. Tutto l’universo sarebbe "pieno" di materia, dappertutto. Una specie di horror vacui, orrore del vuoto. Ma allora non potrebbe esistere neppure il movimento. Infatti, per poter "spiegare" il fatto che il movimento, dopotutto, è una realtà, Cartesio fu costretto a "inventare" nientemeno che tre diversi tipi di materia, sempre più sottile, al punto che quella più rarefatta è penetrabile da quella più compatta.
SABINA: Questo, Cartesio. Ma tornando al nostro discorso, Alessio: come "spiegare" il permanere degli enti, pur cambiando continuamente la materia di cui sono costituiti?
ALESSIO: Oh, se non c’è riuscito un genio come Cartesio…
SABINA: Non pensare di cavartela così a buon mercato.
ALESSIO: No, eh?
SABINA: No.
ALESSIO: E va bene. Tenterò di darti una risposta. Ma, se non sarà di tuo gradimento, o se non ti convincerà affatto, tu poi non prendertela con me, perché ti avevo avvertito.
SABINA: Su, poche storie.
ALESSIO: Ecco, io la vedo così – ma certo potrei anche sbagliarmi. È un fatto che le cellule che compongono il nostro corpo – questo sacco gonfio d’acqua per il novanta per cento, questa specie di spugna permanentemente inzuppata – si rinnovano ogni pochi anni, tutte, dalla prima all’ultima: dalle unghie dei piedi fino al midollo spinale e al cervello. Ma qui, giunti a un punto di tale importanza, lascia che invochi la mia divinità protettrice, la mia Musa benevola, colei alla cui tutela ci siamo affidati in questa impareggiabile notte antartica: la fulgida stella Alphard. Perché ridacchi?
SABINA: Questa tirata, proprio non me l’aspettavo.
ALESSIO: Davvero? Ma non sai che, secondo il pensiero magico e astrologico, le stelle sono esseri viventi, dotati di pensiero e sensazione, perfetti e benevoli come divinità?
SABINA. Ma tu non sei un seguace dell’astrologia e tanto meno della magia!
ALESSIO: Ebbene no, sono un volgare materialista. Pure, qualche volta mi chiedo se Giordano Bruno non avesse almeno un po’ di ragione; se la vita non sia presente – infinita – in tutto l’universo. Del resto, Schopenhauer non era su posizioni poi tanto diverse quando affermava che la volontà di vivere è presente in tutto l’universo, e si manifesta nell’incoercibile impulso riproduttivo: dai cristalli al magnetismo, su su fino agli esseri più evoluti e all’uomo, nel quale assume anche le forme superiori della creazione artistica.
SABINA: Va bene, ma ora lasciamo stare Schopenhauer e anche, se non ti dispiace, Giordano Bruno, col suo animismo e col suo panteismo; e torniamo a noi, con l’aiuto della benefica Alpahard.
ALESSIO: E sia. In breve, secondo me si tratta di questo: le cellule cerebrali, come quelle di tutto il corpo, si rinnovano in maniera graduale, in modo che le nuove sostituiscono le vecchie poco alla volta. Il numero totale delle cellule cerebrali è di 13 miliardi. Come il cervello immagazzini i ricordi, non è ancora chiaro; ma è certo che può accumularne un numero molto superiore. Pare che all’età di settant’anni, il cervello umano possa contenere qualcosa come quindici trilioni di singole cognizioni. Ciascuna cognizione è un "ricordo"; e questa marea innumerevole di ricordi, simile ai granelli di sabbia d’una spiaggia in riva al mare, ci tiene uniti al passato, alla catena degli eventi. Perciò Sabina è sempre Sabina. O, se preferisci, Sabina è la sorella gemella della Sabina di un tempo, clonata molecola dopo molecola e perfettamente riprodotta.
SABINA: Peccato che le molecole invecchino, dopotutto. E che noi viviamo morendo ogni giorno.
ALESSIO: Già, siamo essere-per-la-morte, come diceva Heidegger.
SABINA: Ma perché? Le cellule sono potenzialmente immortali.
ALESSIO: Lo chiedi a me? Sei tu la biologa.
SABINA: Nessuno lo sa. Ma lasciamo stare la biologia e torniamo alla filosofia, me ne hai fatto un po’ innamorare. Accettare l’esistenza, come dicevi prima, non vuol dire rinunciare alla lotta?
ALESSIO. La lotta va bene: ci mette in pace con la nostra coscienza. Ma quanto ad avere una reale efficacia sulla realtà, questo è un altro discorso.
SABINA: Ah già, ricordo le cose che dicevi l’altra notte. Tutto procede secondo una logica necessaria, per una causalità determinata dalle leggi fisiche della materia. Anche le nostre ribellioni, quindi?
ALESSIO: Anche quelle: la libertà è solo apparente.
SABINA: Pure, le possibilità sono infinite.
ALESSIO: È vero: sono infinite, in quanto possibilità. Ma nel passaggio dalla possibilità alla effettualità, da infinite che erano non ne resta che una: quella che si realizza.
SABINA: Non ti seguo bene. Certo che ne resta una sola: l’evento è il realizzarsi di una di quelle infinite possibilità.
ALESSIO: È come se ti dicessi: chiudi gli occhi, ho qui, in questo sacco, infiniti gioielli. Ma tu puoi riceverne uno solo, a occhi chiusi, e non ti è concesso vedere gli altri. Devi solo credere che ci sono. Ma per quel che ne sai tu, nel sacco potrebbe anche essercene uno solo – e il resto del volume, cartaccia. E allora, tu hai ricevuto quello non perché lo hai scelto, ma perché io ho scelto per te; ho scelto di darti quell’unico gioiello che avevo messo nel sacco.
SABINA: Vuoi dire che il concetto di possibilità, e quindi di libertà, è un semplice paradosso?
ALESSIO: Sì. È come quel negozio che espone il cartello: "Oggi non si fa credito, domani sì. Colui che vorrebbe acquistare a credito, ritorna l’indomani: ma il cartello è ancora lì. Aspetta un altro giorno e poi torna, ma sempre legge scritto: "Oggi non si fa credito, domani sì".
SABINA: Quindi, io non posso "scegliere" fra vivere del passato e vivere del futuro?
ALESSIO: Secondo me, tu – come tutti- puoi solo accettare l’insieme del tempo: passato, presente e futuro. Certo, in teoria puoi scegliere: ma cosa scegli, in realtà? Scegli la possibilità che ti ha scelto. Credi di aver agito liberamente, ma hai solo compiuto un movimento necessario.
SABINA: E tutto è un’illusione?
ALESSIO: Prendiamo il caso di Kierkegaard, il filosofo che più di ogni altro ha insistito sui concetti di libertà e di scelta. La vita, per lui, ci pone di fronte a dei radicali aut-aut: bisogna scegliere o questo o quello. Pure, proprio la sua vita dimostra l’illusorietà della scelta. Proprio per non dover scegliere una concreta e determinata possibilità, ha rifiutato sistematicamente l’atto della scelta. Ha rifiutato di fare il pastore luterano, pur avendo studiato teologia per accontentare il desiderio di suo padre morente. Ha rifiutato il matrimonio con Regina Olsen e ha rotto il fidanzamento, pur essendo sempre innamoratissimo di lei. Ha rifiutato di essere uno scrittore, pur avendo dedicato tutta la sua vita a scrivere: ma si è nascosto dietro una lunga serie di misteriosi pseudonimi. Insomma, lui per primo si è reso conto che, per essere liberi, bisogna non scegliere. Scegliere è sempre scegliere una sola possibilità, quindi tornare a chiudersi nella catena della necessità, che è la negazione stessa della libertà.
SABINA: Quindi, si può dire che l’uomo è libero nella misura in cui non sceglie effettivamente, e quindi non agisce?
ALESSIO: Direi meglio: crede di essere libero.
SABINA: Non è un po’ paradossale?
ALESSIO: Oh, lo è certamente.
SABINA: E allora…?
ALESSIO: Niente. Il paradosso non risiede nel ragionamento che lo individua, ma nella condizione umana. Immaginati un uomo poverissimo, che se ne vada in giro dicendo, tutto tronfio d’orgoglio: "Io sono ricco!"; al che tu gli fai: "Dimostramelo"; e lui: "Non posso: se ti mostrassi la mia ricchezza, in quel preciso istante la perderei!". Tu cosa penseresti?
SABINA: Che quell’uomo è un bel cialtrone.
ALESSIO: E perché?
SABINA: Perché si vanta di possedere una cosa che non gli appartiene.
ALESSIO: Giusto. Ebbene. Tale è la posizione di chi afferma: "L’uomo è libero di fare infinite cose!", ma, quando gli si chiede di mostrarle, risponde: "Non posso! Se lo facessi, perderei le mie infinite possibilità e non me ne resterebbe che una."
SABINA: Carina come similitudine. Pure, non sono interamente convinta: c’è qualcosa che non mi torna.
ALESSIO: Allora, propongo di riesaminare la questione.
SABINA: Va bene. Immaginiamo di giungere a un incrocio sconosciuto: davanti a noi ci sono quattro strade praticabili. Non sappiamo quale sia quella giusta, perciò ci soffermiamo a riflettere a lungo. Alla fine, dopo aver valutato il pro e il contro, decidiamo di imboccarne una: per esempio quella che va a sinistra. D’accordo?
ALESSIO: Sì, ti sto seguendo.
SABINA: Ecco, ora io mi domando: come si fa a dire, dopo che ho fatto la mia scelta, che in realtà non ero libera di farla, perché averne scelta una annulla, di fatto, le altre possibilità, cancellando così l’idea stessa di libertà? Infatti, prima che io scegliessi, le mie brave quattro possibilità erano tutte lì, stese davanti a me: tanto è vero che avrei potuto benissimo scegliere di andare non a sinistra, ma a destra, oppure avanti o indietro. Non è così?
ALESSIO: Hai reso perfettamente l’idea.
SABINA: E cosa risponderesti?
ALESSIO: Primo, che tu credevi di essere libera di andare a sinistra o a destra o avanti o indietro. Invece sei andata a sinistra perché, in favore di quella strada, c’era un peso schiacciante di probabilità favorevoli. Secondo, che proprio l’aut-aut radicale esclude che di vera libertà si tratti. Libertà è scelta fra possibilità diverse: ma come posso conoscerle, come posso sapere che sono realmente diverse, se non posso sperimentarne che una sola, e perciò dopo aver fatto la mia "scelta"?
SABINA: Come sarebbe? Io so che cos’è la sinistra: è la direzione che, trasferita su un atlante geografico, indica l’ovest, cioè il punto cardinale ove il Sole tramonta. E so cos’è la destra e che cos’è l’est: è il punto cardinale ove il Sole sorge. Dunque, se scelgo la strada a sinistra so quello che scelgo; e se non scelgo la strada a destra, so anche quello che ho scartato.
ALESSIO: Ne sei proprio sicura?
SABINA: Sì. Credo di sì.
ALESSIO: E se così non fosse?
SABINA: Sarebbe a dire…?
ALESSIO: Sarebbe a dire che, forse, la strada dell’est non ti porterà verso il Sole che sorge, ma verso il Sole che tramonta. Mentre se tu avessi imboccato la strada dell’ovest, forse saresti arrivata dove il Sole sorge e non dove tramonta.
SABINA: Parli di una geometria non euclidea?
ALESSIO: O di un banalissimo errore di valutazione. Forse, giunti al tuo crocicchio, le quattro strade sembrano partire ciascuna in linea retta formando angoli di novanta gradi l’una con l’altra; e, invece, finivano per descrivere delle linee curve, tornando ciascuna verso la direzione opposta. Guarda, te lo disegno su questo bloc-notes. Vedi? Tu credevi che l’incrocio fosse come una classica rosa dei venti, formata da quattro angoli retti, così: ╬, e invece, se il nostro ipotetico viandante avesse potuto osservare quel luogo a volo d’uccello, come le cosiddette "piste" di Nazca nel Perù – che si possono vedere solo da un aereo – gli si sarebbe offerto più o meno questo spettacolo: una specie di spirale doppia.
SABINA: Ogni scelta implica un certo rischio.
ALESSIO: Non rischio, ma inganno. Quando la realtà è tutto l’opposto di quel che ci saremmo aspettati…
SABINA: Ma nessuno ci aveva garantito la certezza a priori.
ALESSIO: Dunque, la nostra non era stata una vera scelta, ma una parodia di scelta, una farsa.
SABINA: Certo, ci sono dei ragionamenti.
ALESSIO: Chi oserebbe definire regolare una partita ai dadi, sapendo che essi sono truccati?
SABINA: Dio è un baro?
ALESSIO: Battute a parte, c’è una sostanziale differenza. Noi sappiamo che i dadi sono truccati, dunque sappiamo che la partita è un gioco d’azzardo. Lo sappiamo, eppure blateriamo che tutto è a posto, che tutto è regolare. Siamo vittime di un inganno che non viene tanto dall’esterno, quanto da noi stessi. Preferiamo dare la colpa alla sfortuna, piuttosto che riconoscere la nostra ignoranza e la nostra impotenza. Così, se a dispetto dei dadi truccati la partita ci va bene, il merito sarà tutto nostro; se perdiamo e ci va male, la colpa sarà di Dio, del caso, del destino, e chi più ne ha, più ne metta.
SABINA: Sì, per ora mi hai convinto. Ma mi riservo di pensarci su e di tornare sull’argomento, eventualmente.
ALESSIO: Poi c’è un altro fatto importante, di cui è necessario tener conto.
SABINA: Quale?
ALESSIO: Scegliere implica un atto della volontà, ma anche un modo della conoscenza. Si sceglie quel che si conosce, a rigore: si crede di scegliere quel che si crede di conoscere. Ma la conoscenza non è solo un’operazione dell’intelletto, come credeva Cartesio.
SABINA: Quando parlava delle idee "chiare e distinte"?
ALESSIO: Anche. Più in generale, per Cartesio la mente è in grado di osservare la materia, la res extensa, con assoluto distacco scientifico.
SABINA: Che è, poi, la posizione della scienza moderna.
ALESSIO: Appunto, figlia di Cartesio; almeno nel senso di una spietata, radicale "despiritualizzazione" della materia. Quel che resta è una materia bruta, inerte, assolutamente passiva e totalmente separata dalla mente. E la conoscenza è un cristallino fra il soggetto e l’oggetto: conoscere il mondo è osservare, con il più completo distacco, la pura estensione della materia.
SABINA: E invece…?
ALESSIO: E invece, come sosteneva Giordano Bruno, conoscere è uno slancio dell’anima verso le cose: sapienza e amore. È la sua teoria degli heroici furori. La mente, pervasa da un sublime slancio di amore per la bellezza, si accende al fuoco del desiderio e s’innalza al di là delle sue facoltà ordinarie: è presa da un rapimento mistico che la rende simile a Dio.
SABINA: Questo mi ricorda un po’ Platone.
ALESSIO: È vero, e precisamente la teoria dell’identità di bellezza, amore e sapienza, così com’è esposta nel Simposio, e che fu una vera e propria Bibbia per i filosofi del Rinascimento.
SABINA: Cioè, conoscere è partecipare della realtà delle cose?
ALESSIO: Certo. È immergervisi, fondersi con essa.
SABINA: L’avevo avuto, l’altra notte, il sospetto che in te si celasse una nostalgia dello spirito magico.
ALESSIO: Nel senso che la magia postula una simpatia universale fra tutte le cose?
SABINA: Sì. Per la visione magica, tutto agisce su tutto.
ALESSIO: Ma io mi sento di sottoscrivere una tale affermazione. Solo che la magia la interpreta nel senso più grossolano e materiale, come fa – ad esempio – l’astrologia. Eh, tutte sciocchezze!
SABINA: Invece…?
ALESSIO. Certo che tutto ha influenza su tutto. Ma non è un’influenza soprannaturale, è naturale, naturalissima. E poi, chissà perché i maghi pensano che certe cose ci influenzino e altre no: si contraddicono da sé stessi.
SABINA: Per esempio?
ALESSIO: Per esempio l’astrologia. Gli astrologi affermano che la nostra vita è influenzata dalle dodici costellazioni dello Zodiaco: quelle, cioè, che giacciono a cavallo dell’Eclittica, la linea formata dal movimento apparente del Sole fra le stelle. Ma perché proprio da quelle dodici, e non dalle altre? O dal Sole, o dalla Luna? Oltretutto, le costellazioni sono una pura illusione prospettica. Ci appaiono tali dal nostro particolare punto di osservazione nell’universo, cioè il pianeta Terra. Ma due stelle di una medesima costellazione possono essere, fra loro, infinitamente più lontane di due stelle di costellazioni fra loro lontanissime, o meglio, che ci sembrano lontanissime. Se poi, a bordo di un’astronave, uscissimo dalla nostra galassia, vedremmo ancora le stesse stelle, ma collocate in posizioni totalmente diverse. Non ci capiremmo più nulla, per il semplice fatto che le cosiddette "costellazioni", in realtà, non esistono.
SABINA: Bene, ora però torniamo al problema della conoscenza. Mi sembra di aver colto una contraddizione nel tuo pensiero, o forse sono io che non ho capito bene. Prima avevi affermato che noi crediamo soltanto di conoscere le cose, che ci autoinganniamo deliberatamente, per stupidità e per orgoglio. Non è così?
ALESSIO: Sì.
SABINA: Ora, però, hai detto che la conoscenza è uno slancio di amore verso le cose, un atto di partecipazione ad esse. Dunque, dopo tutto, è un qualche cosa di possibile?
ALESSIO: No, certo; noi non conosciamo un bel niente. Però sono convinto di una cosa: che se la conoscenza come atto distaccato e puramente razionale è il più improbabile degli eventi che possano verificarsi, qualche infinitesima probabilità in più l’abbiamo cercando di conoscere mediante lo slancio dell’anima, cioè con un atto di amore.
SABINA: Anche prima, se non erro, hai usato la parola "anima". Ma allora, che razza di materialista sei?
ALESSIO: Un cattivo materialista, uno spiritualista non ancora intimamente persuaso. Come un triste prete spretato.
SABINA: Povero padre Alessio! Dello spretato hai anche il furore anticlericale, mi correggo, l’"eroico furore".
ALESSIO: Sì, è una vita ben grama quella di noi spretati. Ci accompagna e ci perseguita, come un’ombra fedele, qualcosa di malinconico e di patetico. Il nostro odio, probabilmente.
SABINA: Che è l’altra faccia della vostra nostalgia.
ALESSIO: Oh, sì. Se il nostro orgoglio ce lo permettesse, ci getteremmo piangendo ai piedi della Chiesa, gonfi di pentimento e di acre voluttà.
SABINA: Ho sempre pensato che in ogni figliuol prodigo vi fosse, essenzialmente, un sensuale.
ALESSIO: Ah, divina sensualità del pentimento! Sentirsi scorrere le lagrime giù per il viso, sprofondare in un’estasi di umiliazione. Ah, beatitudine suprema della vergogna!
SABINA: Ora basta, padre Alessio! Lei si sta avvicinando pericolosamente all’orgasmo intellettuale. Il suo pentimento altro non è che un’indegna commedia, un cavallo di Troia per la sua diabolica sensualità.
ALESSIO: Non mi resta che questo misero surrogato di piacere, da quando un destino crudele mi ha spezzato il cuore.
SABINA: Che dice mai?
ALESSIO: Sabina, Sabina, tu lo sai bene cosa voglio dire…
SABINA: Questo è uno dei tuoi colpi bassi.
ALESSIO: Già. Lo hai notato? Quando si è disperati, si tende a diventare anche cattivi.
SABINA: Non è cattiveria; è sofferenza. E non sai quanto mi rattristi esserne la causa.
ALESSIO: Via, al bando i sensi di colpa. Ferri vecchi di un cristianesimo rancido e andato a male.
SABINA: Sì, certo, alla malora i sensi di colpa. Però vedo un’ombra profilarsi sulla nostra amicizia.
ALESSIO: È solo un falso allarme. Ti chiedo di darmi un po’ di tempo, di avere pazienza. La mente può accettare la realtà più in fretta del cuore. È il cuore che fa le bizze… Ma presto anche lui si calmerà.
SABINA: Ti chiedo molto, lo so. Chiedere amicizia alla persona che ci ama è il massimo dell’impertinenza.
ALESSIO. O della fiducia. Io l’ho presa in questo secondo senso.
SABINA: E io te ne sono grata, molto più di quanto tu possa immaginare.
ALESSIO: Bene, non parliamone più.
SABINA: Sai, in fondo io sono sempre stata sola. Non parlo della semplice solitudine materiale, naturalmente.
ALESSIO: Guarda…! Un’altra stella cadente.
SABINA: A proposito. Non me lo vuoi dire, adesso, quale desiderio avevi pensato l’altra notte? Ricordi?
ALESSIO: Ah, sì, ricordo. Bene, te lo dirò a patto che anche tu mi dica quello che avevi pensato tu.
SABINA: Va bene.
ALESSIO: Avevo pensato quanto sarebbe stato bello avere delle altre notti come quella, qui affacciato sotto l’immenso cielo del Sud, insieme a te. E sono stato fortunato, perché quel desiderio si sta avverando.
SABINA: Io avevo pensato che vorrei realmente far tesoro di questa esperienza in Antartide. Ma non solo e non tanto dal punto di vista scientifico, ma per me stessa, per la mia vita. Di poter vedere più chiaro in me stessa; di poter tornare a casa, fra sette mesi circa, con qualche certezza in più.
ALESSIO: Sabina la confusa, Sabina la perplessa. Certo che non lo dimostri affatto, nel tuo modo abituale di porti. Sembri non solo disinvolta, ma anche serena e perfino allegra.
SABINA: Sì, ma non recito, sono spontanea anche in mezzo ai dubbi. Non so come spiegarti, è come se vivessi contemporaneamente su due binari.
ALESSIO: Posso chiederti se c’è qualcuno nella tua vita sentimentale, in questo momento?
SABINA: Il mio migliore amico può chiedermi quello che vuole. No, adesso non più.
ALESSIO: Perché mi hai detto, prima, che se mi avessi conosciuto dieci anni fa, la tua vita avrebbe potuto essere diversa?
SABINA: Perché è faticoso, essere come sono io. E anche perché mi sarebbe piaciuto condividere con te l’esperienza dell’amore.
ALESSIO: Comunque, noi ci vogliamo bene lo stesso.
SABINA: Sì, tanto.
ALESSIO: Allora, bando alle malinconie. Hominem cognosces dignum, qui a te diligatur: Cicerone.
SABINA: Traduci: "Conoscerai un uomo…"
ALESSIO: "Conoscerai un uomo, degno di essere amato da te." Oh, cavolo, la mia solita gaffe.
SABINA: Intendevi dire: "Conoscerai una donna". Bene, ho capito e apprezzo ugualmente l’intenzione. Ma visto che siamo in vena di citazioni classiche, cosa ti ispira questa notte senza luna? Non il solito Virgilio, se è possibile, con tutto il rispetto per lui.
ALESSIO: Mi fa venire in mente il celebre Notturno di Alcmane:
"Dormono le grandi cime
dei monti,
e i dirupi e le balze,
e i noti letti dei torrenti;
dormono tutti gli animali che strisciano
sopra la terra nera,
e le belve dei monti, e il popolo
delle api;
dormono i mostri giù nel fondo
del buio mare inquieto;
dormono gli uccelli
dalle lunghe ali distese."
SABINA: Non ho parole, questi versi sono troppo belli. Quando furono scritti?
ALESSIO: Di Alcmane sappiamo poco o niente, se non che visse a Sparta nella seconda metà del VII secolo avanti Cristo. Anche della sua opera poetica ci restano appena pochi frammenti: ma hanno lo splendore dei lampi fra le nubi di un cielo tempestoso.
SABINA: "…dormono i mostri giù nel fondo
Del buio mare inquieto…"
ALESSIO: È una traduzione così così. Il testo originale recita:
"καί κνωδαλ’ έν βένθέσσί πορφυβέάς αλός".
SABINA: Pensare che furono scritti 2.600 anni fa. No, l’uomo oggi conosce certo più cose, ma non ha imparato a esprimerle meglio.
ALESSIO: Non è neanche detto che noi conosciamo più cose. Forse, quello che tu chiami "esprimerle meglio" significa, in realtà, "esprimere anche ciò che sta in penombra, suggerire l’inesprimibile, ma avendone conoscenza intuitiva e simbolica, non esclusivamente razionale". Pensa: forse, in questo preciso momento, i mostri del mare dormono veramente sotto la chiglia della nostra nave. E intanto il mare a noi sembra così quieto, così rasserenante…
SABINA: Sai qual è la profondità, nel punto ove ci troviamo noi adesso?
ALESSIO: Piuttosto notevole. Siamo nel mezzo del Bacino Australiano Meridionale. Credo che il fondo sia a più di cinquemila metri.
SABINA: Cinquemila metri! Un abisso spalancato: ci metteremmo parecchi minuti prima di toccare il fondo, se la nave per qualche motivo dovesse affondare.
ALESSIO: Pensieri da brivido. Ma, a volte, è piacevole anche il brivido della paura, se si è alla distanza sufficiente per osservare il pericolo da lontano…
SABINA: Già, ricordo un brano di Lucrezio. Sai, dove dice come sia rassicurante guardare il naufragio di una nave, dal sicuro rifugio della riva:
ALESSIO: Credo che dica più o meno così:
"Suave, mare magno turbantibus aequora ventis,
e terra magnum alterius spectare laborem;
non quia vexari quemquamst iucunda voluptas,
sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est".
SABINA: Vediamo un po’… "È bello guardare dalla riva, mentre il vasto mare è sconvolto dai venti, le gravi difficoltà altrui…". Vado bene fin qui?
ALESSIO: Perfettamente.
SABINA: Finisci tu di tradurre.
ALESSIO: "…non perché sia fonte di gioia il fatto che qualcuno soffra, ma perché è cosa dolce vedere i mali da cui siamo liberi."
SABINA: Sai, io ti ammiro. Tu sei riuscito a trovare uno scopo nella vita: la cultura, il sapere. È molto.
ALESSIO: La cultura è il mezzo; il sapere, il fine. Diciamo che sono riuscito a individuare alcuni mezzi – senza escludere che ve ne siano degli altri, magari più efficaci. Quanto al fine, ne sono lontanissimo.
SABINA: Come Socrate, che diceva di non sapere niente? Anzi, per essere precisi, che affermava di sapere che non sapeva nulla?
ALESSIO: No, Socrate era un po’ cialtrone quando affermava questo – un pochino solo, ma lo era. Voglio dire che lo diceva, ma non lo pensava affatto. Io, invece, lo penso davvero.
SABINA: È un fatto che le persone più colte che ho conosciuto nella mia vita – ma quelle veramente colte – dicono tutte di essere molto lontane dal possesso della sapienza.
ALESSIO: Comunque, mi sopravvaluti. Ma tu, piuttosto, perché dici che io sono fortunato ad aver trovato uno scopo nella vita? Tu, invece, pensi di non averlo trovato?
SABINA: Mettiamola così: tu l’hai trovato, ma non l’hai raggiunto. Io non l’ho raggiunto per il semplice fatto che non l’ho nemmeno trovato.
ALESSIO: Non che trovarlo sia cosa da poco.
SABINA: Anzi, da molto. È per questo che ti ammiro, e lo penso sinceramente.
ALESSIO: Propongo di dare questo indirizzo alla conversazione di stanotte: quale sia lo scopo più degno per la vita umana.
SABINA: Proposta approvata all’unanimità.
ALESSIO: Da dove partiamo?
SABINA: Non dal fatto che la vita è priva di scopo, per favore. Ne abbiamo già parlato la notte di Fomalhaut.
ALESSIO: Non ne avevo alcuna intenzione.
SABINA: Anche se fosse come tu dici, bisogna pur cercare di dargliene uno. Altrimenti la vita sarebbe intollerabile.
ALESSIO: Sono perfettamente d’accordo.
SABINA: Molto bene.
ALESSIO: Per te, qual è la cosa più importante nella vita?
SABINA: Essere felici, credo.
ALESSIO: E credi bene. Chiunque desse una risposta diversa, non sarebbe che un ipocrita o un masochista.
SABINA: Tutti gli esseri tendono alla felicità.
ALESSIO: Però, l’altra notte avevamo riflettuto che la vita non è un valore in se stessa, a priori.
SABINA: E io avevo sostenuto che una forza cieca ci tiene tuttavia attaccati alla vita; e che la fonte da cui più generosamente si alimenta questo cieco attaccamento, è l’odio.
ALESSIO: Sì, l’odio che ci tiene veramente aggrappati alla vita. Questo avevi detto; e poi avevamo citato qualche frase di Cioran.
SABINA: O, come surrogato all’impotenza dell’odio, il sesso.
ALESSIO: Dunque, prima ancora che alla felicità, tutti gli uomini tendono a vivere. Così, ciecamente, anche senza uno scopo, anche senza felicità.
SABINA: Ma non senza la speranza della felicità.
ALESSIO: No, senza la speranza, mai. Ottimo, vedo che ricordi perfettamente tutte le cose che avevamo detto.
SABINA: A questo punto, mi pare che si possa fare un’ipotesi. Questo cieco attaccamento alla vita, non sarà il principale ostacolo al fine cui tutti gli uomini tendono, la ricerca della felicità?
ALESSIO: In che senso?
SABINA: Nel senso che il desiderio di essere felici tende ad innalzarci, mentre l’attaccamento irragionevole alla vita tende a farci ricadere verso il baso.
ALESSIO: È un’immagine poetica e molto bella, ma cosa intendi per "innalzare" ed "abbassare"?
SABINA: Voglio dire che l’istinto della felicità è leggerezza, fantasia, coraggio. Mentre l’istinto della cieca sopravvivenza è pesantezza, assoluta mancanza di libertà, paura.
ALESSIO. Ma esiste, poi, codesta felicità, o è come l’araba Fenice,
"che vi sia ciascun lo dice,
dove sia nessun lo sa"?
SABINA: No, non esiste. I Romani, che erano gente pratica, non avevano neanche la parola corrispondente, vero?
ALESSIO: Non proprio; la parola felicitas esisteva, ma indicava piuttosto la buona fortuna: felicitas rerum gestarum designava l’esito fortunato delle imprese. Oppure felicitas indicava la fecondità, la fertilità, specialmente della terra coltivata – erano un popolo di contadini, dopotutto. Molto più raramente indicava la "felicità" come la intendiamo noi. Nel latino tardo della Chiesa, poi, passò a designare la beatitudine celeste, ultraterrena.
SABINA: E i Greci?
ALESSIO: Stesso discorso che per i Romani. In greco antico "felicità" si rende con "ευδαιμονία", ma indica soprattutto uno stato di benessere, di agiatezza.
SABINA: Comunque, non è questo il punto. Tutti gli uomini tendono verso la felicità. E, quando si dice che vi tendono, è sottinteso che la felicità non può mai essere veramente posseduta, che sempre sfugge come la sabbia tra le dita. Ma che importa?
ALESSIO: D’accordo. Scusa, prosegui pure il tuo ragionamento.
SABINA: In ogni caso, la speranza della felicità ci sorregge: come ha descritto magistralmente Leopardi nel Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. E la vita felice non è mai questa, che abbiamo ora; ma quella che verrà, quella del futuro. Tale speranza ci dà la forza di compiere le imprese più faticose, più sovrumane, di sottoporci a sacrifici durissimi: di trascendere, quasi, i nostri stessi limiti.
ALESSIO: Sì, nessuno si sobbarcherebbe a tali imprese, se non lo sostenesse una qualche speranza di felicità.
SABINA. Ma l’istinto dell’attaccamento alla vita è ancora più forte. Esso viene prima di qualunque ragionamento, ha la forza stessa dell’irragionevolezza. Ci incatena alla terra, non ci permette di guardare in alto. Ne consegue che è impossibile, per chi sia ciecamente attaccato alla propria vita, essere felice o anche solo innalzarsi di un poco verso la felicità. Io chiamo felice colui che è pronto a rinunciare alla vita in qualunque momento, ma in vista di un fine più alto.
ALESSIO: Per dirla con Kierkegaard: solo chi è pronto a rinunciare serenamente a tutto, è degno di ritrovare ogni cosa.
SABINA: Sì. Può sembrare un paradosso, e forse lo è; ma la vita, in fondo, è fatta di paradossi.
ALESSIO: Ma io vedo anche un altro paradosso nel tuo ragionamento.
SABINA: Quale?
ALESSIO: Ci chiedevamo quale scopo meriti il vivere, ma poi hai affermato che solo chi vive senza attaccamento, solo chi è pronto a rinunciare a tutto – anche alla vita – può avvicinarsi alla felicità.
SABINA: E dov’è il paradosso?
ALESSIO: Nel fatto che la felicità è il fine cui tutti tendono, e sia pure illusoriamente; ma non può essere lo scopo della vita. Lo scopo della vita è liberarsi dal cieco attaccamento, senza di che la vita stessa cessa di essere un valore. Cioè, la felicità – o meglio, il tendere verso di essa – è una conseguenza del saper rinunciare a tutto, anche alla vita, se occorre: è una conseguenza di un certo modo di vivere, non uno scopo da prefiggersi.
SABINA: Sì, è vero. Voler essere felici è una dichiarazione d’intenti, non uno scopo, la felicità ti è data per premio, se sei così coraggioso da essere disposto a perderla. È come una bella donna che fugge sempre, quando cerchi di afferrarla, e ti lascia solo il velo ra le mani; ma se sarai forte e andrai per la tua strada, forse sarà lei a venirti a cercare.
ALESSIO: E allora, torniamo a porci la domanda: quale deve essere lo scopo della vita?
SABINA: La conoscenza, credo.
ALESSIO: La conoscenza di che cosa?
SABINA: La conoscenza. Di tutto. Conoscere.
ALESSIO: Oltre le colonne d’Ercole?
SABINA: Sì. E per prima cosa, oltre la superficie di se stessi. La maggior parte degli uomini vive senza compiere questa navigazione decisiva. Non conoscono se stessi, quindi non sanno niente di niente. Non hanno abbastanza fegato per togliersi la maschera. Nascondono la loro vigliaccheria dietro una quantità di viaggi e studi e parole, parole. Non sanno niente.
ALESSIO: Io mi metterei fra costoro.
SABINA: No, non direi.
SABINA: Pure, sono ben lontano dal conoscermi. Dunque, al mio sapere manca sempre l’essenziale.
SABINA: L’essenziale non è conoscersi: è cercarsi. Sapere che la verità non è quella con cui riusciamo così bene a darla a intendere agli altri. Sapere che possiamo bluffare con chiunque, tranne che con noi stessi.
ALESSIO. Va bene. Ma perché la conoscenza è il bene supremo?
SABINA: Perché ci mette in armonia col mondo, ci restituisce il senso dell’equilibrio e dell’appartenenza. E quindi ci dà uno scopo: essere parte di un tutto, riconquistare la perduta unità con le cose. Senza una tale consapevolezza, noi non siamo altro che rami secchi, fiori recisi. Nient’altro che esseri alienati e stralunati, senza senso e senza scopo.
ALESSIO: Questo punto di vista presuppone una logica di apertura, di positività, di accoglienza: tutto l’opposto della logica del dominio, della negatività, della chiusura oggi dominanti.
SABINA: Sì, tutto nasce dall’arroganza dell’ospite che si trasforma in padrone, che vuol soggiogare e appiattire la varietà e la molteplicità del reale, invece di riconoscersi parte di esso.
ALESSIO: Ma tutto ciò, come si concilia con l’elogio dell’odio che tu hai fatto l’altra notte, anzi all’elevazione dell’odio alla dignità di massima terapia universale al male di vivere?
SABINA: Ti ho proprio colpito, eh? Ma l’odio può essere, semplicemente, una necessità fisiologica, un tonico salutare che non potrà mai far tanto danno quanto il dominio organizzato, la gerarchia istituzionale camuffata da moralità, legalità, benessere e progresso. Ma quale progresso?
ALESSIO: Sabina, mi sei sempre più simpatica. Ora scopro che sei addirittura un’anarchica!
SABINA: E perché no? La logica del dominio, che trova la sua massima espressione nello Stato, nel capitale, nell’apparato tecno-scientifico mi fa molta più paura di qualsiasi anarchismo. Non è l’irrequietezza del singolo che dobbiamo temere, ma il mostruoso e brutale appiattimento praticato dai poteri forti: dai governi, dalle chiese, dalle lobbies della finanza internazionale.
ALESSIO: Ma questi poteri forti hanno bisogno di mantenere gli individui in uno stato di isolamento, di alienazione, di disumanizzazione. L’individuo alienato non pensa, non cerca, non sa niente. Non sa quel che gli manca, non sa come potremmo vivere se rifiutassimo la logica del dominio e della gerarchia. Cerca di stordirsi accumulando e consumando beni inutili, senza fermarsi mai.
SABINA: Ecco, questa per me è la scienza: una palestra per il pensiero. Un modo per riappropriarsi della propria mente.
ALESSIO: Noi, comunque, facciamo parte di uno di quei poteri forti: è l’apparato tecno-scientifico che ci finanzia, che ci manda in Antartide.
SABINA: Giordano Bruno e Tommaso Campanella, coloro che hanno aperto la battaglia per la libertà del pensiero, erano frati domenicani. Cioè, stavano dentro uno dei massimi poteri forti della loro epoca: la Chiesa cattolica.
ALESSIO: Erano ex frati.
SABINA: Voglio dire che proprio all’interno dei poteri forti si formano i virus che li metteranno in crisi.
ALESSIO: Senza contare che c’è compromesso e compromesso.
SABINA: Appunto. Noi non stiamo collaborando alla costruzione della bomba atomica.
ALESSIO: D’accordo. Del resto, avremo occasione di riparlarne se e quando verremo messi alla prova.
SABINA: Nel frattempo, bisogna affilare la mente come una lama di coltello. Sforzarsi di capire, per essere pronti ad agire in qualunque momento.
ALESSIO: Sabina la guerrigliera.
SABINA: No. Mi accontento di potermi guardare allo specchio, la mattina, senza che mi venga voglia di sputarmi in faccia. In fondo, Alessio, non chiedo molto, non ti sembra?
ALESSIO: Certo, non è molto. È un minimo cui tutti dovrebbero aspirare. E forse vivremmo in un ambiente un po’ più ecologico, un po’ meno sgradevole, in tutti i sensi. Però, forse sei un po’ troppo socratica, un po’ troppo ottimista se pensi davvero che dalla conoscenza scaturisca automaticamente un uomo migliore, e quindi una scelta più giusta.
SABINA: Sì, può darsi. Sarebbe bello se dall’etica si potessero trarre delle leggi rigorose, come quelle della matematica. Sai, questa è una cosa che mi ha sempre affascinato.
ALESSIO: Che cosa?
SABINA: La certezza assoluta della matematica, la sua perfezione; soprattutto della geometria. Le teorie scientifiche sono incerte, soltanto probabili: ma, prima o poi, vengono sempre rimesse in discussione. Invece il teorema di Pitagora è sempre lì, fermo come una roccia che sfida i secoli e i millenni; che dico, sfida tutta l’eternità. Sempre, finchè vi saranno il cielo e la Terra, in un triangolo rettangolo (costruito su una superficie piana) il quadrato costruito sull’ipotenusa sarà uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. E non per questo o quel triangolo rettangolo, non per dieci o cento o mille triangoli rettangoli, ma per tutti gl’innumerevoli, anzi per tutti gl’infiniti triangoli rettangoli che si possono costruire o anche soltanto immaginare, e questo rimarrà in saecula saeculorum.
ALESSIO: Amen. E tu speri che un tale grado di certezza si possa raggiungere anche nella sfera morale?
SABINA: No, naturalmente; è solo un sogno a occhi aperti.
ALESSIO: Alcuni filosofi ci hanno provato, comunque.
SABINA: Davvero? Quali?
ALESSIO: Spinoza, per esempio. E Leibniz. Anche Bertrand Russell, in tempi a noi vicini.
SABINA: Immagino che non siano arrivati a dimostrare un gran che.
ALESSIO: No, infatti. Anche se l‘Etica more geometrico demonstrata di Baruch Spinoza è molto elegante. In senso matematico, voglio dire.
SABINA: E Leibniz?
ALESSIO: Leibniz non ha saputo far di meglio che affermare che noi viviamo nel migliore dei mondi possibili; e dunque, tutto sommato, si dovrebbe concludere che potremmo accontentarci.
SABINA: Con quale ragionamento ha fatto quell’affermazione?
ALESSIO: Col principio di non-conraddizione. Dio è l’essere prefettissimo; il mondo è stato creato da Dio; dunque il mondo è stato creato nella forma più perfetta possibile.
SABINA: Tutto ciò non è molto matematico.
ALESSIO: No, non lo è.
SABINA: Per prima cosa, bisognerebbe dimostrare che Dio esiste e non semplicemente affermarlo.
ALESSIO: Già.
SABINA: E per seconda, il ragionamento di Leibniz mi sembra negare la libertà di Dio. Questo mi sembra un curioso paradosso. L’essere perfettissimo non possiede il bene della libertà? La libertà sarebbe, dunque, un privilegio degli esseri finiti e imperfetti? Detto questo, mi sento però di spezzare una lancia in favore di Leibniz. Che noi viviamo nel migliore dei mondi possibili, non significa che viviamo in una specie di paradiso terrestre: "migliore" è comparativo di maggioranza e non ha valore di superlativo assoluto. In fondo, vuol dire soltanto che viviamo nel mondo meno peggiore; il che, oltretutto, per un credente è perfettamente logico. Che da ciò noi si possa dormire tra due guanciali, è una conclusione indebita, non contenuta nella premessa.
ALESSIO: Hai ragione, la tua osservazione è pertinente e mi induce a guardare per la prima volta Leibniz sotto una luce nuova, più simpatica e interessante. Ma tornando a Dio, tu come lo vedresti?
SABINA: Secondo me, l’idea di Dio dovrebbe andare oltre le coppie di opposti buono-cattivo, bello-brutto, giusto-ingiusto. Questo è un modo di ragionare antropomorficamente.
ALESSIO: Ma l’uomo può pensare in altro modo?
SABINA: No, per definizione.
ALESSIO: E allora?
SABINA: E allora Dio è un’invenzione dell’uomo.
ALESSIO: O qualcosa di totalmente inconoscibile.
SABINA: Già. Mi sembra che qualcuno abbia detto che, se i cavalli potessero pensare l’idea di Dio, lo concepirebbero come un essere equino.
ALESSIO: Non c’è dubbio.
SABINA: Resta un’altra possibilità: che a Dio non si arrivi mediante un’idea, ma attraverso una esperienza. Una esperienza interiore, ovviamente.
ALESSIO: Questa è la via del misticismo.
SABINA: Io non la disprezzerei. Uomini insigni l’hanno percorsa; e, del resto, scartata la via razionale, non ve ne sono altre.
ALESSIO: Dopo Sabina la rivoluzionaria, è il turno di Sabina la mistica. No, scherzi a parte, hai ragione. Vi sono cose che la ragione, da sola, non può attingere. Un’altra è la poesia.
SABINA: Il poeta, infatti, è un veggente: uno che vede. Che cosa? Non è certo un caso che le antiche tradizioni rappresentassero Omero come cieco. Non si tratta di vedere le cose materiali, le cose di questo mondo.
ALESSIO: Anche i bambini sono dei veggenti. Anche loro, si dice, vedono cose che agli altri non è dato di vedere, con tutta la loro ragione calcolante.
SABINA: Sì, questo lo credo anch’io. I bambini hanno dei poteri. Solo i bambini piccoli, però; quando si avvicinano all’adolescenza, perdono i loro poteri.
ALESSIO: I bambini: cioè noi stessi, prima che la ragione si affermasse in noi come l’unico approccio alla realtà. O, almeno, come l’unico approccio serio.
SABINA: Quindi noi tutti abbiamo avuto quei poteri straordinari. Poi, non soltanto li abbiamo perduti: li abbiamo perfino dimenticati.
ALESSIO: Sai, pensando a queste cose, sempre più mi vengono dei grossi dubbi sul fatto che la storia umana abbia un andamento evolutivo, cioè che progredisca da ciò che è meno perfetto verso il più perfetto. Che è un assioma-cardine della scienza moderna.
SABINA: Già. Forse non si tratta di una evoluzione, ma di una involuzione. Ci stiamo allontanando sempre più da una condizione originaria che, forse, non era afatto primitiva e scimmiesca, come vorrebbero i darwinisti, ma – al contrario – molto più armoniosa e più felice dell’attuale.
ALESSIO: Questi, come direbbe Kierkegaard, sono pensieri che feriscono alle spalle. Cioè, che ti colpiscono proprio là dove ti sentivi più sicuro e più orgoglioso della tua forza.
SABINA: Però, sono salutari. Voglio dire, ti suggeriscono un po’ di umiltà, un po’ di spirito critico rispetto al paradigma dominante.
ALESSIO: E noi siamo qui per ritrovare un po’ di spirito critico, sotto il benevolo influsso della stella Achernar, mentre tutti a bordo dormono sui morbidi cuscini delle loro riposanti e inossidabili certezze. Ma ora vediamo di riprendere il filo del discorso, e torniamo al concetto di Dio
SABINA: Prima hai citato anche Bertrand Russell. Lui, che cosa ne pensava?
ALESSIO: Oh, come tutti i neo-positivisti, lui pensava che trovare dei teoremi etici, delle leggi etiche evidenti di per sé, fosse solo una questione di tempo e di logica. Ma che, piano piano, si sarebbe pur trovato il modo, anche se lui proprio non sapeva dire quale.
SABINA: Bella roba! Io non sono intelligente come Bertrand Russell, ma non mi faccio davvero simili illusioni.
ALESSIO: E fai bene.
SABINA: Però la nostalgia di un sapere certo, e quindi di una morale sicura, mi rimane dentro.
ALESSIO: Scusa, cosa intendi per "certo"?
SABINA: Valido universalmente.
ALESSIO: Nel campo dell’etica? Lo sai bene che è impossibile. Ciò che è buono qui e ora, è cattivo laggiù, era cattivo ieri o lo sarà domani. E ciò che è buono per me, può essere cattivo per te. Hai sentito di quel padre pachistano, immigrato in Italia con tutta la sua famiglia, che ha ucciso sua figlia perché "non si comportava bene", cioè non rispettava le tradizioni e rifiutava di sposare il cugino che lui le aveva destinato come marito?
SABINA: L’ho sentito. E ammetto che le tue osservazioni sono basate sulla realtà dei fatti. Le conseguenze, però, sono terribili; e la storia di quella famiglia pachistana ne è una testimonianza.
ALESSIO: E tu credi che, se avessimo una legge morale certa, le cose andrebbero meglio?
SABINA: Forse, chissà.
ALESSIO: No, ti illudi. Il problema non è tanto la mancanza, anzi l’impossibilità di una legge morale certa. Il problema è che la morale sarà sempre carta straccia per gli esseri umani: buona da usare quando si tratta di far valere diritti, ma da gettare nel cestino non appena comporta dei doveri. Dammi retta: il più delle volte noi uomini sappiamo bene quel che andrebbe fatto; e non lo facciamo sempliemente perché non corrisponde ai nostri interessi. Tutto qui. Non ci sono ragioni metafisiche: è una cosa molto semplice, addirittura banale.
SABINA: Sempre radicalmente pessimista, vero?
ALESSIO: Forse soltanto realista.
SABINA: E sia. Anche tu, dunque, postuli una imperfezione originaria dell’animo umano; una tara, una debolezza connaturata? Ciò sarebbe in contrasto con quel che abbiamo prima ipotizzato, sul fatto che gli esseri umani – forse – anticamente erano assai più felici ed equilibrati di ora.
ALESSIO: Nessuna imperfezione. Vi sarebbe una imperfezione, se in natura esistesse il concetto di perfezione. Ma non c’è. Ogni cosa reale è imperfetta. Solo i numeri e gli enti matematici sono, a loro modo, perfetti, come dicevi tu prima e come sosteneva, duemilacinquecento anni fa, Pitagora. Ma, a differenza di quanto credeva Pitagora – che li aveva addirittura divinizzati – i numeri sono perfetti proprio perché nascono da una astrazione; una sublime astrazione. Tutta la matematica è una geniale e sublime astrazione. Per questo ho sempre pensato che è così poetica, così pura, così meravigliosamente armoniosa.
SABINA: Ma se dici che ogni cosa reale è imperfetta, reintroduci dalla finestra quel che avevi cacciato dalla porta.
ALESSIO: Certo, hai ragione. Naturalmente, volevo dire "imperfetta" rispetto a quel modello ideale che noi abbiamo in mente, astratto, puramente teorico, come lo è appunto il concetto di numero.
SABINA: Ma perché affermi che quello di numero è un concetto astratto?
ALESSIO: Perché nella realtà non esistono l’Uno, il Due, il Tre, il Mille, il Centomila… Nella realtà esiste un sassolino, o una mela, o una formica; esistono due formiche, tre formiche, eccetera.
SABINA: E qual è la differenza?
ALESSIO: Il numero come concetto matematico è un’idea, la quantità della materia è un fatto oggettivo, che sta fuori della mente. Il numero è una realtà infinita, le cose sono pur sempre finite.
SABINA: Ma non vedi che i fisici continuano a scoprire sempre nuove quantità, e quindi sempre nuovi numeri, nella materia? Dopo l’atomo, l’elettrone; dopo l’elettrone, il pione e il muone; dopo il pione e il muone, l’antimateria; dopo l’antimateria, il quanto; e così via.
ALESSIO: Sarà sempre una quantità finita. Mentre i numeri sono infiniti, proprio perché non sono cose, ma idee.
SABINA: E se l’universo fosse infinito? Se fosse infinito, e quindi composto da infinite particelle atomiche e infinite stelle e galassie?
ALESSIO: È un’ipotesi, certo.. ma il numero è un’idea anche per un’altra ragione: perché risponde a leggi matematiche, cioè a leggi assolute. Il 6 è e sarà sempre un numero perfetto, perché i suoi divisori, 1, 2 e 3, addizionati, daranno sempre e solo 6. Mentre in natura non esistono leggi matematiche, ma solo leggi scientifiche, cioè possibili, probabili o molto probabili. Ma non assolute, non sempre e comunque universalmente valide.
SABINA: Ne sei certo? O non è vero, piuttosto, che soltanto "probabili" sono le conoscenze umane sulla natura; ma che la natura, per se stessa, potrebbe anche essere soggetta a leggi assolute? Per esempio: l’orbita dei pianeti non risponde a leggi matematiche?
ALESSIO: Sì. Tanto è vero che il pianeta Plutone venne "scoperto" a tavolino, prima ancora di essere visto col telescopio, soltanto studiando matematicamente le irregolatità dell’orbita di Nettuno.
SABINA: Lo vedi?
ALESSIO: Ora che mi ci fai pensare, le tre leggi di Keplero – su cui si basa la nostra concezione del Sistema Solare – hanno questo carattere di assoluta certezza.
SABINA: E la sezione aurea di una conchiglia di Nautilus? E le leggi di accrescimento dei cristalli? E la propagazione delle onde luminose? E le leggi acustiche dell’armonia musicale? Non si basano anch’esse su un grado di certezza assoluto e immodificabile, come le leggi della matematica e quelle della geometria, euclidea e non?
ALESSIO: Sì, hai ragione. Mi hai convinto. Forse le leggi assolute, i teoremi, esistono non solo nella mente, ma anche in natura; e siamo noi uomini che non sappiamo decifrarli in maniera adeguata.
SABINA: Già. Però questo reintroduce un altro problema.
ALESSIO: Vuoi dire, l’idea di Dio?
SABINA: Se l’universo è governato da leggi matematiche, sembra difficile negare che in esso vi sia un ordine; e, dato che l’ordine, di per sé, non fa parte dei normali processi naturali, non è affatto escluso che vi sia anche un artefice.
ALESSIO: Forse, però, tutto dipende – come dicevamo prima – dal nostro modo di pensare antropomorfico, dal nostro linguaggio. Quando noi diciamo una frase del tipo: "l’universo è governato da leggi matematiche", commettiamo parecchi arbitrii sul piano logico.
SABINA: Quali?
ALESSIO: Primo, che l’universo sia "governato". "Governato" è un participio passato che presuppone l’azione del "governare". Ora, se c’è l’azione del governare, c’è sicuramente qualcuno o qualcosa che è governato, ma anche qualcuno o qualcosa che governa. E questo è assolutamente arbitrario. Cioè, il nostro linguaggio ci suggerisce delle conclusioni che non erano contenute nelle premesse.
SABINA: Come dobbiamo dire, allora? Che è "regolato" da leggi?
ALESSIO No, nemmeno "regolato" va bene. Può sembrare un’espressione meno forte, per così dire; ma, in effetti, "regolare" sottintende comunque l’esistenza di un "regolatore".
SABINA: E allora?
ALESSIO: Non dovremmo dire che l’universo è governato o regolato da leggi, ma piuttosto che l’intelligenza umana vi scopre dei princìpi, delle regolarità e dei rapporti costanti, e che ad essi ha dato il nome di leggi. È lui, l’essere umano, che le ha chiamate così: ma non sono "leggi" nel senso comune della parola. Sono rapporti fisici di natura costante, tutto qui. Noi, per la necessità di comprenderci e per comodità didattica, li chiamiamo leggi. Ma è solo una convenzione. Nessuna mente li ha prodotti, li ha "pensati". Il secondo arbitrio che ci permettiamo dicendo che l’universo è governato da leggi matematiche, è proprio quello di usare la parola "leggi". Se poi diciamo "leggi matematiche", c’è un terzo arbitrio: poiché la matematica è una creazione della mente, ciò significa postulare l’esistenza di una Mente capace di progettare in termini matematici.
SABINA: D’accordo. Ma allora questa regolarità, questa armonia nei movimenti della materia, sarebbero solo frutto del caso?
ALESSIO: Per esempio?
SABINA: Per esempio, il fatto che noi possiamo prevedere al minuto secondo il passaggio della Cometa di Halley.
ALESSIO: Niente. Siamo bravi a fare calcoli.
SABINA: Sta di fatto, però, che i calcoli denunciano l’esistenza di una realtà ordinata, precisa.
ALESSIO. Se io getto una pietra in uno stagno, i cerchi nell’acqua si formano a caso?
SABINA: No.
ALESSIO: Da che cosa dipenderanno?
SABINA: Dal peso del sasso; dalla forza del lancio, e quindi dalla velocità di caduta; dalla densità dell’acqua, eccetera.
ALESSIO: Molto bene. E allora, c’è bisogno di presupporre una mente che ha prodotto quei cerchi nello stagno?
SABINA: No, ma di una mano che ha lanciato il sasso.
ALESSIO: E se il sasso fosse caduto dal fianco della montagna? Se si fosse semplicemente staccato da solo?
SABINA: Be’, ora mi hai ridotta al silenzio.
ALESSIO: Vedi qualche trucco nel nostro ragionamento?
SABINA No, non mi pare. A parte il fatto che il sasso non è caduto proprio "da solo", ma pur sempre per qualche causa precisa. La pioggia, ad esempio; e, naturalmente, la forza di gravità.
ALESSIO. Bene. Ma son tutte cause naturali, che non presuppongono una mente, e tanto meno un Grande Matematico.
SABINA: Concesso.
ALESSIO: No, per questa via non è possibile in alcun modo "provare" l’esistenza di una mente cosmica.
SABINA: Neppure negarla, però.
ALESSIO: Io non sono d’accordo con questo modo di ragionare. Sono coloro i quali sostengono l’esistenza di una Mente che devono provarla, non gli "altri" a doverla smentire.
SABINA: Perché?
ALESSIO: Perché sono i sostenitori di una teoria scientifica che devono sforzarsi di dimostrarla.
SABINA: Perché?
ALESSIO: Ostinata, eh?
SABINA: Dicono.
ALESSIO: Senti. Questa mattina ho visto un disco volante.
SABINA: Dici sul serio?
ALESSIO: Si è posato sull’acqua, e ne sono usciti degli omini verdi.
SABINA: Al diavolo! E io che quasi quasi ti credevo.
ALESSIO: Avevano delle lunghe antenne sulla testa, e…
SABINA: Piantala.
ALESSIO: No, mia cara. Sei tu che devi provarmi che sto mentendo. Se non lo fai, io continuo la mia storia. Hanno messo in mare una specie di motoscafo-sommergibile, e poi…
SABINA: Basta, mi arrendo! Va bene.
ALESSIO: Va bene cosa?
SABINA: Ho capito quel che vuoi dire.
ALESSIO: E sei d’accordo?
SABINA: Non lo so…
ALESSIO: Allora, intanto che ci pensi, io vado avanti. Il sommergibile si è inabissato ed è sceso dritto dritto sino al fondo…
SABINA: Invece di affliggermi con la tua storia degli omini verdi, sii così gentile da spiegarmi perché devi essere tu a portarmi delle prove convincenti. Parlando seriamente, intuisco che è così, ma non mi viene in mente una spiegazione logica per questo.
ALESSIO: Perché, se così non fosse, tutti potrebbero affermare tutto di tutto, e anche il suo contrario.
SABINA: Non perché è un evento improbabile?
ALESSIO: No, perché improbabile non vuol dire impossibile. Ma perché è un evento mai verificato prima. Ho detto "verificato" e non "affermato", perché vi sono migliaia di persone che dicono di aver visto gli omini verdi. Il nuovo va accolto con un minimo di cautela, non ti pare?
SABINA: D’accordo.
ALESSIO. Ora, torniamo al punto in discussione. Ci chiedevamo se l’esistenza di movimenti regolari, in natura, possa interpretarsi come indizio di un odine o, addirittura, di un Ordinatore.
SABINA: Sì. Abbiamo osservato, però – stanotte, ma anche l’altra notte – che l’ordine in quanto tale non rientra nei processi naturali, poiché ogni processo naturale implica necessariamente un aumento graduale di entropia, ossia il passaggio da un grado minore di disordine a uno maggiore.
ALESSIO: Tuttavia è lecito chiedersi se, dietro il disordine più o meno accentuato dei singoli processi fisici, non possa darsi un disegno complessivo in effetti ordinato, che noi non riusciamo a scorgere a causa della nostra piccolezza, della brevità della nostra vita e della inadeguatezza dei nostri strumenti, a cominciare dallo strumento che chiamiamo "mente".
SABINA: Questo sì.
ALESSIO: Bene. Ora, per caso ti ricordi le tre leggi di Keplero? Per favore, potresti enunciarmele?
SABINA: Non è poco quello che chiedi. Va bene, ci proverò. Prima legge: le orbite dei pianeti sono ellissi, in cui il Sole occupa uno dei fuochi.
ALESSIO: Brava. E la seconda?
SABINA: Poi mi spiegherai, comunque. Seconda legge: la velocità dei pianeti non è costante, ma segue una legge secondo la quale… secondo la quale…?
ALESSIO: …secondo la quale il segmento che congiunge il Sole al pianeta descrive, durante il moto orbitale, aree uguali in tempi uguali. E la terza?
SABINA: No, non me la ricordo. Sono solo una povera biologa, non un’astronoma come te. L’unica cosa che ricordo è che era maledettamente complicata, faticavo ad impararla anche al liceo, figurati.
ALESSIO: Detta R la distanza media Sole-pianeta, il cubo di tale distanza è proporzionale al quadrato del periodo T di rivoluzione. Cioè: R alla terza= K T alla seconda, dove K è una costante che ha lo stesso valore per tutti i pianeti.
SABINA: Bene. E allora?
ALESSIO: Tu dirai che tutto questo presuppone molta regolarità, dunque molto ordine, e magari una Mente che governa.
SABINA: Almeno sembra.
ALESSIO: Già. Infatti, Keplero – proprio lui! – nel Prodromus dissertationum scriveva, più o meno: "Mi sono proposto di dimostrare con questa operetta, o lettore, che Dio Ottimo Massimo, nella costruzione del Mondo e nella disposizione dei cieli, guardò ai cinque corpi solidi regolari che tanto sono stati celebrati fino dal tempo di Pitagora e di Platone, e che dispose numeri, proporzioni e movimenti delle cose celesti secondo le proprietà di quei corpi."
SABINA: Ma davvero Keplero ha scritto quella roba?
ALESSIO: Se è per questo, ti dirò che è andato anche oltre. Ha scritto, infatti, press’a poco testualmente. "La mirabile armonia delle cose immobili – il Sole, le stelle fisse e lo spazio – che corrispondono alla trintà di Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo"…; devo continuare?
SABINA: No, credo che basti. Come dire che Dio ha seguito dapprima un bel corso di geometria…
ALESSIO: …rigorosamente euclidea, però…
SABINA: … un bel corso di geometria euclidea; e poi, per rendere omaggio a Pitagora e Platone, ha creato il mondo sulla base dei suoi bravi calcoli: tanto era eccellente la geometria dei Greci.
ALESSIO: E c’è un’altra cosa da osservare.
SABINA: Quale?
ALESSIO: I numeri irrazionali.
SABINA: Che cosa vuoi dire?
ALESSIO: Che l’esistenza dei numeri irrazionali smentisce l’idea di una matematica perfettamente ordinata, dopotutto. I numeri irrazionali, dal punto di vista dell’armonia dell’insieme, sono un’autentica mostruosità: al punto che non si possono nemmeno scrivere. Perché i loro decimali proseguono all’infinito, senza alcuno schema regolare. π, per esempio, che a scuola si abbrevia scrivendolo come 3,14. Oppure radice quadrata di 2. In entrambi i casi, scriverli è impossibile: si andrebbe avanti all’infinito coi decimali, senza alcun’ombra di regolarità.
SABINA: Effettivamente, il concetto di numero irrazionale fa a pugni con l’idea di una verità matematica perfettamente ordinata e armoniosa.
ALESSIO. Al punto che, secondo una tradizione, Pitagora stesso avrebbe fatto uccidere un suo allievo che ne aveva scoperto e divulgato l’esistenza. Ma fu un delitto inutile, perché due secoli dopo Euclide li rivelò al mondo nel decimo volume degli Elementi.
SABINA: Non conoscevo questa storia.
ALESSIO: Chissà, forse è solo una leggenda. Ma, forse, rende bene l’idea della mentalità che regnava nella scuola pitagorica. Avendo basato tutta la sua speculazione filosofica sull’idea di un mondo dei numeri ideale e perfetto – al punto di farne, sembra, delle divinità – mai essa avrebbe potuto accettare in essi l’esistenza di una evidente disarmonia.
SABINA: E, come abbiamo detto l’altra notte, quando un filosofo vede minacciato il suo "sistema", farebbe qualsiasi cosa per difendere la propria fatica, tranne la più ovvia: rimetterlo totalmente in discussione.
ALESSIO: Dunque, permettimi di riprendere in esame la tua affermazione che esistono, in natura, delle leggi matematiche perfette.
SABINA. Sapevo che lo avresti fatto. Cioè, sapevo di non averti convinto interamente.
ALESSIO: Che cosa vuoi fare, anch’io ho la sindrome di san Tommaso. Come ce l’hai tu, del resto.
SABINA: No, io qualche volta mi accontento di credere. Sono più passionale, più istintiva di te. Ma non ti dò torto. In questioni di logica, è più giusto sottoporre al vaglio ogni cosa, come fai tu.
ALESSIO: Va bene. Allora, il fatto è questo: se esistono i numeri irrazionali – ed esistono – vuol dire che nemmeno la matematica è perfetta e, soprattutto, che non è necessariamente il regno della proporzione e dell’armonia.
SABINA: Così pare.
ALESSIO: Ora, siamo certi che in natura si trovino quella perfetta armonia, quella perfetta proporzione che non si trovano nemmeno nella scienza dei numeri e delle figure geometriche?
SABINA: Tu, da dove partiresti?
ALESSIO: Comincerei col mettere in dubbio che la matematica sia uno strumento perfetto di descrizione della natura. Infatti, le possibilità sono due: o essa offre un modello solo imperfetto – come nel caso dei numeri irrazionali -; oppue l’imperfezione, la disarmonia sono nella natura stessa. E se ciò fosse in qualche misura dimostrato, sarebbe un forte argomento contro il finalismo.
SABINA: Che credevamo, a torto, di aver fatto fuori l’altra notte.
ALESSIO: Eh, io non mi ero illuso, è un osso troppo duro a morire. Senza contare che risponde a un bisogno profondo dello spirito umano.
SABINA: Mi viene in mente un romanzo di Thornton Wilder, Il ponte di San Luis Rey. Un ponte di liane sospeso vertiginosamente su un fiume del Perù, che faceva il suo dovere da chissà quanto tempo, crolla improvvisamente, facendo precipitare nel vuoto cinque viaggiatori. Perché proprio quei cinque?, si chiede un frate. Perché proprio quei cinque, e non altri? Perché loro?
ALESSIO: Certo, è una domanda legittima.
SABINA: È una domanda istintiva.
ALESSIO: Giusta precisazione. È quel nucleo di finalismo che ciascuno di noi si porta dentro. Ma è un istinto infantile. Noi uomini abbiamo sempre bisogno di pensare che tutto tende a uno scopo, altrimenti ci sentiremmo persi. Piccoli, inutili, abbandonati. Ma se io penso che Dio mi ha fatto l’onore di scomodarsi di persona per farmi precipitare giù nel fiume da un ponte secolare di liane, allora anche la mia morte acquista importanza e significato. D’accordo, bisogna che muoia sfracellandomi qualche centinaio di metri più in basso: ma la mia morte non sarà stata vana, dimostra che qualcuno o qualcosa ci pensa costantemente, magari per farci precipitare nel vuoto. Il che non è poco.
SABINA: Già. Ma torniamo al tuo ragionamento di prima. Ora dovresti mostrarmi che la logica matematica è imperfetta come chiave d’interpretazione dell’universo, oppure che imperfetto è l’universo stesso. Be’, almeno provaci. Certo non possiamo fare miracoli.
ALESSIO: Va bene, adesso ci proverò; anche perché, modestamente, sono un superuomo.
SABINA: Ti ascolto, Zarathustra.
ALESSIO: In realtà, esiste una terza possibilità. Cioè che vi sia uno stato d’imperfezione e disarmonia sia nella matematica, sia nella natura. Comunque, se risulta che la matematica è una scienza imperfetta, come si fa a decidere se l’eventuale imperfezione della natura dipende dallo strumento che adoperiamo per interpretarla, cioè la matematica, oppure dalla realtà stessa della materia, di cui la natura è fatta?
SABINA: È praticamente impossibile.
ALESSIO: Appunto. Perché se io, fin dalla nascita, sono stato costretto a guardare il mondo attraverso un paio di lenti verdi, non saprò mai se il mondo mi appare tutto verde a causa delle lenti, oppure perché magari è proprio verde lui, in se stesso.
SABINA: Come se ne esce?
ALESSIO: Non se ne esce.
SABINA: Ah, bene!
ALESSIO. Comunque, mi pare evidente che la matematica non sia né possa essere uno strumento "perfetto" di conoscenza. Infatti, è uno strumento creato dalla mente umana, la quale certo non può dirsi perfetta. Ora, da una cosa imperfetta non può nascere una cosa perfetta.
SABINA: Resta da vedere se il concetto di "perfezione" si adatti alla natura dell’universo.
ALESSIO. Ma innanzitutto, tu come definiresti la perfezione?
SABINA: "Perfetta" si dice una cosa priva di lacune, errori o difetti.
ALESSIO: Infatti, "perfetto" viene dal latino perfectum, participio passato di perfǐcere, che significa "compiere": dunque vuol dire "perfetto" nel senso di "condotto a compimento". E, per conseguenza, che risulta completo in ogni suo elemento.
SABINA: E tu pensi che la natura si possa definire "perfetta"?
ALESSIO: Un momento, procediamo con ordine. Chiediamoci piuttosto: la natura si può definire "compiuta"?
SABINA: "Compiuta" rispetto a che cosa?
ALESSIO: Appunto. Vedi che il verbo "compiere" presuppone l’esistenza di qualcuno o qualcosa che compie?
SABINA: Già. Il solito pensiero antropomorfico.
ALESSIO Non si può dire che una cosa sia compiuta, se non avendo riguardo a un’azione diretta verso un certo fine. Sei d’accordo?
SABINA: Credo di sì. Ma fammi un esempio, per favore.
ALESSIO: Ora mi accendo la pipa; così. Va bene? Ecco, adesso è accesa ed io posso fumare. L’azione di accendere la pipa è stata compiuta, dunque è "completa".
SABINA: Vedo.
ALESSIO: E posso dire che è "perfetta", perché ha raggiunto lo scopo senza lacune, errori o difetti, come dicevi tu prima. Non ho acceso la pipa in maniera precaria, non corro il rischio che mi si spenga da un momento all’altro. Perciò si può dire che l’ho accesa perfettamente.
SABINA: Dunque, noi diciamo che è compiuta e perfetta, perché ha pienamente realizzato il suo scopo.
ALESSIO: Esatto.
SABINA: Ma noi non sappiamo se la natura abbia uno scopo.
ALESSIO: Esatto.
SABINA: Questo dovrebbero provarlo i finalisti.
ALESSIO: Infatti.
SABINA: Ergo, non si può affermare che la natura sia compiuta, cioè che sia perfetta.
ALESSIO: No, non si può.
SABINA: E in tutti i casi, noi non disporremmo degli strumenti adeguati per verificarlo. Dal momento che non lo è neppure la matematica, ossia quanto di più oggettivo e razionale, quanto di più "perfetto" ha saputo creare la mente dell’uomo per penetrare il mistero delle cose.
ALESSIO: Precisamente.
SABINA: Mah…
ALESSIO: Tuttavia, ti vedo ancora pensierosa. Intuisco qualche cosa che non ti convince, nel nostro ragionamento.
SABINA: Non lo so. Stavo ancora pensando all’esempio del sasso lanciato nello stagno e ai cerchi che si formano sulla superficie dell’acqua. Se non erro, tu li hai implicitamente paragonati alle orbite dei pianeti del Sistema Solare; infatti, poi, hai voluto che enunciassimo le tre leggi di Keplero. Tu volevi dimostrarmi che là dove "sembra" di vedere un ordine, una regolarità, un’armonia, non vi sono in realtà che movimenti meccanici della materia e delle radiazioni elettromagnetiche.
ALESSIO: Sì. Siamo noi, esseri umani, a "vedervi" una particolare armonia. Tanto è vero che i credenti ne inferiscono l’esistenza di un creatore; anzi, di un creatore che ha – in fatto di armonia, regolarità e ordine, guarda caso! – le nostre stesse idee e i nostri stessi gusti.
SABINA: Scusa, ma tu come fai ad essere certo del contrario?
ALESSIO: Per lo stesso motivo per cui "so" che il profumo dei fiori non è stato "inventato" dalla natura per deliziare il nostro olfatto, né i loro colori per gratificare il nostro senso estetico, ma semplicemente per attirare gli insetti che devono impollinare quei fiori.
SABINA: Sì, ricordo che ne abbiamo parlato l’altra notte.
ALESSIO: Allora, ricorderai che l’uomo ha avuto semplicemente la fortuna di avere gli stessi gusti degli insetti, in fatto di profumi.
SABINA: Lo ricordo. E tuttavia mi domando: come possono i fiori avere "inventato" il profumo?
ALESSIO: Stai certa che ho adoperato il verbo "inventare" in senso volutamente ironico. Proprio perché abbiamo assodato che l’uomo non può fare a meno di pensare, e quindi di esprimersi, in termini antropomorfici.
SABINA: Già. Ma allora…?
ALESSIO: Niente. La natura continuamente "inventa" nuovi meccanismi, sempre più perfezionati, il cui scopo è uno solo: assicurare sempre meglio le possibilità riproduttive delle specie. Anche la parola "meccanismo" è inadeguata, del resto, anzi è fuorviante, perché il meccanismo presuppone un meccanico che agisce in maniera intenzionale.
SABINA: E nella visione di una natura tutta presa dall’unico scopo di auto-riprodursi, non vi è del finalismo?
ALESSIO: Forse, ma di tipo immanentistico. Cioè, intrinseco ai processi naturali medesimi.
SABINA: Questo, comunque, mi sembra un terreno minato. Credo che non riusciremmo a venirne fuori, anche se rimanessimo qui a parlarne per una decina d’anni.
ALESSIO: È probabile. Ma prima di metterlo da parte, voglio almeno provare a farti un altro esempio.
SABINA: Va bene.
ALESSIO: Voglio parlarti del nostro amico, del grande Signore del Sud, "che ci aspetta laggiù nel buio, da qualche parte".
SABINA: L’Antartide?
ALESSIO: Sì. E intanto, permettimi di farti una domanda: prima della scoperta da parte degli occidentali, l’Antartide era disabitata?
SABINA: Certo. Ma, sinceramente, non ricordo chi fu a scoprirla per primo. Qualche cacciatore di foche o di balene, mi sembra. Tu lo ricordi?
ALESSIO: Fu Charles Wilkes. Prima di lui, il grande James Cook la circumnavigò, ma senza vederla; scoprì peraltro la Georgia Australe, nel 1775 (che forse era già stata vista da un navigatore iberico, molto tempo prima). Poi, nel 1819-21, il russo Fabian von Bellingshausen avvistò le prime isole poste a sud del Circolo Polare Antartico: Pietro I e Alessandro I. Ma solo nel 1838-39 lo statunitense Charles Wilkes vide, e costeggiò per un buon tratto, il continente di ghiaccio. Tuttavia, non riuscì a effettuarvi alcuno sbarco.
SABINA: Ma perché mi parli di queste cose, ora?
ALESSIO: Solo un po’ di pazienza, ci sto arrivando. Nel 1893 un capitano norvegese, C. A. Larsen, trovò nell’isola Seymour una cinquantina di palline di sabbia e "cemento" poste su colonnine dello stesso materiale.
SABINA: Dei manufatti?
ALESSIO: Larsen scrisse testualmente che quegli oggetti "sembravano fatti da una mano umana".
SABINA: Ecco un mistero davvero affascinante. Dove hai detto che li aveva scoperti?
ALESSIO: Nell’isola Seymour, al largo della costa orientale della Penisola di Palmer. Molto, ma molto più a sud di qualsiasi altra località, a noi nota, ove siano stati rinvenuti oggetti primitivi lavorati.
SABINA: Accidenti, che bel mistero! Io vado pazza per i misteri.
ALESSIO: Einstein, nel suo libro Come io vedo il mondo, scrive che il senso del mistero "è la più bella e profonda emozione che possiamo provare", e che in esso "sta il seme di ogni arte, di ogni vera scienza".
SABINA: E questo Larsen, come li descrisse, esattamente?
ALESSIO: Non molto particolareggiatamente. Disse che quegli oggetti "avevano tutta l’apparenza di essere stati fatti da mani umane", e basta.
SABINA: Non furono esaminati da qualche esperto?
ALESSIO: No. Pare che Larsen ne fosse piuttosto geloso; e infatti, dopo averle prelevate, le fece trasportare nella sua casa di Grytviken, nella Georgia Australe. Allora quella località della Georgia Australe era divenuta la capitale mondiale della caccia alla balena; il porto rigurgitava di navi, e Grytviken era diventata una vera cittadina. Ma poi le balene cominciarono a diminuire, e le zone di caccia si spostarono più a sud. Oggi gli stabilimenti per la lavorazione della carne e dell’olio di balena sono caduti in rovina, e Grytviken è divenuta una caratteristica città-fantasma, come quelle rimaste in Australia dopo la fine della corsa all’oro.
SABINA: E le cinquanta colonnine di Larsen?
ALESSIO: Andarono distrutte nell’incendio della sua casa.
SABINA: Ah!… Di che cosa hai detto che erano fatte?
ALESSIO: Sembravano fatte di argilla.
SABINA: Una roccia sedimentaria… Un materiale "naturale", voglio dire; non fabbricato dall’uomo.
ALESSIO: Sì.
SABINA: Dunque, l’unico indizio che si trattasse di manufatti consisteva nella loro forma insolita, che faceva pensare a un’opera umana.
ALESSIO: Nelle forma e nella simmetria. Cinquanta "colonnine" di argilla, sormontate da altrettante "palline" dello stesso materiale.
SABINA: Però le parole "colonnina" e "palla" suggeriscono di per sé che si trattasse di manufatti, mentre la cosa non è dimostrata. Hai presente certi basalti colonnari, per esempio nella famosa Grotta di Fingal, in Scozia?
ALESSIO: Sì. Mendelssohn ne ha ricavato un’opera sinfonica.
SABINA: Be’, se vedi una fotografia, resti quasi in dubbio se siano davvero opera della natura. Tuttavia, non c’è alcun dubbio che lo sono.
ALESSIO: Purtroppo, non sapremo mai se ciò era vero anche per le colonnine di Larsen.
SABINA: Ma perché mi hai raccontato questa storia? Solo perché sai che adoro i misteri?
ALESSIO: No, naturalmente; ora te lo spiego. Ma prima, dimmi un’altra cosa: tu come definiresti il concetto di mistero?
SABINA: Per me, un mistero è un evento naturale non ancora chiarito dalla ricerca scientifica.
ALESSIO. Pensi allora che la scienza finirà per chiarire tutto?
SABINA: No. Ma prendo atto del fatto che la scienza ha definitivamente chiarito molte cose che un tempo erano considerate "misteri", nel senso di realtà soprannaturali.
ALESSIO: Capisco. Però, il fatto che alcuni misteri siano stati svelati e altri no, non implica – a rigore – che tutti i misteri abbiano un’origine naturale. Questo, possiamo dirlo solo per quei "misteri" che furono tali nel passato, e non lo sono più oggi, dopo che li abbiamo compresi e spiegati.
SABINA: Non mi dirai che proprio tu credi a una realtà soprannaturale.
ALESSIO: Io no, personalmente. Ma è solo un’opinione, non ho le prove per farne un teorema. Anche per una semplice ragione logica.
SABINA: E cioè?
ALESSIO. Che la mente umana, essendo una realtà naturale, con i suoi strumenti – per quanto elaborati – non potrebbe mai attingere una realtà soprannaturale.
SABINA: Giusto. E le statuette di Larsen?
ALESSIO: Ora sono diventate addirittura delle statuette! Vedi come corre la nostra facoltà associativa, senz’avvedersene…
SABINA: Insomma, qualunque cosa fossero.
ALESSIO. Ricordi il paragone del sasso nello stagno? E, precisamente, ricordi l’ipotesi che il sasso fosse caduto in acqua da solo, o comunque per cause naturali e senza alcun intervento umano?
SABINA: Sì, me ne rammento bene.
ALESSIO: Be’, il mistero delle "colonnine" rinvenute da Larsen è dello stesso genere. I cerchi prodotti sull’acqua sono figure geometriche perfette, ma di qui ad affermare che essi testimoniano l’esistenza di una mente matematica alle spalle del sasso, ce ne corre. Così, anche le "colonnine" di Larsen potrebbero essere state solo uno "scherzo della natura". In fondo, ce ne sono tanti. Le famose sfere di roccia del Costa Rica, per esempio: così belle rotonde, che hanno tratto in inganno parecchi studiosi.
SABINA: Potrebbero, ma non ne siamo certi.
ALESSIO: E dimmi, collega biologa: quando la scienza è in dubbio circa l’interpretazione di un fatto, cioè intorno a una teoria, come si comporta?
SABINA: Sceglie, almeno provvisoriamente, la teoria che meglio si accorda con le altre teorie già accettate; anzi, quella che contrasta con il minor numero possibile delle altre teorie.
ALESSIO. Ora, è più facile pensare che l’uomo abitasse l’Antartide prima dell’èra moderna, o che quelle "statuette" (come le hai chiamate tu) fossero un’opera, per quanto bizzarra, della natura? Quale delle due interpretazioni contraddice il minor numero possibile di teorie già affermate e universalmente avallate dal consenso degli studiosi?
SABINA: La seconda, senza dubbio. Ammettere che quelle "cose" trovate da Larsen fossero state fabbricate da mani umane, significherebbe andare contro tutte le nostre attuali conoscenze in fatto di climatologia, geologia, glaciologia, antropologia e storia.
ALESSIO: Pure, c’è sempre qualcuno che preferisce contraddire cento teorie universalmente ammesse, piuttosto che mettere da parte una sola ipotesi, se essa è particolarmente affascinante. E sai perché?
SABINA: Perché ognuno di noi, in fondo, ama il mistero.
ALESSIO: Sì; è quasi un bisogno fisiologico della nostra psiche. Ricordo un libro che lessi da ragazzo, Les pays légendaires di René Thévenin. C’era una frase che suonava più o meno così, e che ho sempre tenuto a mente. "I paesi leggendari… Come possiamo credere che non dureranno tanto quanto l’uomo, poiché è in noi stessi che vivono?".
SABINA: Come l’Atlantide di Platone, non è vero?
ALESSIO: Già. E come l’Eldorado o la mitica "Città dei Cesari", laggiù nelle terre magellaniche, in qualche piega dimenticata delle Ande Patagoniche. O come la leggendaria Shangri-La, o la mistica Agarthi, nel cuore dell’Asia centrale. Come tante "isole fantasma", mai più ritrovate; anche intorno all’Antartide. L’isola Emerald, per esempio, o l’isola Nimrod, nell’estremo Pacifico meridionale.
SABINA. O come il Giardino delle Esperidi, vero? Ricordo qualcosa di questo mito greco, ma vagamente… Che cos’era?
ALESSIO: Il Giardino delle Esperidi era un luogo misterioso dell’estremo Occidente; infatti, in greco "occidente" si dice "έσπερος". Vi crescevano alberi dai frutti meravigliosi e apparteneva alle tre sorelle Esperidi. Lo custodiva un drago fornito di cento teste: ma Ercole, durante una delle sue dodici fatiche, riuscì a rubare le mele d’oro.
SABINA: Anche i dischi volanti rientrano nella categoria delle cose misteriose che tanto fascino esercitano sull’umanità.
ALESSIO: Certamente. E anche i miracoli religiosi.
SABINA: E per le "statuette" di Larsen, c’è stato nessuno che abbia affermato esser quelle le prove di un antichissimo insediamento umano nell’Antartide, abbastanza civile da fabbricare manufatti non di uso quotidiano?
ALESSIO: E come poteva essere diversamente? Del resto, esiste anche la famosa "carta di Piri Reis", un ammiraglio turco, che riproduce le coste dell’Antartide, sgombre di ghiacci e frequentate da navi. Una carta che risale al 1513: più di tre secoli prima, secondo le nostre cognizioni, che il grande Signore del Sud vedesse comparire all’orizzonte la vela di una qualche imbarcazione!
SABINA: Ed esiste ancora, questa carta?
ALESSIO: Questa sì. È conservata a Istanbul, in Turchia.
SABINA: Sicché, tornando a noi, come hanno "spiegato" le colonnine d’argilla dell’isola Seymour?
ALESSIO. Con l’Atlantide di Platone.
SABINA: No.
ALESSIO: Ti dico di sì.
SABINA: L’Atlantide, nel continente di ghiaccio?
ALESSIO: No, prima che il ghiaccio lo ricoprisse.
SABINA: Ma…
ALESSIO: Questo non collima con quanto afferma la geologia, vero? E nemmeno con la climatologia storica.
SABINA: Infatti, si pensa che l’Antartide giaccia sotto un mantello di ghiaccio spesso fino a tremila metri, e che deve essersi formato dopo il Miocene, quindi nel Pliocene. Al più tardi, al principio del Quaternario.
ALESSIO. Ma se alcune zone costiere dell’Antartide fossero rimaste libere dai ghiacci fino a tempi recentissimi? Se dieci o dodicimila anni fa le isole Shetland Australi , per esempio, fossero state ancora libere dai ghiacci, e anzi ricoperte da fitte foreste?
SABINA: So che nell’Antartide, e specialmente nelle isole presso la Penisola di Palmer, sono stati trovati dei tronchi fossili; e che la posizione del Polo Sud era, un tempo, molto diversa da quella attuale. So che tali foreste esistevano, ma non in tempi così recenti…
ALESSIO: Nel 1976 una spedizione italiana guidata da Renato Cepparo ha scoperto sull’isola King George – a 62° di latitudine sud! – dei tronchi semi-fossilizzati che pare non abbiano più di 12.000 anni, e che facevano parte di una foresta lunga due chilometri e larga duecento metri. Mentre oggi, in quei luoghi, non vi sono che ghiaccio, neve e, d’estate, pochi muschi e licheni.
SABINA: Va bene. Ma di qui ad affermare che il continente antartico è l’Atlantide di Platone…
ALESSIO: Eppure un altro italiano, Flavio Barbiero – una persona seria, un ammiraglio – ha sostenuto in un suo libro proprio questo. Barbiero aveva partecipato alla spedizione del 1976 all’isola King George, ma già due anni prima aveva divulgato le sue tesi, che offrivano una nuova teoria sull’origine delle glaciazioni. Non starò a riassumerti tutti i particolari, ma solo la sua tesi centrale: da una lettura puntuale del testo di Platone – sia del Timeo che del Crizia – si giunge, secondo lui, a localizzare l’Atlantide nel mare di Weddell. Più precisamente, il tempio di Poseidone avrebbe dovuto sorgere nell’isola Berkner, in piena Antartide.
SABINA: Non ne sapevo niente; anche se, da qualche anno a questa parte, si vedono pullulare teorie più o meno bizzarre tendenti a localizzare luoghi famosi "smarriti" dall’archeologia ufficiale, o addirittura luoghi di natura leggendaria. So addirittura di una teoria che vorrebbe che i Templari avessero scoperto l’America, e un’altra che li avrebbe portati fino in Nuova Zelanda, per nascondervi i loro tesori all’epoca della persecuzione di Filippo il Bello. Ma tornando alle fonti classiche, ora che mi ci fai pensare, ricordo di aver sfogliato il libro di un autore francese, un certo Gilbert Pillot, il quale sostiene che l’Odissea descrive una navigazione non nel Mare Mediterraneo, ma in pieno Atlantico settentrionale. Il paese dei Lestrigoni, per esempio, sarebbe la Norvegia; e via di questo passo.
ALESSIO. Be’, ti confesso che una cosa del genere l’ho pensata anch’io, e fin dalla prima volta che ho letto Omero. La descrizione della costa del paese dei Lestrigoni è molto precisa e fa subito venire in mente un fiordo norvegese. Mentre l’interpretazione tradizionale dei filologi classici, che si tratti cioè della Sardegna, non mi ha mai convinto molto. Senza contare la descrizione, anch’essa inequivocabile, della durata del dì e della notte alle alte latitudini…
SABINA: Il che dimostra che, dopo tutto, qualche volta bisogna anche avere il coraggio di mettere in discussione le teorie consolidate.
ALESSIO: Senza dubbio; altrimenti non vi sarebbe progresso.
SABINA: Sai, tu mi hai parlato delle "colonnine" di Larsen, da geografo (e astronomo) quale sei. Io invece, se permetti, vorrei raccontarti una piccola storia da biologa.
ALESSIO: Mi piacciono le storie della biologia.
SABINA: Vorrei parlarti di un insetto, e più precisamente di una cicala.
ALESSIO: Un apologo?
SABINA: No, un mistero. Dunque, esiste una cicala periodica, la Magicicada septemdecim, che vive per diciassette anni – come dice il suo nome – , allo stato di ninfa, sottoterra.
ALESSIO: E che cosa fa sottoterra, per diciassette anni?
SABINA: Niente. Succhia la linfa dalle radici degli alberi. Poi, all’età di diciassette anni, esce all’aperto, si riproduce, depone le uova – e muore. Tutto in poche settimane. È evidente che esiste una misteriosa e inquietante sproporzione nel suo ciclo vitale, che è – sia detto tra parentesi – il più lungo nel regno degli insetti. Lo stadio di "ninfa", infatti, in entomologia segue quello di "neanide" ed è rappresentato da forme d’insetti provviste di un semplice abbozzo di ali. Non è possibile non porsi la domanda: a che serve una "preparazione" sotterranea e quasi larvale di diciassette anni, per poi vivere, come individuo adulto e sviluppato, poco più di una semplice manciata di giorni?
ALESSIO: Infatti, a che serve?
SABINA: Nessuno lo sa. Ma certo a qualcosa deve servire. Tra le altre, è stata fatta un’ipotesi che mi sembra particolarmente interessante.
ALESSIO: E che ha a che fare col finalismo, ci scommetto.
SABINA: Può darsi. La vuoi sentire?
ALESSIO: E come no? Anch’io vado pazzo per il finalismo. Ho con esso un rapporto di odio-amore che è sicuramente di origine freudiana.
SABINA: Bene, allora ascolta. E prima di tutto, vorresti darmi la definizione di numero primo?
ALESSIO: Un numero primo è quello che non è multiplo di alcun numero intero, tranne l’uno e sé stesso, naturalmente.
SABINA: Un esempio?
ALESSIO: Il numero tre.
SABINA: Bene. Ora ascolta: diciassette è un numero primo?
ALESSIO: Vediamo…, fammi pensare. Sì, è un numero primo. Infatti non è divisibile per nessun altro numero intero.
SABINA: E allora, che ne diresti se quella specie di cicala avesse "scelto" di allungare il suo ciclo vitale fino a diciassette anni, allo scopo di raggiungere un numero primo abbastanza alto? Poiché anche il cinque, il sette, l’undici e il tredici sono numeri primi, oltre al tre.
ALESSIO: Non ti seguo.
SABINA: Secondo te, quale sarà il peggior nemico della cicala? A parte l’uomo, si capisce; ma quello è nemico di tutte le altre forme viventi.
ALESSIO: Il suo predatore specifico.
SABINA: Oppure?
ALESSIO: Mah, il suo specifico parassita, suppongo.
SABINA: Ora, poiché diciassette non è divisibile per alcun numero intero tranne uno e sé stesso, ne consegue che qualunque sia il ciclo vitale del suo parassita, essa potrà evitare di incontrarlo.
ALESSIO: Come sarebbe?
SABINA: Ma è semplice. Mettiamo che il suo parassita abbia un ciclo vitale della durata di due anni. Che cosa succederà?
ALESSIO: Dunque, diciassette non è divisibile per due. Perciò…, accadrà che il parassita averà l’occasione di attaccarsi alla cicala solo ogni trentaquattro anni, cioè ogni due cicli vitali della cicala. Trentaquattro, infatti, è divisibile per due.
SABINA: Ora, un’altra domanda. Che cosa mangerà quel parassita, durante la bellezza di trentaquattro anni?
ALESSIO: Niente. E perciò morirà. Ma… un momento. Anche il parassita della cicala potrà tentare di allungare il proprio ciclo vitale, esattamente come ha fatto la sua preda.
SABINA: A stomaco vuoto? Comunque, ammettiamolo. Ammettiamo che ci sia quasi riuscito, che abbia allungato il proprio ciclo vitale fino al limite di sedici anni. Che ne dici, ha quasi raggiunto la sua vittima, no?
ALESSIO: Parrebbe di sì.
SABINA: E invece, un ciclo di sedici anni si "incrocia" con uno di diciassette ogni 272 anni. Duecentosettantadue, capisci cosa vuol dire?
ALESSIO: Che il parassita dovrebbe aspettare per duecentosettantadue anni a stomaco vuoto.
SABINA: E in quelle condizioni, quante probabilità avrebbe di riuscire a compiere l’ultimo sforzo e di raggiungere anch’esso i diciassette anni di ciclo vitale, facendolo coincidere, così, con quello dell’agognata cicala?
ALESSIO: Zero virgola zero.
SABINA: Dici bene. Come potrebbe sopravvivere per quasi trecento ani, senza cicale alle quali attaccarsi?
ALESSIO: In nessun modo.
SABINA: Bene. La vuoi sapere un’altra cosa? Quel benedetto parassita, nessuno l’hai mai trovato.
ALESSIO: Non esiste?
SABINA: O forse esisteva, chissà quanti milioni d’anni fa. Ma la cicala è riuscita a scrollarselo di dosso, con la strategia vincente dei numeri primi.
ALESSIO: Ora ho capito dove volevi arrivare. Ma non per questo diremo che la natura ha studiato la matematica né, meno ancora, che alle spalle di tutto ciò vi è un Grande Matematico.
SABINA. Certo, non lo diremo. La natura fa semplicemente il suo mestiere. E non lo fa seguendo delle "leggi" matematiche…
ALESSIO: … ma soltanto seguendo delle strategie che, poi, l’uomo individua, dando loro il nome di leggi.
SABINA: Sta di fatto che rivelano molta ingegnosità.
ALESSIO: Quella che noi uomini chiamiamo ingegnosità.
SABINA: Allora, diciamo che sono delle strategie complesse.
ALESSIO: Questo sì.
SABINA: E armoniose.
ALESSIO: Questo, invece, è già opinabile.
SABINA: La matematica non è armoniosa?
ALESSIO: Dipende: Non sempre.
SABINA: Per esempio?
ALESSIO: Avrai sentito parlare dei numeri immaginari.
SABINA: Credo, ma non ricordo bene. Cosa sono?
ALESSIO: Leibniz li definì degli anfibi tra l’essere e il non-essere.
SABINA: Fammi un esempio di numero immaginario.
ALESSIO: Qual è la radice quadrata di uno? Cioè: qual è quel numero che, moltiplicato per sé stesso, dà come risultato uno?
SABINA: Uno. Perché uno per uno fa sempre uno.
ALESSIO. Giusto. Però, certo ricorderai che un numero negativo, moltiplicato per un altro numero negativo, dà come risultato un numero positivo.
SABINA: Sì.
ALESSIO: Ora: cosa dà meno uno, moltiplicato per meno uno?
SABINA: Più uno.
ALESSIO: Allora ne deriva che la radice quadrata di uno è sia più uno, sia meno uno.
SABINA: Così sembra… Però, non me lo sarei aspettato! Com’è possibile?
ALESSIO: Aspetta, non è ancora finita. Anzi, il bello deve arrivare proprio adesso. Pensa bene e poi cerca di rispondermi: qual è la radice quadrata di meno uno?
SABINA: Oh, vedo che hai deciso di farmi impazzire. Vediamo: non può essere ancora meno uno, perché il quadrato di meno uno è più uno. Potrebbe, allora, essere più uno?… No, neanche. A parte l’assurdità di ordine logico, abbiamo già visto che la radice quadrata di uno è sia meno uno, sia più uno. Quindi, il quadrato di più uno è ancora e sempre uno. E allora?
ALESSIO: E allora sono stati inventati i numeri immaginari, cioè le radici quadrate dei numeri negativi.
SABINA: E come si scrivono?
ALESSIO: Semplicemente "i". Comunque, ammetterai che siamo entrati in un campo assai complesso, questo sì, ma non troppo armonioso.
SABINA: Però ingegnoso!
ALESSIO: Ah, questo è uno dei tuoi colpi basi. "Ingegnosi" saranno i matematici, non i numeri.
SABINA: Va bene, va bene, stavo solo scherzando. Del resto, non sono poi del tutto persuasa che siano un esempio di disarmonia.
ALESSIO: Delle cose che stanno fra l’essere e il non-essere, anzi che sono contemporaneamente l’uno e l’altro!
SABINA: Mi fanno venire in mente l’anti-materia.
ALESSIO: D’accordo, mi rendo conto che anche il concetto di armonia è troppo soggettivo. Per l’essere umano, le note musicali formano un’armonia; ma è probabile che non tutti gli animali la pensino così.
SABINA: Bene, direi che siamo ritornati al punto di partenza. Non è possibile dire se alla natura sia applicabile o meno la categoria della perfezione; dunque, non possiamo affermarlo neppure per la natura morale dell’uomo.
ALESSIO: Già, così pare.
SABINA: Resta da spiegare come mai la mente umana possegga il concetto di perfezione.
ALESSIO: Ciò non significa che esistano degli enti perfetti…
SABINA: No. Ma allora da dove proviene l’idea della perfezione, se non esiste alcun ente perfetto?
ALESSIO: Capisco. Tu pensi: non esisterebbe l’idea della sete, se non fosse data la possibilità di bere.
SABINA: Più o meno.
ALESSIO: Allo steso modo, non esisterebbe l’idea della perfezione se non ci fosse, nella realtà, qualche cosa di perfetto.
SABINA: Confesso che, se così non fosse, non saprei più nemmeno io che cosa pensare.
ALESSIO: E se vi fosse un difetto nel ragionamento? Per esempio: la sete non è un’idea, è un fatto.
SABINA: Una sensazione; ma anche le sensazioni, tu dirai, si possono classificare tra i "fatti". E il desiderio della perfezione? Anche i desideri sono solo dei fatti? E, se sì, da dove hanno origine?
ALESSIO: Per quel che ne sappiamo, il desiderio della perfezione è un’aspirazione, in altri termini, un sogno. Così come si può sognare un uomo volante, o un pesce parlante, o un albero che cammina.
SABINA: Ma esiste la realtà dell’albero ed esiste la realtà del camminare. Tu hai solamente congiunto due eventi incompatibili, per mezzo dell’immaginazione.
ALESSIO: Sia pure, ma da che cosa nasce l’idea della perfezione? Dalla constatazione che vi sono cose imperfette. Qui non si tratta di due eventi diversi, come l’esservi un albero e il fatto che esso cammini. Perfezione e imperfezione sono due concetti attinenti allo stesso ordine di realtà.
SABINA: Appunto.
ALESSIO: Ma proprio qui sospetto che si trovi annidato il sofisma. Noi, per ogni cosa esistente possiamo immaginare un diverso grado o stato di realtà; anzi, possiamo immaginare il suo contrario concettuale: come fa la matematica con l’introduzione dei numeri negativi. Per esempio, meno uno è un numero negativo che non trova il suo corrispondente nella realtà. Zero meno uno, in natura, darà sempre e soltanto zero. Diciamo meglio, in natura zero meno uno è un concetto privo di significato.
SABINA: Vuoi dire, allora…
ALESSIO: Immagina una penna.
SABINA: Fatto.
ALESSIO: Ora, immaginane due. Puoi?
SABINA: Certo.
ALESIO: E dieci milioni di penne?
SABINA: Posso immaginare una quantità grandissima di penne. Se siano proprio dieci milioni, però, non saprei.
ALESSIO: Va bene, non ti chiedo di contarle. Adesso, puoi immaginare infinite penne?
SABINA: Infinite?… No. Per quante ne pensi, ce n’è sempre una prima. Dunque non sono infinite.
ALESSIO: La cosa è discutibile. Anche i numeri sono infiniti, ma alla base di tutti c’è sempre il numero uno. Però è vero che pensare infiniti oggetti reali è impossibile: gli oggetti occupano uno spazio, dunque ci sarà sempre uno spazio esterno, non occupato da loro; e perciò non saranno infiniti. Comunque, cerca di immaginare infinite penne – anche se, in pratica, noi sappiamo che infinite non possono essere. Fatto? E ora immaginati infinite penne, meno una.
SABINA: Non so se ci riesco… Ci sto provando. Infinite penne meno una? No, non posso; perché, se ne tolgo una, non saranno più infinite…
ALESSIO: Sicura?
SABINA: Sì…, credo di sì.
ALESSIO: Ma nel campo degli enti mentali, le cose non sono davvero così semplici. Pensa a tutti i numeri pari, ad esempio. Sono infiniti?
SABINA: Certo. Anzi, no. Se sono solo quelli pari, saranno finiti…
ALESSIO: Eppure, è possibile contarli all’infinito. Due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, quattordici…, e avanti all’infinito.
SABINA: È vero. Non ci avevo mai pensato.
ALESSIO: Cosa ne concludiamo?
SABINA: Che la metà di una quantità infinita, è ancora qualcosa di infinito.
ALESSIO: Dunque, l’intuizione matematica è una cosa, e la realtà pensabile un’altra, vero?
SABINA: Spiegati meglio.
ALESSIO: L’intuizione, un attimo fa, ti aveva suggerito che la metà di una quantità infinita, fosse finita. Non è così?
SABINA: È vero.
ALESSIO: Dunque, non possiamo fidarci dell’intuizione, per questo genere di cose. E sai perché? Perché la nostra mente pensa sempre per immagini: immagini di cose reali. Ecco perché non si possono pensare veramente infinite penne: perché le penne, essendo oggetti fisici, saranno sempre una quantità finita. Possiamo invece pensare ai numeri come infiniti: ma per il semplice fatto che non li pensiamo veramente. I numeri non sono oggetti fisici, sono concetti della mente; quando diciamo che i numeri sono infiniti, facciamo una affermazione puramente verbale, di cui però non possiamo pensare l’equivalente in termini immaginativi.
SABINA: Vedo dove mi vuoi portare. Se non possiamo fidarci dell’intuizione per quanto riguarda i concetti della mente, non possiamo farlo nemmeno per quel particolare concetto che è l’idea di perfezione.
ALESSIO: Già. Noi abbiamo un tale concetto, ma questo non vuol dire che corrisponda a un ente reale che ha la caratteristica d’essere perfetto.
SABINA: Pare.
ALESSIO: E ancora. Torniamo all’esempio di prima, quello delle penne. Puoi pensare infinite penne blu?
SABINA: Sì… Oh, non lo so più.
ALESSIO: È evidente che, dalla tua immagine mentale, dovranno restare escluse tutte le penne rosse e nere e così via. Giusto?
SABINA: Sì.
ALESSIO: E allora, come potranno essere infinite?
SABINA: Ma saranno infinite solo quelle blu.
ALESSIO: Ma non saranno tutte le penne. Saranno solo una parte.
SABINA: Be’, come nell’esempio dei numeri pari o dispari, diciamo che una parte dell’infinito è ancor essa infinita.
SABINA: Molto bene. Allora su questo punto siamo d’accordo?
ALESSIO: Sì. Per quel che ci capisco…
ALESSIO: Stai tranquilla, nemmeno io ci capisco molto. La mente umana è, per definizione, finita; e allora come fa a pensare veramente l’infinito?
SABINA: È chiaro che non può.
ALESSIO: Già: come diceva sant’Agostino. Comunque, noi ci proviamo lo stesso. D’accordo? Faremo quel che potremo.
SABINA: Va bene.
ALESSIO: Ora vorrei che tu ti concentrassi, e pensassi una non-penna.
SABINA: È uno scherzo, questo?
ALESSIO: No.
SABINA: Allora devo dire che Alice nel paese delle meraviglie ti ha dato al cervello, con tutte quelle storie del non-compleanno del Cappellaio Matto e del coniglio…
ALESSIO: No, ma è un fatto che Lewis Carroll era un illustre matematico.
SABINA: E i matematici sono pazzi?
ALESSIO: Non lo so, perché fortunatamente non lo sono.
SABINA: Pazzo?
ALESSIO: Matematico.
SABINA: Ah, bene. Perché i pazzi, di solito, non sanno di esserlo. Come il povero Don Chisciotte della Mancia.
ALESSIO: Allora, torniamo a noi. Hai pensato questa non-penna?
SABINA: Ma devo provarci davvero?
ALESSIO: Sì, per favore.
SABINA: Va bene… ci provo. No, non riesco.
ALESSIO: Eppure, non è difficile.
SABINA: Mi prendi in giro?
ALESSIO: No. Avresti potuto pensare un gatto, per esempio.
SABINA: E perché?
ALESSIO: Perché un gatto non è una penna.
SABINA: Mi chiedo dove vuoi arrivare stavolta.
ALESSIO: Soltanto a ribadire l’idea di prima. Noi possiamo pensare delle cose che non esistono. Oppure delle cose che vanno contro la logica e contro l’esperienza verificabile razionalmente.
SABINA: Sì, credo di sì.
ALESSIO. Dunque, possiamo anche pensare la perfezione e credere che esista come ente reale, da qualche parte.
SABINA: Perché ne abbiamo il desiderio…
ALESSIO: Di’ meglio: perché ne abbiamo l’intuizione. Ma abbiamo visto che l’intuizione può essere ingannevole. Si possono intuire delle cose impossibili[,** inesistenti.
SABINA: Mi hai quasi convinta.
ALESSIO: Quasi?
SABINA: Non lo so, c’è qualcosa in me che fa resistenza…
ALESSIO: Farò un altro tentativo, prima di gettarmi in mare. E ti avverto che non sono un gran nuotatore.
SABINA: Ti lancerei un salvagente.
ALESSIO: Allora, concentrati e pensa dei triangoli.
SABINA. Fatto.
ALESSIO: Ora pensa dei triangoli equilateri.
SABINA: Quanti?
ALESSIO: Quanti vuoi, per adesso.
SABINA: Allora ne penso uno. Fatto.
ALESSIO: Ora pensa a un triangolo rettangolo formato dalla metà della base del precedente, e con l’ altezza del precedente come uno dei cateti.
SABINA: Cioè, la metà esatta del triangolo equilatero.
ALESSIO: sì.
SABINA: L’ho pensato. Anzi, li sto pensando contemporaneamente, uno dentro l’altro. Va bene?
ALESSIO: Sì. Ora cerca di pensare infiniti triangoli equilateri come quello.
SABINA: Fatto.
ALESSIO: E anche infiniti triangoli rettangoli che siano identici al primo che hai pensato.
SABINA: Ci sto provando. Sì, mi pare di riuscirci. Per modo di dire, si capisce. Non sono per davvero infiniti, quelli che penso.
ALESSIO: Già. E non lo potrebbero.
SABINA: Perché?
ALESSIO: Perché abbiamo detto che i triangoli rettangoli sono grandi la metà di quelli equilateri.
SABINA: E allora?
ALESSIO: E allora, infiniti triangoli equilateri dovrebbero occupare uno spazio infinito.
SABINA: …?
ALESSIO: Ma in tal caso, come può restare il "posto" per i triangoli rettangoli?
SABINA: Non lo so.
ALESSIO: E ancora. I triangoli rettangoli sono estesi la metà di quelli equilateri. Come possono essere infiniti, e occupare così uno spazio infinito, se occupano effettivamente una superficie che è la metà di quella occupata dagli infiniti triangoli equilateri, cioè metà dello spazio infinito?
SABINA: Ma prima abbiamo detto che la metà dell’infinito, è ancora infinito. Per esempio, la serie dei numeri pari è infinita, pur essendo la metà della serie numerica completa.
ALESSIO: È vero. Ma io ti avevo chiesto di pensare quei triangoli, non di fare un ragionamento su di essi.
SABINA: Infatti, non sono riuscita a pensarli.
ALESSIO: Allo stesso modo, tu pensi l’idea di perfezione. Ma l’idea di perfezione non è pensabile.
SABINA: Perché non esiste o perché non la si può pensare?
ALESSIO: Non la si può pensare, e basta. Io posso sempre pensare qualcosa di più perfetto, rispetto a un’altra cosa che sembrava perfetta.
SABINA: Ma perché la perfezione non esiste?
ALESSIO: Voglio dirti che se una cosa non è pensabile, il concetto di esistenza diviene, per essa, privo di significato.
SABINA: Sta oltre la nostra capacità di pensiero?
ALESSIO: Precisamente. E, se sta oltre, lasciamolo lì.
SABINA: Lasciamo perdere se la perfezione esiste oppure no?
ALESSIO: Non la perfezione, ma l’idea di perfezone. È un’idea, anzi, un’intuizione. A cui potrebbe anche non corrispondere alcun ente.
SABINA: E tu, personalmente, cosa pensi?
ALESSIO: Io non penso. Nessuno può pensare qualcosa, al riguardo.
SABINA: E allora?
ALESSIO: Allora, è un vicolo cieco. Peggio, un falso problema. Non c’è la soluzione perché non c’è alcun problema che sia pensabile, circa il concetto di perfezione.
SABINA: E va bene. Questa volta mi hai convinta.
ALESSIO: Dunque, rinunci a definire la natura come "imperfetta"?
SABINA: Sì.
ALESSIO: E anche la natura morale dell’uomo?
SABINA: Sì; almeno per adesso. Devo pensarci ancora, ma non adesso. Ti risparmio un salto nell’acqua gelida.
ALESSIO. Grazie. Ora che abbiamo sgombrato dal campo dell’etica l’idea platonica di Sommo Bene – cioè di perfezione morale – possiamo riprendere e concludere i nostri ragionamenti precedenti.
SABINA: Stavamo discutendo circa lo scopo della vita umana.
ALESSIO: E tu affermavi che, per trovarlo, bisogna costruire sulle fondamenta di un sapere certo, e quindi anche di una morale certa. E tendevi a identificare il sapere certo con il bene certo, se non sbaglio.
SABINA: Sì, è vero. Dicevo che conoscere e sapere come agire sono, in realtà, un’unica cosa, perché tutti gli uomini tendono naturalmente alla perfezione.
ALESSIO: Ma ora abbiamo spazzato via il concetto di perfezione.
SABINA: Dirò allora, semplicemente, che tendono a migliorarsi, nella misura in cui conoscono.
ALESSIO. Ma, migliorarsi rispetto a che cosa?
SABINA: Al loro essere morale…
ALESSIO: D’accordo. Ma rispetto a quale idea? Perché non rispondi? Forse perché dovresti dire: "rispetto all’idea di perfezione"?
SABINA: Sì, credo di sì.
ALESSIO. Ma noi non possediamo una tale idea.
SABINA: Nemmeno Cristoforo Colombo possedeva l’idea di "America", però ha trovato l’ente corrispondente.
ALESSIO: Vedo che vuoi rimettere tutto in discussione. E sia.
SABINA: No, ti prego.
ALESSIO: Certo, andando a casaccio si può anche trovare qualcosa… resta da vedere se sarà quella giusta, quella che si cercava. Colombo non voleva trovare l’America, ma la costa orientale dell’Asia. E morì, dopo quattro viaggi, convinto di averla trovata. Non credo tu voglia dire che l’idea di una perfezione inesistente possa guidarci nella vita morale, meglio di quanto l’idea di una mèta inesistente possa guidare un navigatore su mari sconosciuti.
SABINA: No. No, è vero. Non si può procedere a caso, in queste cose. O si sa o non si sa; e credere di sapere senza sapere, è peggio di sapere di non sapere.
ALESSIO: Sono d’accordo con te, questa volta.
SABINA: E così, anche stanotte abbiamo quasi fatto l’alba.
ALESSIO: Sei stanca?
SABINA: Un po’, ma piacevolmente. Queste notti antartiche sono così incantevoli. Non ci sono parole per descriverne tutto il fascino. Per nulla al mondo scenderei in cabina, prima di aver visto Alpahard tramontare. A proposito, di quale Idra si tratta?
ALESSIO: Dell’Idra di Lerna, naturalmente. Quella che Ercole dovette affrontare per ordine del solito Euristeo.
SABINA: La fantasia dei Greci era meravigliosa. E geniale l’idea di riportare i miti nei "disegni" delle costellazioni.
ALESSIO. Le costellazioni, però, sono molto più antiche dei Greci.
SABINA: Come è possibile?
ALESSIO: Esiste tutta una serie di indizi, che fa pensare che i Greci si siano semplicemente "appropriati" di un sapere astronomico molto più antico di loro. Ma è una storia lunga e complicata.
SABINA: C’entrano anche i Caldei, vero?
ALESSIO: Certo, i Babilonesi, ma non solo. Anche gli antichi Egizi, i Fenici e i Minoici. I Greci hanno "battezzato" con i loro miti delle costellazioni preesistenti, antichissime.
SABINA: Quanto antiche?
ALESSIO: Di almeno quattromilacinquecento anni fa.
SABINA: Molto prima dei famosi astronomi alessandrini.
ALESSIO: Sì. Pare che le attuali costellazioni siano state "disegnate" 2.500 o 2.600 anni prima di Cristo.
SABINA: Come si può affermarlo con tanta sicurezza?
ALESSIO: Perché un’analisi accurata del poema di Arato di Soli, Fenomeni e pronostici, scritto nel III secolo avanti Cristo, rivela che le informazioni astronomiche in esso contenute risultano esatte se riferite non al III secolo, ma al 2.600 avanti Cristo, a causa del moto di precessione terrestre.
SABINA: Senti, vorrei che concludessimo le riflessioni di questa notte, tornando al nostro assunto iniziale. Mi sento un po’ confusa e vorrei ritrovare, se possibile, qualche punto fermo.
ALESSIO: Qualcosa in cui credere, e per cui valga la pena di vivere.
SABINA: Esatto; e non fare dell’ironia. Tutti ne abbiamo bisogno.
ALESSIO: Certo, è una cosa seria. L’ironia non era rivolta alla questione in sé, ma aveva il solo scopo di sdrammatizzare certe eccessive pretese che, di solito, l’accompagnano.
SABINA: Per esempio?
ALESSIO: Quella di capire tutto e una volta per sempre.
SABINA: Su questo hai ragione. Ci vuole molta umiltà.
ALESSIO: Preferirei chiamarla "ragionevolezza".
SABINA: Dopotutto, noi umani siamo esseri piccoli e imperfetti, vero?
ALESSIO: Ti odio; ma non raccoglierò la provocazione.
SABINA: Allora, da dove incominciamo? Sei tu il nocchiero.
ALESSIO: Grazie per la fiducia, ma non vorrei che fosse mal riposta. Non sono affatto sicuro di trovare la via. Quando Magellano arrivò all’imboccatura dello Stretto che ancor oggi porta il suo nome, cercava disperatamente una via verso l’Oceano Pacifico, ma non sapeva se l’avrebbe trovata. Inoltrandosi in quel dedalo di isole e di canali tra la Patagonia e la Terra del Fuoco, poteva soltanto sperare. Sperare che non sarebbe stata una nuova delusione, dopo le tante che l’avevano preceduta; che quella non fosse una rotta senza uscita.
SABINA: E gli andò bene.
ALESSIO: Sì, quella volta gli andò bene.
SABINA: Allora, speriamo anche noi…
ALESSIO: Speriamo. Dunque, alla domanda: esiste, in generale, uno scopo della vita umana?, la risposta è: no. La vita, probabilmente, è un prodotto casuale e non "previsto" dalla natura. Noi, quindi, esistiamo per caso. Non tendiamo ad alcun fine. Ciascuna specie si sforza di sopravvivere, anche a prezzo della vita dei singoli individui. I lemming, quando sono troppo numerosi e non trovano più nutrimento, si suicidano in massa, gettandosi in mare dall’alto dei fiordi norvegesi. Gli individui periscono, ma la specie sopravvive. Questo è l’istinto di ciascun essere vivente, e lo è anche dell’uomo. L’uomo desidera avere dei figli per conquistare una qualche forma di sopravvivenza, cioè d’immortalità. In questo modo, l’istinto della riproduzione serve la sopravvivenza della specie.
SABINA: La vita è senza scopo, però ciascuna specie si sforza rabbiosamente di assicurare la propria continuità. Non è un paradosso?
ALESSIO: No, perché? "Paradosso" da punto di vista dei finalisti. E, invece, è semplicemente la legge della vita, che cerca in se stessa il proprio scopo, che è ragione sufficiente a se stessa. Del resto, ciò vale anche per la psicologia dei singoli individui. Il bambino non chiede di venire al mondo: ci si trova scaraventato, letteralmente, fuori dal tepore del grembo materno. Dopo di che, lotta per sopravvivere: perfino il suo primo respiro è una lotta: una lotta contro l’asfissia. Nessuno sa perché, è difficile spiegarlo con argomenti razionali. È difficile spiegare l’istinto: in questo caso, l’istinto di conservazione. Voi biologi lo sapete bene, "istinto" è la parola-passepartout che si tira fuori quando non si sa un accidente di niente. Le migrazioni degli uccelli, per esempio. Volano di notte, instancabilmente: come fanno a orientarsi? Con le stelle, si dice; ma essi volano anche col cielo coperto, anche nella nebbia. E allora? Col magnetismo terrestre, dice un altro. Sarà, ma ne sappiamo quanto prima. Gli albatri urlatori volano perfino dormendo: dormono, e continuano a volare, seguendo la giusta rotta! Di un po’, non c’è da diventare matti? L’istinto, l’istinto: che vuol dire? È solo una parola; dovremmo dire, onestamente: non lo sappiamo. E così è per l’istinto della vita: esiste, lo vediamo all’opera in mille e mille forme, ma non sappiamo cosa sia né in che modo agisca attraverso gli individui; possiamo solo vederne le manifestazioni.
SABINA: Ma tu, che cosa ne pensi?
ALESSIO: Penso che sia la mente ad aver bisogno di ragioni, sia per l’agire che per il puro e semplice esistere. Ma la mente è un caso particolare del fenomeno vita – un caso particolare e non "previsto"; così come la vita è un caso particolare e non "previsto" del fenomeno chiamato "materia". La vita, quando esiste concretamente – non la Vita come idea, ma le singole vite dei singoli individui – non necessita di alcuna "ragione": basta a se stessa. È un fatto, un evento: e i fatti sono auto-sufficienti.
SABINA: Però, vanno interpretati.
ALESSIO: Sì, in questo senso anche Nietzsche diceva – pensando soprattutto ai fatti della storia – che i fatti sono "stupidi". Vale a dire, non ci rivelano nulla se non nella misura in cui devono essere interpretati. Però questo bisogno di "interpretare", cioè di razionalizzare, di creare un ordine – per esempio un ordine causale – è un qualcosa di tipico della mente umana; qualcosa che in natura non esiste.
SABINA: Certo, gli animali hanno l’istinto per interpretare le cose. Anche se l’istinto, sono d’accordo con te, è qualcosa di difficilmente spiegabile.
ALESSIO: Già. Comunque, vi sono dei fatti che non si possono interpretare con il solo istinto.
SABINA: Per esempio?
ALESSIO: Un cane che abbaia alla luna. Che cosa significa, secondo te?
SABINA: Non saprei. Potrebbe significare che anche gli animali hanno i loro bravi fantasmi.
ALESSIO: E cosa sono i fantasmi?
SABINA: Un mistero.
ALESSIO: E che cos’è un mistero?
SABINA: Lo abbiamo visto prima: un evento naturale che non è stato ancora spiegato.
ALESSIO: Un fatto non interpretato?
SABINA: Pare di sì.
ALESSIO: Dunque, perché un cane abbaia alla luna?
SABINA: Perché non "sa" come interpretare quel fatto.
ALESSIO: E ciò lo inquieta?
SABINA: Evidentemente. Ma…non dicevi proprio ora che il bisogno di interpretare i fatti è tipico della mente umana?
ALESSIO: Tipico, ma forse non esclusivo. Forse esso esiste già, in embrione, nell’istinto degli animali. Del resto, la mente umana non è che un istinto animale un poco più evoluto.
SABINA: Va bene. Questo per il punto primo: la vita non ha scopo e non ha neppure bisogno di uno scopo. Punto secondo?
ALESSIO: Punto secondo: chiediamoci se la mente umana, che è un meccanismo evoluto e quindi complesso, possa fare a meno di uno scopo, come ne fanno a meno gli altri viventi. Se essa si possa rassegnare alla mancanza, anzi, all’impossibilità di uno scopo. Quanto a me, non lo credo.
SABINA: No?
ALESSIO: Credo di no.
SABINA: E allora?
ALESSIO: E allora, bisogna pur cercarlo.
SABINA: Ma se è impossibile trovarlo! Lo abbiamo appena detto.
ALESSIO: Tanto peggio per l’impossibilità.
SABINA: Sarebbe a dire…?
ALESSIO: Io ho affermato che gli esseri umani fanno bene a cercarlo – ammesso che lo cerchino. Non che riusciranno mai a trovarlo.
SABINA: Così, secondo te, fanno bene a cercare un qualcosa che non potranno trovare mai?
ALESSIO: E che importa se non lo troveranno? Quel che importa è che hanno bisogno di cercare.
SABINA: Ma perché?
ALESSIO: Per dare uno scopo alla loro vita.
SABINA: Anche se lo scopo non c’è?
ALESSIO: Glielo daranno loro.
SABINA: Come?
ALESSIO: Cercandolo.
SABINA: E dove lo dovrebbero cercare?
ALESSIO: In se stessi.
SABINA: E quale sarebbe, questo scopo?
ALESSIO: Dillo tu.
SABINA: Non lo so.
ALESSIO: Dài. Provaci, almeno.
SABINA: Non lo so, padre Alessio. Il Cielo m’è testimonio che non lo so. Che posso fare? Sono soltanto una povera donna inquieta e confusa. Non mi maledica, padre, la prego!
ALESSIO: Infame donnaccia, come osi parlare del Cielo!
SABINA: Perdono! Perdono!
ALESSIO: Nessun perdono, cagna.
SABINA: Ahimé, padre, non mi respinga. Sono pentita, sono disperata!
ALESSIO: Non ci credo. Dammi una prova della tua sincerità, oppure vattene giù all’Inferno.
SABINA: Padre, lei è ben crudele! Perché respinge una pecorella smarrita?
ALESSIO: Via, via, via! Vade retro, Satana!
SABINA: Ohimè! Sono perduta.
ALESSIO: Dimmi qual è il tuo scopo nella vita, lurida peccatrice. È l’ultima occasione che ti offro.
SABINA: Il mio scopo?… Il mio scopo?… Il mio scopo è… amare.
ALESSIO: Ah, finalmente! E perché proprio amare?
SABINA: Mah, non lo so… come tutti, del resto; amare ed essere amati. Forse perché è un mezzo che ci conduce verso la felicità.
ALESSIO: Già… probabilmente.
SABINA: Sono assolta, padre? Non mi maledice più?
ALESSIO: La maledizione è sospesa solo temporaneamente. Ma ti pende sempre sul capo: perciò, bada.
SABINA: Che cosa devo fare per non essere dannata?
ALESSIO: Parlami ancora di questo bisogno d’amore.
SABINA: Che cosa devo dire?
ALESSIO: Quello che vuoi.
SABINA: Ma cosa? Mi dia un indizio, un suggerimento.
ALESSIO: Non ti dò nulla. Di’ la prima cosa che ti viene in mente.
SABINA: Come sul lettino dello psicanalista?
ALESSIO: O come in confessionale.
SABINA: Eh, padre, mi sa che lei è un dritto.
ALESSIO: Che dici mai, figliola! Io sono un ministro di Dio…
SABINA: Mi sa che lei è un tantino lussurioso…
ALESSIO: Non bestemmiare!
SABINA: E lei non creda di "farsi" la pecorella smarrita.
ALESSIO: Ma è inaudito!
SABINA: Strilli, strilli pure. Io l’ho bell’e capito dove vuole arrivare, sporcaccione.
ALESSIO: Non c’è più religione. O tempora, o mores!
SABINA: E lasci stare il suo latinorum, vecchio satiro.
ALESSIO: A questo punto, al buon frate viene un infarto secco. Stramazza, rantola, gorgoglia. E tu ce l’hai sulla coscienza.
SABINA: Be’, requiescat in pace, amen.
ALESSIO: Ma non provi nemmeno un po’ di rimorso?
SABINA: Chi, io? Fossi matta.
ALESSIO: Non ce l’hai la coscienza?
SABINA: Non lo so. A pensarci bene, credo di no.
ALESSIO: Donna perfida e crudele. Instrumentum diaboli.
SABINA: "Maschi, tremate, le streghe son tornate!"
ALESSIO: Basta, mi arrendo. Il padre è a terra che farfuglia e agonizza. Insomma, non me lo vuoi dire perché l’amore? Te lo chiedo supplichevole.
SABINA: Bene, se me lo chiedi così: forse.
ALESSIO: Dunque?
SABINA: La prima cosa che mi viene in mente, vero?
ALESSIO: Sì.
SABINA: Ma devo avvisarti che la cosa potrebbe essere piuttosto scabrosa.
ALESSIO: Hai paura di scandalizzare il vecchio padre?
SABINA: Non vorrei dargli il colpo di grazia.
ALESSIO: Non importa, piccina. Omnia munda mundis.
SABINA: Alessio, guarda che dico sul serio.
ALESSIO: Va bene, correrò il rischio. Cosa vedi?
SABINA: Dei corpi.
ALESSIO: Ah! Oh!
SABINA: Dei corpi quasi nudi, abbronzati.
ALESSIO: Dove?
SABINA: Sulla spiaggia. Estate, vacanze, eccetera.
ALESSIO: Che cosa provi, guardandoli?
SABINA: Sono turbata. Dalla loro bellezza, dal loro splendore meraviglioso. Sono come spicchi di sole sulla terra e illuminano il mio cuore. Lo stanno facendo battere furiosamente.
ALESSIO: Corpi femminili, vero?
SABINA: Sì. Gli altri, non li vedo nemmeno.
ALESSIO: E poi?
SABINA: Ho dodici anni, e non capisco bene quel che mi sta succedendo. O meglio, lo intuisco fin troppo bene. Ma non riesco a sentirmi veramente in colpa. Mi pare che anche questo sia amore: ed è un impulso poderoso, sconvolgente – ma bello, a me pare, ed esaltante. Come il soffio del vento di marzo. Ti fa sentire tutta nuova, purificata.
ALESSIO: Dunque, amare è desiderare?
SABINA: Non lo so. Tirale tu, le conclusioni filosofiche. Io sono sempre distesa sul lettino dello psicanalista, su tua richiesta. Ricordi?
ALESSIO: È vero, scusa. Ma continua, per favore.
SABINA: È come un senso di fame che ti prende alla bocca dello stomaco. Il desiderio… sì, non so spiegarlo meglio.
ALESSIO: Ti sei spiegata benissimo.
SABINA: È tutto…, almeno credo. Vuoi sapere altro?
ALESSIO: Tu, però, sei una ragazza sensibile.
SABINA: E con questo, cosa vorresti dire?
ALESSIO. Che sicuramente le altre persone, per te, non sono semplicemente dei corpi. Non credo che anche tu voglia partecipare alla despiritualizzazione della materia, sull’esempio del buon vecchio Cartesio.
SABINA: No, è vero. Per me, le qualità dell’anima sono infinitamente più preziose.
ALESSIO: Però…?
SABINA: Però, il desiderio è un’altra cosa. Non c’entra con l’anima e nemmeno con l’intelligenza o con la volontà. Arde per conto suo.
ALESSIO: E allora?
SABINA: Niente. Sarebbe bello se il desiderio fisico coincidesse con l’attrazione spirituale. Invece questo accade raramente.
ALESSIO: Un retaggio del dualismo cattolico?
SABINA: Forse; ma non solo. Una realtà, piuttosto. Cattolicesimo o non cattolicesimo.
ALESSIO: E cos’è il desiderio fisico?
SABINA. Voluttà. Cioè, desiderio di annientamento.
ALESSIO: Eros e Thanatos?
SABINA: Sì, penso di sì.
ALESSIO: E l’attrazione spirituale?
SABINA: È un desiderio anch’esso, ma svincolato dai sensi. Desiderio di armonia, di bellezza, di pace.
ALESSIO: La Venere celeste contrapposta alla Venere terrestre. Anche i Greci e i Romani avevano questo tipo di dualismo, ora che ci penso.
SABINA: Abbiamo finito, dottore?
ALESSIO: Sì, cara. Può alzarsi.
SABINA: E rivestirmi?
ALESSIO: Diavolo, mica le avevo detto di spogliarsi…
SABINA: Ma non lo sa, dottore, che in ogni donna c’è una esibizionista? Ci piace essere ammirate, sedurre, e così via.
ALESSIO: La prego, sono uno stimato psicanalista. Non posso giocarmi la carriera per un momento di debolezza con una paziente. Mi radierebbero dall’albo professionale.
SABINA: Le farei provare il brivido del desiderio. Fatti, caro dottore, fatti; altro che le sue chiacchiere, mi scusi, da impotente!
ALESSIO: La supplico, signorina, non lo faccia. Sono un uomo sposato…
SABINA: Ma sì, non ne vale la pena, con un ipocrita benpensante del suo stampo. Buffone!
ALESSIO: Stop! Fine del primo atto. Un quarto d’ora di riposo per gli attori e per il personale tecnico.
SABINA: Grazie a Dio. Non fumi la tua pipa, vecchio mio?
ALESSIO: No, basta. Sigaretta?
SABINA: Sì, grazie. Ho recitato bene la mia parte?
ALESSIO: Da grande attrice.
SABINA: Oggi ti vuoi sprecare con i complimenti. Guarda, Alphard è ormai bassa sull’orizzonte.
ALESSIO: Già. Sempre decisa ad aspettare l’alba?
SABINA: Certo. Non manca molto, ormai. Più tardi, Marzia mi incenerirà con lo sguardo. Chissà cosa penserà: scommetto che sta cercando di ascoltare quando rientriamo in cabina.
ALESSIO: Per non parlare di queste borse sotto gli occhi dovute al sonno, ma che fanno subito venire in mente un’altra cosa…
SABINA: Eh, lo dicevo che a quel vecchio satiro di padre Alessio non sfuggono certi particolari. Allora, cambiando discorso, non mi offri una filosofica conclusione su cui meditare quando andrò a letto, prima di addormentarmi?
ALESSIO: Conclusioni? No, non ne ho.
SABINA: Come! E allora, a che serve la filosofia?
ALESSIO: A cercare, non a trovare.
SABINA: Anch’essa appartiene alla malinconica categoria dei cercatori-che-non-troveranno-mai?
ALESSIO: Sì. Ma almeno, a differenza della scienza e della stessa matematica, è abbastanza onesta da non promettere quello che non sarebbe, poi, in grado di mantenere.
SABINA: È già qualcosa, lo riconosco. Dunque, nessuna conclusione?
ALESSIO: Nessuna. Si cerca, si impara, si disimpara. E avanti così, sempre. Si ricorda, si dimentica. Per tutta la vita.
SABINA: Dopo di che?
SABINA: Basta. Finis. Il grande nulla.
SABINA: Comincio ad aver freddo.
ALESSIO: Vuoi rientrare?
SABINA: No, te l’ho detto. Aspetto l’alba.
ALESSIO: D’accordo. L’aspetteremo insieme.
SABINA: E dove il filosofo Alessio tace, l’uomo Alessio non ha nulla da dirmi?
ALESSIO: Molte cose.
SABINA: Dimmene una.
ALESSIO: Sul senso della vita?
SABINA: Sì.
ALESSIO: Il senso della vita è… amare. Sono d’accordo con te.
SABINA: Amare cosa?
ALESSIO: I giovani corpi abbronzati.
SABINA: Ah, così. Quindi mi assolvi, dopo tutto. E poi?
ALESSIO: La delicata bellezza di un’anima.
SABINA: E poi?
ALESSIO: La notte, le stelle. Alpahard, la Solitaria.
SABINA: E l’umanità?
ALESSIO: Quella, al massimo può farci pena.
SABINA: Provar pena per qualcuno non è forse una forma di amore?
ALESSIO: Ora che mi ci fai pensare, forse sì.
SABINA: E se stessi?
ALESSIO: Quello, prima di tutto il resto. Altrimenti non è possibile amare gli altri.
SABINA: E la filosofia?
ALESSIO: Certo. E anche l’arte, la scienza, perfino la matematica.
SABINA: Perfino Dio?
ALESSIO: Perché no? Se lo fai con onestà intellettuale.
SABINA: Cioè?
ALESSIO: Senza rimbambirti con favolette edificanti. E a patto di litigare con Lui almeno tre volte al giorno.
SABINA: E i nemici?
ALESSIO: I nemici, cosa?
SABINA: Non possiamo amare anche quelli?
ALESSIO: Adesso è molto quello che chiedi, Sabina. No, non è possibile. Perché, per poterli amare, bisognerebbe prima perdonarli; e il rancore represso ci ucciderebbe – come dice, giustamente, il tuo Cioran.
SABINA: Solo per questo non li si può amare?
ALESSIO: No, anche perché sono odiosi. Il nemico è l’odioso per definizione.
SABINA: E colui che ci è odioso, non merita anche, per ciò stesso, la nostra compassione?
ALESSIO: La nostra compassione? Perché?
SABINA. Perché lo collochiamo fra i cattivi irrecuperabili.
ALESSIO: Ma sì. La nostra pena, la nostra compassione, s’il vous plaît.
SABINA: E provare pena per qualcuno, non è forse una forma di amore? Poc’anzi, parlando dell’umanità in generale, ne hai convenuto.
ALESSIO: Infatti, mi pareva di averla già sentita.
SABINA: Dimmi: non è forse una forma di amore?
ALESSIO. Sì, di amore. Non possono negarlo; hai ragione. Ma allora, in nome del Cielo o meglio dell’Inferno, si può sapere chi ci resta da odiare? A forza di ammettere che si può amare questo e quell’altro, abbiamo estirpato fin l’ultima, preziosissima pianticella dell’odio.
SABINA. E tu aspetta che torni a crescere. Tanto, non ci vorrà molto: non te ne preoccupare. So che non vi rinunceresti per tutto l’oro al mondo.
ALESSIO: Proprio così.
SABINA: Con te, non si capisce mai quando scherzi e quando parli sul serio.
ALESSIO: Lo dici perché sei un’esperta in materia.
SABINA: Vuol dire che ci siamo scambiati le parti, questa notte. Seccato?
ALESSIO: No, figurati. È bello imparare sempre qualcosa di nuovo.
SABINA: Sì, è bello.
ALESSIO: Ecco l’aurora.
SABINA: Un’altra notte è passata.
ALESSIO: Con te vicino, mi è sembrata breve.
SABINA: Anche per me è stato così.
ALESSIO: Allora, a domani. Cioè, volevo dire: a più tardi.
SABINA: Sì, Alessio. A più tardi. Riposa bene.
ALESSIO: Anche tu.
FINE
Questo secondo dialogo del trittico "Le notti antartiche" è preceduto da "Fomalhaut: riflessioni su finalismo e casualità", e seguito da "Achernar: riflessioni su amore e morte".
.
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels