
Chi tradì e chi fu tradito, nell’estate del 1943?
12 Dicembre 2018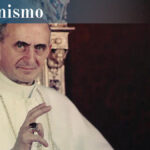
Ebbene sì, la verità è intollerante: grazie a Dio!
13 Dicembre 2018Certo non avremmo saputo darne una ragione precisa, e infatti l’abbiamo capita solo molti ani dopo, però, fin da bambini, c’erano alcune zone della città che, pur appartenendo al "centro", avevamo qualcosa di diverso, di non omogeneo rispetto al resto. In effetti, un viaggiatore dotato di spirito d’osservazione e di una certa capacità logica, potrebbe arrivarci anche da solo, semplicemente osservando lo stile delle case e l’andamento delle vie, benché sia dai libri che gli verrà la conferma delle sue intuizioni. In pratica, si tratta di questo: il centro storico, com’è oggi, non coincide con il centro storico vero e proprio, quello che si è formato nel corso dei secoli. Molti degli stessi udinesi credono, un po’ banalmente, che le due cose coincidano, cioè che quello che oggi è considerato "centro", lo sia sempre stato; o, per essere più esatti, poiché tutti sanno che le città italiane, un tempo, era delimitate da mura, che coincida con l’ultima e più ampia cinta muraria, la quinta, che fu completata, dopo molte interruzioni, solo nel 1463, cioè esattamente ottant’anni dopo la precedente, nel 1363. La quinta cerchia, edificata in epoca veneziana, mente tutte le altre risalgono all’epoca patriarcale, era lunga 7.119 metri – quasi il doppio della quarta, che ne misurava 3.814 – e racchiudeva un’area di ben 205 ettari (un ettaro corrisponde a 10.000 mq., perciò si trattava di oltre due chilometri quadrati).
Ora, il punto è che il perimetro esterno della città odierna, formato dall’anello dei viali di circonvallazione, non ricalca esattamente la quinta cerchia di mura. Vi sono tre zone che restano al di fuori: quella a nord-est, oltre il Parco della Rimembranza (fra viale Caccia, viale Renati e viale Armando Diaz); quella a sud, verso la stazione ferroviaria (il pentagono formato da viale Leopardi, via Ciconi, viale Tullio e viale Europa Unita) e infine quella a sud-ovest, la più piccola (lo stretto triangolo che si allunga fra piazzale Cella, viale Marangoni e viale Duodo, fino al piazzale XXVI Luglio). In tutte e tre queste zone, che erano all’esterno delle mura, non si respira quell’atmosfera antica che è caratteristica del centro: le case e i palazzi sono recenti, anche se non mancano belle palazzine in stile liberty; c’è più verde pubblico e mancano chiese o altri edifici storici. Certo, l’aspetto architettonico di queste zone è stato determinato anche da altri fattori, specie per la zona sud, quella intorno a viale Roma, la quale, durante la Seconda guerra mondiale, fu oggetto di pesantissimi bombardamenti da parte dei liberatori angloamericani, che ridussero in cenere le case, in particolare nell’area di viale Leopardi; però il fattore più importante è quello che abbiamo detto. La periferia di Udine è un fenomeni recente; la quinta cerchia di mura era stata costruita calcolando lo spazio in eccesso, sia per seguire le linee più brevi, sia in previsione di una ulteriore espansione edilizia che, in realtà, non c’è stata, perché la popolazione cittadina è cresciuta molto lentamente ed è rimasta stabile per lungo tempo e solo nel Novecento, dopo la Prima guerra mondiale, ha conosciuto una ripresa significativa. Così, curiosamente, i terreni liberi sono stati edificati partendo dalle mura verso l’interno. Solo dopo la Prima guerra mondiale la popolazione ha oltrepassato le 50.000 unità, per attestarsi definitivamente, dal 1970 a oggi, intorno alle 100.000. Sino agli anni del primo dopoguerra la città aveva conservato ampi spazi edificabili all’interno delle mura, formati da giardini, cortili e orti, nonché aree coltivate a prato, le cosiddette braide, termine di origine longobarda: prima di costruire nuove case e sobborghi all’esterno, c’erano queste aree interne da sfruttare. Infatti, è stato solo tra la fine dell’800 e la metà del ‘900 che si è decisa e attuata la demolizione delle mura e della maggior parte delle tredici porte, che erano, in senso orario partendo da nord: porta Gemona "esterna", porta San Lazzaro, porta Villalta, porta Castellana, porta Poscolle "esterna" o Porta Venezia, porta Grazzano "esterna", porta Cisis, porta Cussignacco, porta Aquileia, porta Ronchi, porta del Bon, porta Pracchiuso e infine porta Sant’Agostino. Ne sono rimaste in piedi solo due, porta Villalta e porta Aquileia; altre due, Porta San Bartolomeo e Porta Torriani, appartengono, rispettivamente, alla terza e alla quarta cerchia.
Sulle mura di Udine ha scritto Marisa Roman (in: Udine 1000. Storia e storie della città per i ragazzi, Banca Popolare Udinese, 1983, pp. 35-39):
La cerchia più antica ha oltre mille anni: con una prima corona di muraglie, lunga memo di un chilometro, sul sommo del colle, racchiudeva unicamente il castello patriarcale; con una seconda, costruita lungo i pendii ed alla base, proteggeva la chiesa di S. Maria e le poche case edificate sul versante più soleggiato. Le acque di un fossato e di un laghetto completavano le difese e il portone principale si apriva dove ora vediamo la torre dell’orologio. Il villaggio chiamato Udene re restava fuori, come gli altri che costellavano la pianura ai piedi del colle, e solo palizzate e rozzi muretti proteggevano le case rustiche. Ma la seconda cerchia di mura, costruita a metà del 1200, già abbracciava la zona dei due mercati, il "vecchio", sorto sul fossato riempito, ed il "nuovo", nonché le botteghe che cominciavano a popolare le viuzze circostanti. Questa nuova e più ampia difesa era munita di tre uscite: la porta di Aquileia nel punto di piazza Libertà dove ora si torva a fontana, la pota di Poscolle all’inizio della strada di questo nome, e quella di Fratta, alla fine di via Mercatovecchio. Queste mura disegnavano quasi la forma di un cuore (…).
Per opera del Patriarca Raimondo della Torre, alla fine del 1200, una terza cerchia raddoppiò praticamente la superficie recintata, aggiungendovi due larghe ali a tenaglia: venne chiamata "la cinta dei portoni" perché se ne aprivano altri sei. Alcune delle porte restavamo ormai all’interno dell’abitato e forse già allora, diventate inutili, erano chiamate "puarte rote" come molti secoli più tardi. I due ampi borghi dentro ai nuovi tratti di mura merlate comprendevamo il duomo, costruito da poco e ancora privo di campanile, altre chiese che prima stavano fuori le mira, e capanne orticelli, giardini. Per le due ultime cerchie ci vollero oltre un secolo di lavoro e l’opera di diversi Patriarchi: furono completate quando il potere patriarcale stava tramontando e le ultimarono i Luogotenenti veneziani, erigendo nuovi bastioni ed approfondendo i fossati. La quarta cerchia era un braccio proteso a sud-ovest per racchiudere le antiche "ville" di Poscolle e Grazzano, coi loro campi e vigneti. A forza di aggiungere cinte, le mura disegnavano un percorso tutto a rientranze e sporgenze: sarà la quinta, amplissima cerchia a dare alla città una forma quasi circolare, col colle al centro e, tra di esso e le porte, una raggiera di strade dalle quali si diramava la fitta ragnatela delle viuzze, delle androne, dei cortili. Numerose erano ormai le porte principali ed i loro nomi si possono rintracciare tutti sulle piante. Eppure sette chilometri ininterrotti di mura non facevano di Udine una città particolarmente fortificata, tanto è vero che i Veneziani, a difesa della pianura friulana, decisero di costruire una fortezza assai più munita: quella di Palmanova. Con il mutare dei metodi di guerra, le mura cessarono la loro funzione di difesa, ma ebbero ancora per secoli quella di cinta daziaria: fino alla prima guerra mondiale, dalle loro stazioni doganali, nelle torri, le guardie controllavano le merci che entravano ed uscivano dalla città, frugando nei carri ed esigendo i tributi.
La parte più affascinante della città, quella dove ci conducevano più volentieri i nostri passi a partire dall’età in cui si ottiene il privilegio di poter uscire di casa e andare a spasso da soli, che coincideva con l’età dei primi calzoni lunghi (mentre oggi i bambini indossano sempre i calzoni lunghi, fin da piccoli, e quelli corti non si usano quasi più, semmai son tornati di moda per gli adulti: curiosa inversione del costume) era quella dei borghi più recenti, quelli della quarta cerchia di mura, in particolare l’amato borgo Grazzano, e più ancora quelli della quinta: borgo Villalta, borgo San Lazzaro, borgo Pracchiuso, borgo Ronchi, borgo Aquileia. Uscire dal "cuore" del centro (abbiamo visto che non è un modo di dire: corrisponde alla fisionomia cittadina compresa entro la seconda cerchia) e imboccare le piazze e le strade che conducevano ai borghi, era, per noi, come passare in un altro mondo, meno noto e perciò vagamente indefinito e misterioso, con qualcosa di esotico; ed era anche come andare un po’ indietro nel tempo, perché vi regnava un’atmosfera più appartata e tranquilla, meno rumorosa e trafficata, senza le luci delle vetrine e popolata, invece, da portoni in pietra, balconi di legno, cortili interni, tutte cose che sapevano di paese, e recavano quasi il soffio profumato della campagna e dei monti vicini.
Una sera di fine inverno, mentre il sole stava ormai calando e già si sentiva il presentimento della primavera non lontana, ci capitò di tornare verso casa dirigendoci verso la Torre di Santa Maria e imboccando la via dei Torriani, costeggiata dal poderoso bastione che fiancheggia il palazzo Manin e che ricalca la quarta cerchia di mura (la porta, verso la fine del 1300, era orientata da sud a nord e non, come appare oggi a chi percorre la via Zanon, da est a ovest). Era un momento magico, in quell’ora sospesa tra la fine del giorno e l’inizio della notte, che Leonardo ha descritto come la più propizia all’ispirazione d’un artista perché tutte le cose, anche i volti delle persone, grazie ad essa appaiono soffuse di una vaga e misteriosa dolcezza, e sembrano muoversi con una grazia tutta particolare. Gli ultimi riverberi della luce morente sfioravano le facciate delle case e accendevano di riflessi incandescenti i vetri delle finestre. Eravamo passati davanti alla stupenda Cappella Manin, simile a un fiore di pietra sbocciato dalla terra e proteso verso il cielo, e subito dopo davanti alla imponente facciata del palazzo nobiliare, solido come un fortilizio, e nello stesso tempo adagiato sulle fondamenta come una forte e tranquilla dimora di campagna, col suo grande portone in pietra che parla di altri tempi e di altri uomini. Più avanti, a destra, al di sopra del muro che costeggia la strada fino allo sbocco in largo del Pecile, si stagliava la mole possente della Torre di Santa Maria, che aveva un qualcosa di vagamente familiare: somiglia non poco, infatti, alla torre che sorge vicino a dov’era la nostra casa, la Torre di San Bartolomeo.
Ed ecco, giunti proprio all’imbocco della via dei Torriani, sull’angolo dell’antico palazzo, la scoperta improvvisa di una bella, commovente edicola religiosa dedicata alla Vergine Maria. Quasi ad altezza d’uomo si apriva nel muraglione una nicchia rettangolare, inquadrata da una cornice di pietra bianca e sormontata da una mensola, anch’essa di pietra bianca e sostenuta da due piccoli basamenti. La rientranza era protetta da una bassa inferriata che riparava solo il bordo inferiore, sufficiente a scoraggiare eventuali vandali che avessero voluto imbrattarla, ma non tale da impedire a una mano gentile di introdurre dei fiori fra le sbarre. La superficie interna era dipinta ad affresco e raffigurava la Vergine Maria che sostiene il divino Bambino con la mano sinistra, la stessa con cui stringe anche una coroncina del Rosario, mentre leva in alto la destra in un gesto indeterminato, forse per benedire o forse, semplicemente, per esprimere la gioia e l’adorazione suscitate in lei da quel tenero contatto; mentre Gesù, ritto sulle gambette, i piedini posati sulle ginocchia di sua Madre, sorride dolcemente, il volto vicinissimo a quello di Lei, che lo guarda. Non è una pittura antica e non è neppure un capolavoro; però fu una cosa bellissima scoprire quel minuscolo angolo di devozione lungo un muro tutto uguale, là dove non ricordavamo di averlo mai visto, e forse era proprio così: dopotutto, erano le nostre prime ricognizioni solitarie e molte strade, molti palazzi, molte chiesette, li vedevamo realmente per la prima volta, come un esploratore il quale si accinga a tracciare dei segni, per la prima volta, su una carta geografica che è rimasta quasi bianca fino a quel momento, in attesa che qualcuno la completasse. Il sentore acerbo della neve che si scioglieva e della terra umida che incominciava a liberare i suoi effluvi primaverili, la luce soffusa della sera imminente, l’ultimo raggio che si posava sui colori vivaci dell’affresco, il rosso della veste della Madonna, il bianco del suo velo e il celeste del suo mantello, tutto contribuiva a conferire a quella piccola scoperta un sapore struggente di cosa nuova, di cosa incantata. Che esperienza ineffabile, per un bambino, scoprire le cose per la prima volta! È come se il mondo, quel particolare angolo del mondo, cominciasse ad esistere sotto il suo sguardo, si staccasse dal fondo indistinto ed entrasse in piena luce, avendo atteso, da sempre, proprio quell’istante.
Il raggio si spense, l’edicola della Madonna rimase indietro, avvolta nell’ombra, era ora di tornare a casa; pure, era come se una presenza amica seguitasse a starci accanto e a fare quell’ultimo tratto di strada insieme a noi. Non eravamo più soli. Qualcuno, costruendo e dipingendo quell’edicola, aveva voluto aprire uno squarcio d’infinito e gettare un raggio di luce ultraterrena sui passanti che, più o meno frettolosi, più o meni inconsapevoli, percorrevano quella strada un po’ fuori di mano. Forse qualcuno alzava la testa e si faceva il segno della croce, o rivolgeva un pensiero a Gesù e alla sua Madre divina; ma erano così pochi i passanti, e quei pochi, nel buio, non la notavano quasi. Nessun lumino la rischiarava: il Figlio e la Mamma vegliavano sui passanti a loro insaputa. Questo pensiero era confortante, e lo è ancora oggi: anche se scendono le ombre della sera, Qualcuno resta con noi…
