
Omaggio alle chiese natie: Godia, S. Giovanni Battista
23 Agosto 2018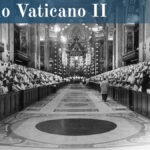
Siri aveva visto e compreso la deriva conciliare
24 Agosto 2018Le due borgate periferiche di Beivars e Godia, all’estremità nord-orientale del territorio comunale di Udine, lambite dalla Roggia di Palma e ormai vicinissime al torrente Torre, distano dal centro rispettivamente quattro chilometri e mezzo e cinque chilometri e mezzo: una breve pedalata in bicicletta oppure una camminata discretamente lunga, ma gradevole per la tranquillità dei luoghi, a secondo dei gusti; in alternativa, c’è sempre l’autobus urbano. Per raggiungerle ci sono diversi possibili percorsi; il più semplice è quello che parte dalla piazza di Paderno, di fronte alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Si prende a destra la via Torino, lunga e silenziosa, fiancheggiata da poche case, che s’inoltra nella campagna verdeggiante: alla fine della primavera, con il granturco alto, è una passeggiata bellissima. Si oltrepassa il campo sportivo, si scavalca la Roggia di Udine e si prosegue fino all’incrocio con la rettilinea via Liguria, che taglia la pianura come una freccia: seguendola, dopo aver svoltato a sinistra, si arriva, dopo un paio di chilometri, alla frazione di Godia, sulla cui piazza sorge la chiesa di San Giacomo Apostolo (evidentemente, questa è la zona delle chiese dedicate agli Apostoli del Signore). Per raggiungere la frazione di Beivars, invece, che è un po’ più vicina, arrivati all’incrocio di via Torino con via Liguria, si attraverso quest’ultima e ci si immette in via Emilia, si passa davanti al cimitero di Paderno (da diversi anni scelto quale ultima dimora anche da molti udinesi, dato che il cimitero principale, quello di San Vito, che tutti qui conoscono come il cimitero di viale Firenze, è sovraffollato) e infine, dopo circa un chilometro, si arriva all’incrocio di via Bariglaria; si prosegue ancora nella stessa direzione, poi si prende la prima laterale a sinistra, via Bologna, e si arriva sulla piazza di Beivars, dove c’è la chiesa di San Giovanni Battista. Un’altra strada, più facile, per chi arriva dal centro, non passa per la piazza di Paderno, ma consiste nel seguire viale Volontari della Libertà fino a piazza Chiavris, poi prendere viale Vat, a destra, seguendo la Roggia di Udine e passando accanto a un interessante manufatto rimasto interrotto, un cavalcavia ferroviario che pare una cattedrale abbandonata a metà dell’opera. A un certo punto viale Vat si incontra con via Liguria, che prosegue verso Godia; in quel punto prende il nome di Via Monte Sei Busi e, dopo poche centinaia di metri, sbocca in via Emilia, proprio davanti al cimitero. Una terza possibilità (ma ce ne sarebbero anche altre) è quella di prendere la lunghissima via Planis, che inizia quasi in centro, davanti al parco della Rimembranza, ed è la prosecuzione di via Sant’Agostino, dopo il santuario della Madonna delle Grazie, e poi prosegue oltre il cavalcavia ferroviario Simonetti: per un attento osservatore, è questo un indizio che rivela come le mura di Udine, sul lato nord-orientale, non coincidevano con l’attuale linea della circonvallazione, ma lasciavano all’esterno appunto l’angolo del tratto iniziale di via Planis: altrimenti, si può star certi che la strada, proseguendo fuori porta, avrebbe assunto un altro nome. Oltrepassato il cavalcavia si segue sempre via Planis, che, a un certo punto, diventa via Don Bosco ed è a sua volta lunghissima, ma non si può sbagliare, perché la zona è in gran parte campestre; si passa davanti al Bearzi e alla chiesa nel tipico stile moderno dei Salesiani, e infine si esce su via Emilia, un poco oltre il cimitero. Che si vada a piedi oppure in bicicletta, è sempre una meraviglia: le strade sono diritte, spaziose, tranquillissime; passano poche macchine, si respira aria buona, si ammira la campagna da ogni lato e si gode, a nord e a nord-est, la vista dei monti vicini: si ha quasi l’impressione che queste lunghe strade debbano perdersi in mezzo ai prati, che non portino in alcun luogo preciso, ma si dimentichino di arrivare dove avrebbero dovuto. E perché, infine, bisogna per forza che le strade vadano da qualche parte? Non possono semplicemente andare? Ecco; questa è l’impressione che si ricava da una escursione verso le frazioni di Beivars e Godia. I paesi, poi, sono rimasti un po’ com’erano parecchi decenni or sono: è come se il tempo si fosse fermato. Nessuno mette fretta, nessuno suona il clacson; si possono ammirare in pace gli scorci, i vecchi muri, i portoni, l’edera sulle case, il glicine che trabocca dai giardini delle villette.
La chiesa di San Giacomo Apostolo è stata fondata nel XVI secolo, ed è da allora che ne abbiamo documentazione; tuttavia esisteva, prima della chiesa cinquecentesca, un edificio sacro molto più antico; ne restano traccia in alcuni affreschi che sono stati datati addirittura al 1200, cioè prima che Dante Alighieri scrivesse la Divina Commedia e che Giotto compisse la sua rivoluzione pittorica, affrescando la Basilica superiore di Assisi e la Cappella degli Scrovegni a Padova. Così come ci si presenta oggi, comunque, l’edificio, che era andato in deperimento, è frutto di restauri ottocenteschi e novecenteschi: è stato infatti consacrato da monsignor Andrea Casasola, un friulano nativo di Buja, il 26 settembre 1869 (quando, per la cronaca, questi luoghi erano passati dall’Impero austriaco al Regno d’Italia da meno di tre anni), ma non venne elevato alla dignità di parrocchia se non dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1951, sotto l’arcivescovo Giuseppe Nogara. L’ultima ristrutturazione è stata fatta nel 1991, ad opera di un intervento sia pubblico che privato. A croce latina, un po’ rialzata rispetto al piano stradale, presenta una semplice facciata a capanna, con uno sviluppo fortemente verticale, con un solo portone centrale e una grande finestra rettangolare tripartita, sormontata da una lunetta semicircolare contenente lo stemma, scolpito in pietra, dell’arcivescovo; più in alto, subito sotto il cornicione del tetto, un affresco del santo titolare, San Giacomo Apostolo, in mezzo a due Angeli adoranti. Per accedere al portone si devono salire alcuni gradini di pietra, raggiungendo un breve spiazzo sopraelevato; la prospettiva della facciata è un po’ compromessa dalla presenza di un alto muro sulla destra, a fianco della gradinata, il quale, pur essendo staccato dal corpo dell’edificio, disturba l’armonia dell’insieme. Il grande campanile sorge staccato, sul lato sinistro della facciata; a pianta quadrata, è sormontato da una cupoletta, al di sopra della quale svetta una croce, a un’altezza più che doppia del tetto della chiesa. L’interno, molto classico, è a una sola navata e prende luce, oltre che dalla finestra della controfacciata, dagli alti finestroni delle pareti, al di sopra dei due unici altari laterali. Il visitatore poco informato e un po’ frettoloso, dopo aver ammirato la quieta armonia che regna all’interno, il senso di pace e di serenità delle semplici linee architettoniche che corono verso il presbiterio leggermente rialzato e l’elegante pavimento in marmo policromo, potrebbe essere tentato di uscire, senza soffermarsi ad ammirare la cosa di maggior pregio artistico custodita in questa chiesa; il bel trittico rinascimentale con Sant’Orsola e la Vergine, e i Santi Giacomo, Silvestro papa, Daniele e Agostino, dipinti nel 1560 da due pittori udinesi di buon livello, anche se (al solito) pressoché sconosciuti fuori del Friuli, rispettivamente Giacomo Secante, allievo di Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone, e Bernardino Blacci, detto il Blaceo. In questo nostro incredibile Paese, non c’è villaggio, non c’è frazione che non custodisca qualche gioiello artistico, magari poco conosciuto, ma assolutamente degno di un pellegrinaggio; il fatto è che noi stessi non siamo affatto consapevoli della immensa ricchezza che abbiamo dovunque, sparsa a profusione, anche sotto il nostro naso. Con un trittico cme quelo della parrocchiale di Beivars, a Parigi o a Londra ci farebbero un’apposita saletta; a Pietroburgo o New York, forse ci costruirebbero attorno una vera pinacoteca. Siamo talmente ricchi e talmente trascurati che non ci prendiamo neanche la briga di infornarci a quale cifra ammonti il nostro smisurato capitale. Nessuno, dal centro di Udine, prende la macchina o l’autobus per venire ad ammirare la chiesa rinascimentale di una frazioncina come Beivars; figuriamoci da Trieste o da Venezia. È più facile che capiti qui un colto turista austriaco o tedesco, come ce ne sono diversi, diciamo pure di quelli appassionati dell’arte, ma anche un po’ pignoli, con la loro brava guida sotto il braccio, piena di segnalibri e di sottolineature. E, in effetti, a Venezia e a Trieste, e anche a Udine stessa, ci sono talmente tante opere paragonabili, o superiori, a quelle del Secante e del Blaceo, che l’apparente indifferenza dei loro abitanti diventa del tutto comprensibile. Il che non toglie che sia e resti anche paradossale.
Abbiano sempre pensato che in questi posti non succede mai nulla, e che ciò è una grande fortuna, rispetto ai ritmi folli della modernità, ai miti aberranti del consumismo; che questo fosse un mondo un po’ remoto e quasi immobile, e perciò fortunato. Fin da quando abitavamo in centro, da bambini, invidiavamo la pace di questa campagna e l’atmosfera agreste che rende la vita a misura d’uomo. Purtroppo, abbiamo saputo che qualche mese fa, nel gennaio 2018, proprio la frazione dimenticata di Beivars è balzata tristemente agli onori della cronaca per un delitto, rimasto tuttora irrisolto. Una casa ha preso fuoco e i vigili del fuoco, subito accorsi, lo hanno spento, ma, senza volerlo, hanno anche alterato le tracce di un delitto che è stato misteriosamente consumato: una donna settantenne, che viveva da sola e il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato, non era perita tra le fiamme, ma era stata assassinata: qualcuno l’aveva sgozzata con un grosso coltello. Tanto ha stabilito l’autopsia: evidentemente, l’incendio era stato appiccato proprio allo scopo di coprire l’assassinio. I giornali hanno parlato di una persona molto sola, che da anni non aveva più rapporti con nessuno, se non coi vicini di casa, ma solo per litigare; che praticamente non usciva neanche più, aveva fatto installare una telecamera (purtroppo quel giorno disattivata) per proteggersi, poiché si sentiva minacciata. Pensava di essere oggetto di una persecuzione, e più precisamente di un malocchio; sosteneva di aver trovati oggetti inquietanti nel giardino di casa, e che qualcuno entrasse di nascosto nella sua proprietà. Una storia molto, molto triste. Una brutta morte dopo lunghi anni di solitudine e totale incomprensione. Ripensiamo alla nostra infanzia, quando delitti così non ce n’erano, forse uno ogni vent’anni, e sempre per motivi facilmente comprensibili: soldi o passione, tutto terribilmente chiaro. Adesso sono diventati relativamente frequenti, purtroppo. La modernità è arrivata anche in questa forma: la cronaca nera degli ultimi tre decenni ha registrato non pochi delitti in questa città e nella sua provincia. Ci domandiamo che cosa sia cambiato, e ci rendiamo conto che è cambiato tutto: è come se ora fosse arrivato un altro mondo, che si è sovrapposto a quello di prima, e lo ha cancellato. La povera signora Rosetta aveva settantadue anni, dunque era nata nel 1946; era religiosa, andava spesso in chiesa a pregare, ma aveva paura. Aveva sporto denuncia contro ignoti, e si era rivolta a un centro di aiuto per le vittime di stalking, però non sapeva chi fossero i suoi nemici. Trovava delle scritte, dei simboli sul muro di casa, delle croci; le cancellava, e il giorno dopo le trovava di nuovo. L’ombra della magia nera e del satanismo si allunga su questa vicenda, anche se è solo una possibilità. Ricordiamo che si era parlato di riti satanici in città anche in occasione del dibattuti sul destino della ex chiesetta delle monache all’interno dell’istituto Renati, in va Tomadini: un editore locale sosteneva che l’edificio sconsacrato era stato utilizzati per le messe nere. Se le sue non erano le allucinazioni d’una persona troppo sola, allora si deve pensare alla cronaca di una morte annunciata. Una vicenda così, cinquant’anni fa, sarebbe stata difficile anche solo immaginarla. Il problema delle persone anziane che rimangono sole e che sono esposte alla criminalità, è una conseguenza della disgregazione della famiglia tradizionale. Cinquant’anni fa, la signora Rosetta si sarebbe trovata a vivere la sua vecchiaia con sorelle, fratelli, nipoti; non sarebbe rimasta sola. Ladri, scippatori, rapinatori, truffatori e anche assassini, prendono volentieri di mira gli anziani, perché sono obiettivi facili. È in atto un terribile imbarbarimento nella nostra società: improvvisamente ci accorgiamo che essa somiglia a una giungla, dove gli animali vecchi e deboli sono destinati a cadere sotto le zanne e gli artigli delle belve più giovani e forti. E, su tutto, il peso della solitudine: come è possibile che, dopo una vita di lavoro, un uomo o una donna si trovino a dover trascinare la loro vecchiaia come naufraghi su di un’isola deserta? La povera donna aveva sporto denuncia, aveva chiesto aiuto: qualcuno si è reso conto che si trovava in pericolo? Sembra che la realtà si sia trasformata in un incubo: il sogno della società del benessere si è mutato nell’incubo della solitudine, della paura e della violenza che colpisce i più indifesi.
La signora Rosetta andava in chiesa a pregare; non sappiamo se abbia trovato conforto. Sappiamo, parlando della Chiesa in generale, che molti, troppi preti e vescovi oggi sanno preoccuparsi solo dei cosiddetti migranti, dei pochi veri e dei molti falsi profughi; sanno commuoversi solo per loro, predicano l’accoglienza solo per loro. Delle nostre persone sole e anziane, dei pensionati che non riescono a sopravvivere con quattrocento euro, degli imprenditori che falliscono e degli operai che perdono il lavoro perché le loro aziende chiudono, e dopo i cinquant’anni è impossibile trovare un nuovo posto di lavoro: di tutti costoro la neochiesa non parla. Parla solo degli africani, degli islamici, dei lontani che pretendono di trovar qui una nuova patria e protestano se il cibo non è di loro gradimento e fanno sciopero della fame perché sono stufi di mangiar pastasciutta o perché non vogliono stare nelle ex caserme, ma in albergo. La neochiesa ha parole di comprensione per loro, non per gente come Rosetta. Bravi allora i nostri neopreti e neovescovi; noi però non ci stiamo. Per noi, persone come la signora Rosetta vengono prima: è a loro che dobbiamo la nostra vita comoda…
