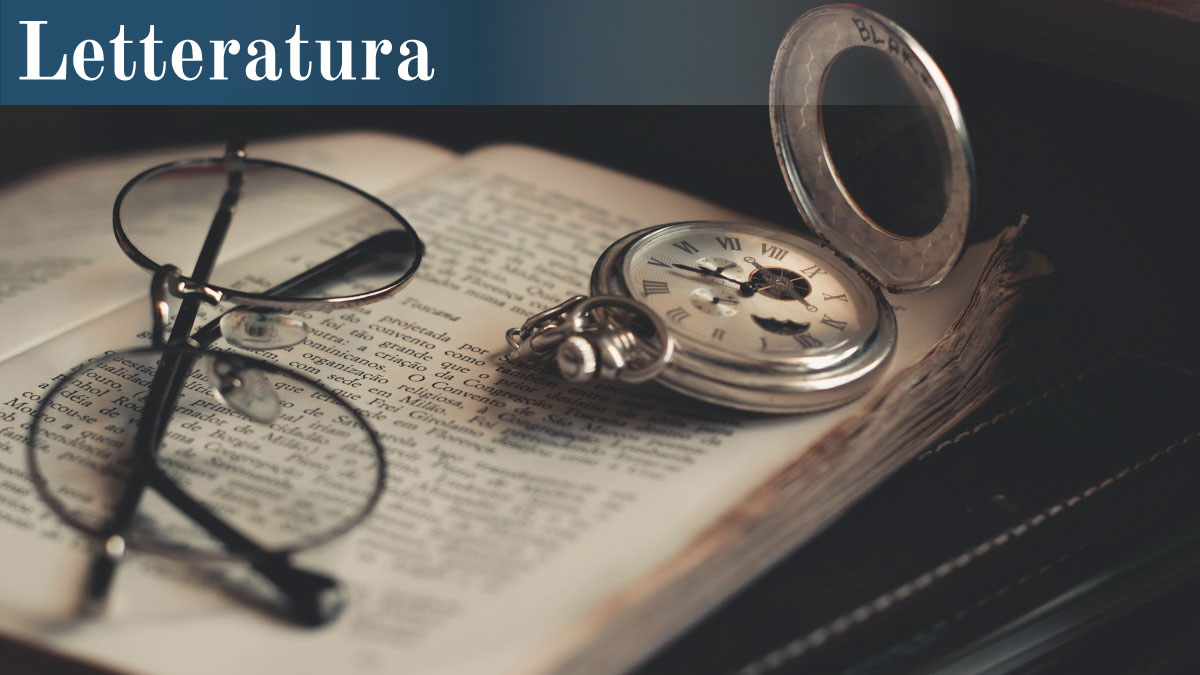1944, de Gaulle salta in extremis sul cavallo vincente
29 Luglio 2018
San Pietro Martire e alcune leggende a proposito della santa Inquisizione
30 Luglio 2018Una cosa alla quale generalmente non si pensa è che anche agli scienziati, e specialmente ai cultori di scienze naturali, una buona infarinatura di cultura classica si addice non solo per ragioni di cultura generale, "umanistiche", come si diceva un tempo, quando tanti medici, fisici e astronomi leggevano Omero e Virgilio e citavano con disinvoltura passi di Plutarco o Cicerone, ma proprio come strumento di lavoro per la propria disciplina. Prendiamo il caso del geologo. La geologia è quella scienza della terra che studia anche le trasformazioni che la superficie del nostro pianeta subisce nel corso del tempo; trasformazioni di solito relativamente lente e graduali, ma che, in presenza di eventi particolari, come terremoti ed eruzioni vulcaniche, possono assumere uno sviluppo improvviso e rapidissimo, e lasciare una traccia durevole nella conformazione del paesaggio, che poi essi, i geologi, hanno appunto l’onere di spiegare. Ma anche l’avanzare o il retrocedere di un ghiacciaio lascia dei segni sul terreno e viene registrato dalle testimonianze umane; anche l’affiorare improvviso di un’isola vulcanica, e poi il suo graduale scomparire, sotto gli assalti delle onde e lo sfaldarsi del suo basamento sottomarino. Per ricostruire la storia di un vulcano, o degli eventi sismici di una certa regione, il geologo ha, quindi, bisogno anche di interrogare le testimonianze scritte, in modo da rendere più completo il quadro delle sue conoscenze riguardo a quel fenomeno, e stimare in maniera più appropriata se un certo vulcano è, poniamo, in fase di quiescenza, o se lo si deve considerare ancora pienamente attivo. Ed ecco che gli autori classici, greci e latini, si rivelano delle fonti di notevole importanza per ricostruire la storia dei fenomeni terrestri in epoca storica; ed ecco che la conoscenza di quelle lingue, di quegli autori, di quei testi, si può rivelare preziosa, perfino nel caso si tratti di testi poetici, perché molti testi poetici si sono comunque ispirati a degli eventi geologici reali. Basti pensare al poemetto pseudo virgiliano Aetna, che si può considerare come una fonte di notevole interesse, perché nei suoi 646 versi, che siano o che non siano, come è più probabile, di mano del sommo Virgilio, vi è comunque una messe d’informazioni scientifiche sui fenomeni vulcanici, così come le avevano i romani, nonché sui singoli particolari di eventi specifici, tutte cose di grande interesse per la geologia storica dei nostri giorni.
Non stiamo dicendo che un geologo (o un botanico, o un climatologo) dovrebbe anche essere un filologo classico; ci mancherebbe. Diciamo semplicemente che la cultura è un sapere completo, unitario e armonioso, e che l’eccessiva specializzazione conduce di necessità a una dipendenza totale, e perciò acritica, nei confronti delle altre specializzazioni per tutto ciò che riguarda le scienze ausiliarie della propria. Nel caso specifico: un geologo, specializzato in vulcanologia, per ricostruire la storia di un determinato vulcano, se non sa nulla di greco e di latino e meno ancora di letteratura greca e latina, sarà costretto, ovviamente, a rivolgersi ai filologi classici per ricavare da essi, acriticamente, cioè da incompetente, le notizie di cui ha bisogno; ma se, invece, avesse una qualche familiarità, anche modesta, con gli scrittori classici, potrebbe organizzare la sua ricerca in maniera molto più appropriata e consapevole. Siamo coscienti che tutto ciò è pura utopia, perché, tranne il caso in cui quel geologo coltivi, per suo conto e per suo gusto, una interesse per le letterature classiche, a nessun aspirante geologo verrà mai in mente che sarebbe una buona cosa se egli, nel suo corso di studi, inserisse qualche elemento di filologia classica, né i suoi professori glie ne daranno mai il suggerimento, neppure a titolo di consiglio personale. C’è già tanto da studiare, e da sapere, nel proprio ambito specifico: ogni scienziato tende a specializzarsi a un punto tale, che quasi non sa nulla delle scienze affini; figuriamoci delle altre. Uno storico medievalista non sa quasi nulla della storia contemporanea, come un biochimico non sa quasi nulla di astronomia, o come un botanico non sa quasi nulla di mineralogia. Se, nel loro lavoro di ricerca, essi avranno bisogno di attingere informazioni dalle scienze affini, lo faranno perciò con lo stesso atteggiamento mentale di un viaggiatore che, giunto in una grande città in cui non è mai stato, chiede le informazioni che gli servono al primo passante che incontra, e si fida ingenuamente di tutto quel che costui gli dirà, senza vagliarlo, ma così, sulla base di un atto di fede, o meglio di una pia speranza. Atteggiamento che non è precisamente di tipo scientifico, ma che bene illustra la nemesi dello scientismo: a forza di specializzarsi, i moderni scienziati non sanno vedere al di là del loro naso; un meteorologo, per esempio, passeggiando nel parco coi suoi figli, forse non saprà rispondere nemmeno alle loro più semplici domande, se quello che hanno davanti sia un acero, o un tasso, o un carpino, tale è l’ignoranza in botanica di quel signore.
Ora prendiamo un caso concreto: la storia antica di un vulcano, diciamo di Vulcano, quello dell’isola omonima, nell’arcipelago delle Eolie o Lipari, che ha dato il nome a tutto gli altri vulcani e che lo ha preso, a sua volta, dal dio omonimo dei romani, che presiedeva al fuoco, alla metallurgia e alla scultura, e che era il corrispondente del greco Efesto. Per ricostruire la storia "antica" di questo vulcano (antica fra virgolette, perché intendiamo in senso storico e non in senso geologico), uno dei massimi studiosi di vulcanologia, l’americano Fred Bullard (1901-1994), si è rivolto, giustamente, agli autori classici e così, incidentalmente, si è trovato alle prese anche con un problema ulteriore, legato al grado di attendibilità dell’Odissea dal punto di vista scientifico, e cioè dove si debbano collocare geograficamente le peregrinazioni di Ulisse nel viaggio di ritorno da Troia a Itaca. Il che, poi, lo ha posto di fronte a un ulteriore problema, e cioè chi fosse Omero, dove abbia vissuto e quando abbia scritto i suoi poemi: niente di meno che la "questione omerica" nella sua immensa complessità.
Scriveva, dunque, Fred M. Bullard nella sui ormai classica, ampia e accuratissima monografia I vulcani della Terra (titolo originale: Volcanoes of the Earth, University of Texas, 1976; traduzione dall’inglese di Paola Fredi, Roma, Newtn Compton Editori, 1978, pp. 265-268):
Le prime indicazioni sull’attività di Vulcano ci portano a concludere che anticamente esso deve essersi trovato in una fase di attività assai più violenta di quella degli ultimi secoli. Le sue eruzioni erano più esplosive tanto di quelle dello Stromboli che dell’Etna. Judd (1875), in un articolo su Vulcano, che appartiene ad una serie di scritti sulle Isole Lipari, ha tracciato la storia di Vulcano dalle prime notizie disponibili fino all’eruzione del 1873-74. L’autore ha riconosciuto sin dal principio che, poiché Vulcano è strettamente legato alla mitologia, sarebbe stata un’ardua impresa separare i fatti reali dalle storie leggendarie degli scrittori classici più antichi. Ciò nonostante, le tradizioni associate con Vulcano dimostrano che esso deve aver avuto frequenti e violente eruzioni sin dai tempi antichi. (…) Tucidide, uno tra i più importanti storici dell’antica Grecia, scrivendo nel V sec. a. C., affermava che Vulcano emetteva molto fumo di giorno e fiamme di notte. Aristotele (384-322 a.C.), descrivendo l’eruzione di Vulcano apparentemente in corso a quei tempi, riferiva che si era formata una nuova collina e che la quantità di ceneri emesse era così grande da coprire la città di Lipari distante circa 10 km e da estendersi fino a parecchie città dell’Italia. Aristotele indica i "venti" intrappolati in canali sotterranei quale causa dei terremoti e dei vulcani, un’idea che ha continuato a persistere per moti secoli (…). Nel III secolo a.C., Callias ha descritto Vulcano affermando che presentava due crateri, uno dei quali, con una circonferenza di 60 m, lanciava fuori grandi massi con un rumore che si poteva sentire a circa 80 km di distanza. Plinio ha riferito che un’isola era emersa dal mare tra le Isole Lipari all’inizio del II secolo a.C., e successivamente Grosisus ha posto tale data intorno al 182 a.C. Basandosi su queste prove e sull’ipotesi che si trattasse dell’isola di Vulcanello (una volta un’isola separata ma attualmente parte di Vulcano), il British Admiralty’s Geographical Handbook pone la nascita di Vulcano intorno al 183 a. C. ("Great Britain", Naval Intelligence Division, 1945, p. 701) e Judd (1875), De Fiore (1922) ed altri hanno accettato questa data che infatti è quella comunemente indicata nella letteratura.
Studi recenti che tentano di ricostruire i vagabondaggi di Ulisse, narrati da Omero, sollevano alcuni dubbi circa la precisione sulla data del 183 come nascita di Vulcanello. Il lettore ricorderà che nell’Odissea Omero descrive le avventure di Ulisse, re di Itaca, durante il suo viaggio di ritorno in patria dopo la caduta di Troia e la fine della guerra troiana. Gli studiosi classici sono stati a lungo discorsi se ammettere che i luoghi descritti fossero realmente noti ad Omero o se esistessero soltanto nella mitologia. Riesaminare questo interessante argomento non fa parte dello scopo del presente lavoro. Comunque, la maggior parte delle informazioni disponibili sul’attività dei vulcani del Mediterraneo nei temi antichi, deriva dai classici e specialmente dagli scritti di Omero e Virgilio; pertanto questa fonte di informazione non può venir trascurata. Se si ammette che Omero abbia descritto una regione a lui nota, dovrebbe essere possibile individuare, da un’attenta analisi delle sue descrizioni, degli indizi che permettano di identificar ei luoghi visitati da Ulisse. Uno fra i più noti e controversi lavori su questo argomento è di Samuel Butler (1897), il quale ha concluso che l’"Odissea" ha avuto le sue origini a Trapani, in Sicilia, ed è stata scritta da una donna. Uno studio del professor L. G. Pocock del Canterbury University College di Christchurch, Nuova Zelanda, in parte conferma e in parte respinge le conclusioni di Butler, sull’itinerario di Ulisse. Le conclusioni del professor Pocock, da lui riferite in via preliminare in un lavoro di quindici pagine, intitolato "The Landfalls of Odisseus" (1955), sono state successivamente ampliate in due pubblicazioni del 1957 e del 1959. L’autore esprime il proprio parere a favore del fatto che Isole descritte come Cariddi, Scilla e Planctae siano rispettivamente Vulcanello (a quel tempo non ancora unita con Vulcano), Vulcano e Lipari. Omero descrive Cariddi come non troppo lontana da Planctae e vicinissima a Scilla. Se l’Odissea fu veramente scritta verso il 650 a.C. come Pocock (1959) sostiene, e se Cariddi corrisponde a Vulcanello allora l’isola apparsa verso il 183 a.C., di cui parla Plinio, deve essere un’altra appartenente al gruppo delle Eolie. A prescindere dalla data precisa in cui Vulcanello apparve come isola, il suo volume aumentò considerevolmente in seguito all’eruzione del 126 a.C. e entro il 91 a.C. si era accumulata una quantità di detriti sufficienti a costruire una piattaforma intorno all’isola (De Fiore, 1922)
I coni vulcanici che appaiono dal mare vengono frequentemente distrutti dall’azione delle onde in breve tempo, per poi riapparire quando si verifica una nuova eruzione; ciò si può verificare più volte prima che un cono raggiunga un volume tale da resistere all’attacco delle onde; queste fasi alterne possono far nascere dei contasti nello stabilire la data di origine di un’isola vulcanica.
Con il passaggio agli scrittori classici la storia di Vulcano diventa nuovamente nebulosa. Gli abitanti delle Isole Lipari subirono le invasioni dei pirati e dei commercianti di schiavi e acquisirono una reputazione di tale ferocia che le Isole venivano evitate dai marinai.
Durante il lungo periodo di oscurantismo medioevale si ha soltanto un breve riferimento a Vulcano fatto da Orosius nel V secolo ed un altro, forse leggendario, che appare nella biografia di San Willebald che si ritiene vissuto dal 701 d.C. al 786 d.C. Nella sua biografia il seguente passo si riferisce a Vulcano: "Il Santo desiderava riuscire a vedere il cratere in ebollizione, chiamato l’inferno di Teodorico, ma non riuscirono a scalare la montagna a causa dello spessore delle ceneri e delle scorie, così si contentarono di osservare le fiamme, che si innalzavano con un rumoreggiare di tuono, e la vasta colonna di fumo che saliva dall’abisso" (Judd, 1875, p. 101).
Fred Bullard era uno studioso coscienzioso e un uomo dalla vasta cultura (cfr., sulla sua opera, la monografia A Guide to the Fred M. Bullard Papers, 1922-1987, Dolph Briscoe Center for the American History, University of Texas at Austin); e tuttavia si vede che il suo modo di trattare i materiali classici riguardanti la storia di Vulcano tradisce una certa ingenuità, in un modo che sarebbe giudicato inammissibile all’interno di una qualunque disciplina scientifica. Per esempio, egli sembra accordare un alto grado di fiducia al libro di Samuel Butler L’autrice dell’Odissea (The Authoress of the Odyssey) e, ancor più, a quello del professore neozelandese L. G. Pocock, che ad esso largamente si richiama, The Sicilian Origin of the Odyssey: a Study of the Topographical Evidence (Wellington, New Zealand University, 1957), "scoperto" in Italia dallo scrittore e traduttore Nat Scammacca (Brooklyn, 1924-Trapani, 2005), e le cui tesi vennero per così dire adottate dall’Antigruppo siciliano e divennero oggetto di convegni di studi. L’autore dell’Odissea sarebbe un’autrice, dunque; non solo, sarebbe stata una donna giovane, secondo il Butler. E siccome una cosa tira l’altra, perché limitarsi all’Odissea e non coinvolgere anche l’Iliade? Dopotutto, solo una donna poteva penetrare la psicologia dei personaggi femminili di Omero con tanta acutezza: ed ecco che un altro studioso britannico, lo storico e linguista Andrew Dalby, afferma senza batter ciglio, nel suo libro Redscovering Home, del 2006, che Omero era una donna. Ma che c’entra tutto questo con la geologia? In realtà, non siamo nemmeno sicuri che le isole descritte da Omero siano proprio le Eolie; figuriamoci se lo siamo circa il sesso dell’antico poeta. Forse nessuno ha detto a questi dotti filologi anglosassoni che la tesi secondo cui l’Iliade e l’Odissea sono stato scritti dalla stessa mano è tramontata da un pezzo; non solo: che ormai praticamente nessuno studioso serio crede più che ci sia stato un autore dell’Iliade e un autore dell’Odissea, maschio o femmina che fosse. Se ne dovrebbero fare una ragione anche gli amici dell’Antigruppo siciliano, i quali, pur di attribuirsi la sicilianità di Omero, son disposti anche a mandar giù l’improbabile idea che questi fosse in realtà una giovane donna di Trapani…
Non imputeremo all’Autore qualche espressione poco chiara, dovuta invece, quasi certamente, alla infelice traduzione italiana (che significa la frase: Con il passaggio agli scrittori classici la storia di Vulcano diventa nuovamente nebulosa?; senza dubbio il senso era: Con il passaggio dagli scrittori classici al Medioevo, la storia di Vulcano diventa nuovamente nebulosa), e nemmeno qualche altro incidente di minore importanza (come la data di nascita di Aristotele, che ci siamo presi la libertà di correggere, perché era sbagliata di un secolo giusto). Però espressioni come il lungo periodo di oscurantismo medioevale riflettono sicuramente il pensiero dell’Autore, che poi è il tipico atteggiamento, banalmente e acriticamente anti-medievale, di quasi tutti gli studiosi di estrazione scientifica e razionalista. Oltretutto, il Bullard non si accorge della contraddizione fra parlare di "oscurantismo medievale" e il fatto che queste isole, rimaste pressoché disabitate in epoca classica, perché ritenute la sede del regno dei morti, proprio nel "buio" Medioevo conobbero l’inizio degli insediamenti stabili, sulla scia del monachesimo benedettino.
Conclusione: non sarebbe una bella cosa se gli odierni studiosi di scienze recuperassero l’idea, assolutamente normale e quasi ovvia fino a meno di un secolo fa, che a nessuno, e nemmeno a uno scienziato, farebbe male alla salute masticare un po’ di cultura classica?
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels