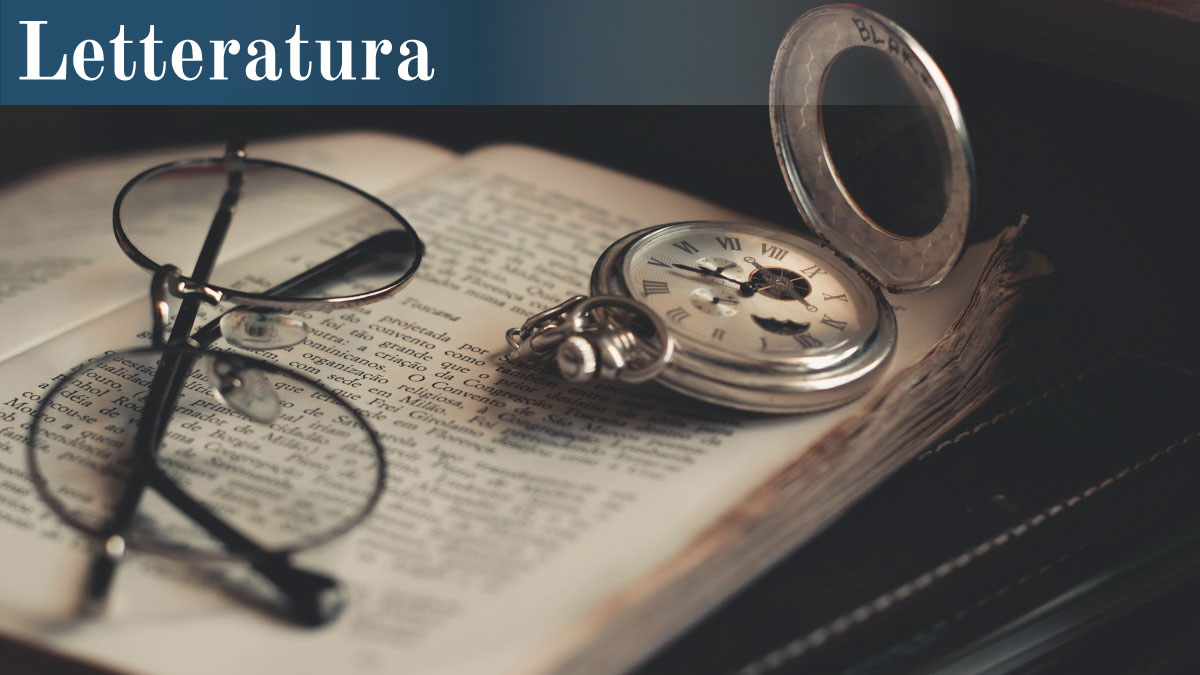I Promessi Sposi: un romanzo cattolico?
12 Giugno 2018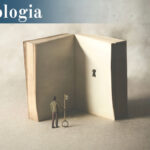
Fare il punto, per riprendere la rotta
13 Giugno 2018Nell’articolo "I promessi sposi": un romanzo cattolico? (pubblicato sul sito dell’Accademia Nuova Italia il 06/08/2017) ci eravamo chiesti se il capolavoro di Manzoni sia davvero quel capolavoro di fede cattolica che tutti, più o meno, credono, chi per approvarlo, chi per storcere, ideologicamente, il naso. Abbiamo anche visto che la biblioteca di una persona può dirci moltissime cose sul suo proprietario, perfino se non lo conosciamo di persona (cfr. il nostro articolo: La biblioteca di Clara nel castello di Fratta, ovvero la malattia della lettura, ripubblicato sul sito dell’Accademia Nuova Italia il 25/03/2018). Vogliamo adesso chiederci se l’esame di una biblioteca, peraltro immaginaria, non possa dirci, per caso, molte cose non solo sul suo proprietario (immaginario), ma anche, e soprattutto, su colui che l’ha ideata: in questo caso, stiamo parlando della biblioteca di don Ferrante, descritta nel capitolo XXVII de I promessi Sposi, e, quindi, di ciò che essa ci rivela non di don Ferrante, ma del suo autore: Alessandro Manzoni.
Tutti i lettori dei Promessi sposi, debitamente imbeccati dai critici letterari, dicono e ripetono, e credono fermissimamente (cioè credono non per aver fatto un ragionamento personale, ma solo perché l’hanno sentito dire e ripetere infinte volte da qualcun altro) che Manzoni, nell’elencare i volumi della biblioteca di don Ferrante, il marito di donna Prassede – la coppia che ha preso in casa propria Lucia dopo il suo rapimento e la miracolosa liberazione dal castello dell’Innominato — ha inteso tracciare un ironico ritratto dell’erudito seicentesco, e, attraverso di esso, ha voluto mostrare quanto vuota, insulsa, libresca, polverosa, petulante, inconcludente, sciocca e frivola fosse la cultura del XVII secolo, suggerendo una evidente relazione di causa ed effetto fra quella disgraziata cultura decadente e la sventurata società che da essa veniva influenzata, s’intende nel peggiore dei modi… vale a dire, lontano dai lumi della ragione. E già qui sarebbe bene farsi qualche domandina sulla vera natura della religiosità di Manzoni, visto che nel XVII secolo non sa vedere altro che ignoranza e superstizione, e ne addossa indirettamente la responsabilità, oltre che alla (cattiva) dominazione spagnola, anche alla muffita e stantia cultura del secolo barocco; ma non ha saputo vedere per niente, neppure nella forma più vaga o più umile, quanto di buono vi era in un popolo che, non ancora sottoposto al fuoco di fila della cultura dei philosophes e del loro braccio armato, la massoneria, conservava schiettamente, se non altro, e sia pure in mezzo a forme rudimentali e "primitive", una fede cattolica schietta, radicata, che era parte integrante del vissuto di quelle popolazioni, e che traeva alimento da una tradizione antichissima, che aveva oltre un millennio e mezzo di storia dietro le spalle. Tuttavia, prendendo il povero don Ferrante quale avversario di comodo, una vera testa di turco, su cui rovesciare la sferza della sua (non bonaria) ironia, Manzoni si rende il gioco un po’ troppo semplice: lo avremmo apprezzato di più se si fosse scelto un avversario un poco più coriaceo. Il valore di un combattente si giudica dalla qualità del suo nemico: e se Manzoni, per trionfare sul "buio" XVII secolo, ha bisogno di ridicolizzare don Ferrante, di mostrare quanto vuota, insulsa e grottesca è la sua cultura, non si può dire che faccia lui stesso una gran figura. In compenso, se quella di don Ferrante — soprattutto attraverso la sua biblioteca — è una caricatura, quasi una barzelletta, il vincere facile di Manzoni ci dà più informazioni su di lui, di quanto egli non abbia forse supposto: riconosciamo l’illuminista tutt’altro che pentito, il razionalista che si è messo a frequentare i preti, il liberale che vuol sentirsi in accordo con le idee del suo secolo, mentre trova disdicevole che don Ferrante abbia voluto fare la stessa cosa col proprio. Insomma, come tutti i progressisti, dimentica che il vero progressista è sempre inattuale.
Il guaio è che i critici letterari gli sono andato dietro a ruota, prendendo per oro colato tutto quel che lui ha detto, sia di don Ferrante, sia del secolo XVII; hanno riso alle sue battute, ammiccato ai suoi frizzi, applaudito alle sue frecciate, più o meno come una scolaresca di codardi lecca-stivali si mette a sghignazzare alle battute del professore che ha preso di mira il solo alunno che osa pensare con la sua testa e che non si sottomette alla sua dittatura intellettuale. Ridono di don Ferrante, dei suoi libri, della sua cultura, perché Manzoni dà loro il segnale: figuriamoci, nel secolo di Galilei e della scienza, don Ferrante crede ancora alla magia e all’astrologia. Si può essere più buffi di così? Da qui la facile (troppo facile) equazione: progresso, uguale bene; tradizione, uguale male. Lungi da noi voler cadere nell’idealizzazione opposta, e voler fare di don Ferrante, per la foga di vendicarlo, un campione d’intelligenza e vero sapere; solo, ci sarebbe piaciuto vedere la sua figura tratteggiata più in chiaroscuro, con più complessità: via, uno psicologo acuto come Manzoni possibile non abbia saputo darci niente di meglio che questa macchietta sbozzata in fretta, prevedibile, banale, scontata, e pure approssimativa? Possibile che fra i quasi trecento volumi di don Ferrante, non ce ne sia uno di realmente interessante e profondo? Possibile che, in una vita intera spesa a leggere e a meditare (e non autori qualsiasi, ma Aristotele), non gli sia spuntato nel cranio un solo pensiero originale? Uno che sia uno; uno di quelli che riscattano un’intera vita di mediocrità, e gettano un raggio di luce anche nelle tenebre più fitte? Manzoni, come tutti i liberali, si fa forte di aver dalla sua il progresso, e il progresso è più eloquente di qualsiasi ragionamento: parla con la voce dei fatti. Ma i fatti dicono al liberale quel che egli vuole sentirsi dire: che solo un secolo d’ignoranti, o di falsi uomini colti, come il 1600, poteva produrre il flagello della peste, o, almeno, poteva consentire alla peste di menare una strage sì grande. Peccato che il liberale scelga sempre di soffermarsi su quei fatti che paiono dargli ragione, mentre finge di non vedere, e passa sotto silenzio, quelli che, in un modo o nell’altro, potrebbero mettere in crisi le sue magnifiche certezze. Tutto questo ha un nome: si chiama arroganza intellettuale; e ne abbiamo visti e ne vediamo tuttora, nel corso della storia, innumerevoli esempi, sempre con le stesse dinamiche, monotoni, perfino noiosi.
Ma torniamo agli scolari servili e codardi che sbeffeggiano il loro compagno per compiacere il professore tiranno. Si può dire che quasi tutti i critici letterari hanno seguito questa strada; fra tutti, nonostante l’imbarazzo della scelta, prendiamo Eugenio Donadoni (1870-1924), e, attraverso di lui, e dopo di lui, Piero Nardi (1891-1974): unendo le loro forze, i due valorosi manzoniani progressisti riducono veramente in polpette il povero don Ferrante, o piuttosto la sua memoria; la schiacciano, l’annientano, la cancellano, la riducono a un povero trofeo impagliato da appendere al muro (in: I promessi sposi, a cura di Piero Nardi, Milano, Mondadori, 1952, pp. 621-622):
Negli’ Sposi promessi’:"Possedeva una libreria di varie materie, la quale per poco non aggiungeva ai cento volumi" [contro i quasi trecento dei "Promessi"]. Non si dimentichi che siamo nel ‘600. Oggi, anche trecento volumi rappresenterebbero una biblioteca ben meschina! Va bene che il M. aggiunge subito: "tutta roba scelta". Lo aggiunge a ogni modo con una strizzatina d’occhio a noi lettori. E l’ironia si fa più accentuata con la nuova determinazione:"tutte opere delle più riputate". Delle più riputate perché don Ferrante uomo di studio, letterato, è il tipo dell’erudito per l’erudizione, l’uomo di cultura conservatore, e quindi arretrato. Pago di ripetere ciò che gli è stato detto, suoi idoli restano le opere più riputate, cioè quelle consacrate dalla tradizione. Riprendiamo col Donadoni: "Don Ferrante è il passato, è per il passato. Il decimosettimo è il secolo di Keplero e di Tiko-Brache [sic]: il secolo che vide nascere l’astronomia: e don Ferrante è competentissimo in… astrologia: il secolo decimosettimo è il secolo del Galilei e del Viviani e della fisica: e don Ferrante è un furioso cultore della magia e delle scienze occulte. È il secolo in cui la "Historia naturalis" di Bacone tracciava il metodo per giungere alle leggi della vita organica e inorganica: e don Ferrante è un lettore di lapidari, degli erbari e bestiari del Medio Evo. Il secolo decimosettimo rise di un riso europeo alla lunga, gioconda beffa del Cervantes contro la cavalleria: e lo studio principale di don Ferrante, quello che dava una parvente ragione di essere alla sua vita, e che solo poteva trarlo dalla sua biblioteca fra gli uomini, era la scienza cavalleresca. Il secolo decimosettimo è il secolo di Lord Bacone e di Cartesio, cioè dell’insurrezione universale contro l’Aristotile delle scuole: e don Ferrante sceglie come proprio modello il suo bravo Aristotile" (‘La dottrina nei "Promessi sposi", 1913). Così ci è schiusa la via a comprendere lo spirito dell’episodio famoso che va sotto il nome di descrizione della biblioteca d don Ferrante, e che meglio andrebbe sotto quello di rappresentazione della cultura di don Ferrante. Né sembri strano che volendo offrirci un quadro del sapere del secolo, a complemento del più vasto quadro del ‘600 offerto dal romanzo, il M. abbia voluto farne esponente un personaggio il quale rappresenta tutto il peso dell’eredità del passato, con esclusione, o quasi, d’ogni fermento di novità. Prima di tutto, il M. non poteva avere […] il concetto che del ‘600 abbiamo oggi noi; e in secondo luogo è da tener presente che queste pagine sulla cultura di don Ferrante introducono, ai fini del quadro storico, un elemento statico: esse sono generative, in quanto preparazione, nel quadro storico, all’episodio, fondamentale anche per lo sviluppo della vicenda del romanzo, della peste, il cui dilagare tremendo trova il suo perché appunto in tutto lo statico — in tutto l’arretrato e in tutto il superstizioso — che faceva parte troppo grande della cultura del secolo. […] Considerato in sé, come organismo spirituale indipendente dai tempi suoi, don Ferrante riesce a essere, grazie alla potenza creatrice del M., anche l’esponente del letterato puro – e quindi inutile, o, per immobilismo, per fedeltà alla tradizione, ai pregiudizi, dannoso – di tutti tempi.
No, caro Donadoni: non ci siamo. I suoi gusti in fatto di letteratura e filosofia non devono essere per forza migliori di quelli di don Ferrante; e nemmeno quelli del Manzoni. È solo il fatto di essere un seguace dell’ideologia progressista che glielo fa pensare, e che la induce a mettersi un gradino più in alto: tanto è vero che l’uomo di cultura "conservatore", secondo lei, è automaticamente anche "arretrato". Sillogismo troppo facile, e anche un po’ sciocco: esistono gli arretrati tanto fra i conservatori che fra i progressisti, non lo sapeva? Oppure pensa che essere fautori del progresso equivalga a essere sempre e comunque dal lato buono della storia? Lei ironizza, con Manzoni, sul fatto che opere consacrate dalla tradizione sono anche le più "riputate". Ma non è quello che fanno tutti, e che fa anche lei?, per esempio coi Promessi sposi, e specialmente col suo modo (conformista) di leggerli, cioè con quella fede cieca che si ripone solo in un testo sacro, da pare dei discepoli di quella religione? Non le è mai venuto in mente che la tradizione non è perenne (quella con la lettera minuscola, quanto meno), e che ciò che oggi la fa sorridere, perché le pare antiquato, un tempo riempiva i petti d’orgoglio per la sua novità e la sua arditezza? E che anche la tradizione che lei ora segue, anche le opere che lei oggi ammira come "le più riputate", un giorno, fra cinquant’anni, o fra cento o duecento, faranno sorridere qualcuno, e lei stesso, e quelli come lei, saranno paragonati a dei don Ferrante, stolidamente innamorati delle cose vecchie e passate? Lei dice, continuamente: il secolo decimo settino è il secolo dell’astronomia, di Galilei, della scienza, di Cartesio, eccetera: non la sfiora il pensiero che costoro non siano stati tutto il Seicento, e che molti, moltissimi loro contemporanei (specie all’inizio: e il romanzo è ambientato nel 1630-32, vale a dire prima del processo a Galilei), uomini di cultura e di pensiero non meno valorosi, avevano vedute assai diverse, sia riguarda la scienza, sia riguardo al progresso? Non lo sa che la maggior parte degli astronomi del Seicento criticavano Galilei e lo accusavano, giustamente, di voler essere creduto, allorché insegnava che solo il sistema di Copernico è giusto, senza avere uno straccio di prova a sostegno (o meglio, di averne una, le maree, ma del tutto sbagliata)? Non lo sa che la scienza moderna è nata staccandosi dalla magia, dall’alchimia e dell’astrologia, in maniera assai più complessa e sfumata di quel che poi si è voluto far credere? E che moltissimi illustri astronomi del tempo, come Tycho Brahe e Keplero, erano altrettanto dediti all’astrologia e facevano gli oroscopi? Quanto al Cervantes: che il Don Chisciotte sia una beffa e una risata sul mondo cavalleresco, dire una cosa simile denota solo quanta poca penetrazione e umiltà vi siano nel suo modo di porsi di fronte alle opere letterarie: lei le interpreta sempre e solo alla luce della sua ideologia progressista, e, se non può, le piega e le distorce, finché il risultato è quello. E caro Nardi, nemmeno con lei i conti tornano: la peste dilagò nel ‘600 perché la cultura del secolo era troppo arretrata? Ma arretrato è un concetto relativo, non assoluto: arretrata rispetto a cosa? Che dire allora del dilagare dell’Aids, nel tecnologico fine ‘900? Quanto alla sua equazione fra letterato puro e inutile, o dannoso: pensa davvero che siano meglio i letterati impegnati? I Majakovskij, gli Aragon, gli Éluard, i Brecht? Non le pare che siano un po’, come dire, penosi, specie se letti qualche anno dopo? Ma è chiaro che sia lei che Donadoni siete stati "traviati" dal Manzoni: la cui idea del ‘600 è greve, unilaterale, ingenerosa. Manzoni, illuminista, odiava di cuore il ‘600, quel ‘600: e come avrebbe potuto capirlo?
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels