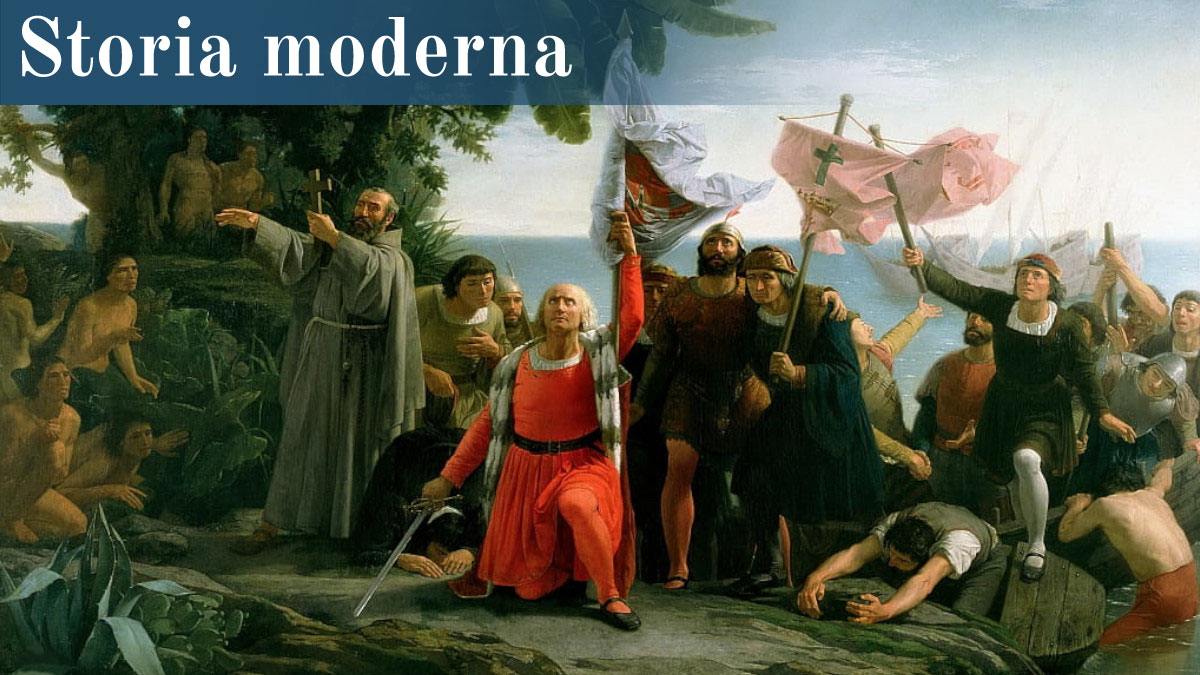La filosofia pensa l’essere; la psicologia, il pensiero
14 Agosto 2017
L’imbecille benintenzionato, flagello dell’umanità
15 Agosto 2017Quod Deus vult perdere, dementat prius: A coloro che vuol perdere, prima Dio toglie il senno; dementat, li fa impazzire, li rende simili a dei poveri dementi. È un antichissimo adagio, tratto da una tragedia di Euripide e volto dal greco in latino, con Zeus, ossia Giove, naturalmente, al posto del generico "Dio", e successivamente adattato alla cultura cristiana, appunto con quella piccola, ma sostanziale modifica. È una frase straordinariamente acuta e piena di verità, che la storia degli uomini, e anche quella dei singoli individui, ha illustrato, ed illustra, infinite volte. Un tipico esempio di questo accecamento, di questo ottenebramento della ragione e della lucidità più elementare, è riscontrabile nella decisione di Napoleone Bonaparte di proseguire la guerra contro la sesta coalizione, nel 1813, nonostante l’offerta di mediazione dell’imperatore d’Austria, che, se accettata, avrebbe probabilmente permesso a Napoleone di arrestare la frana del suo impero e di arrivare a un modus vivendi con le altre potenze, ridimensionando, ovviamente, i suoi disegni di egemonia europea e mondiale.
Forse non tutti sanno che, fra la disastrosa campagna di Russia del 1812, e la fatale battaglia di Lipsia dell’ottobre 1813, la bilancia fra i due schieramenti rimase per un po’ sospeso. Le forze militari dell’Impero napoleonico da una parte e quelle della la Sesta coalizione dall’altra, furono per diversi mesi in equilibrio. Non solo Napoleone, ricorrendo a nuove leve e raschiando il fondo della pentola, era riuscito a mettere nuovamente in campo un grosso esercito, sia pure formato, in gran parte, da coscritti con poca istruzione e nessuna esperienza, perché i veterani della Grande Armata, vincitori di cento battaglie, erano rimasti sepolti sotto le nevi della Russia, o erano tuttora impegnati in una lotta interminabile coi guerriglieri spagnoli; era anche riuscito a riportare due vittorie significative, anche se non decisive, sui Russi e sui Prussiani riuniti, a Lutzen il 2 maggio e a Bautzen il 21 maggio, cosa che gli consentì di firmare, in posizione di vantaggio, l’armistizio di Pleiswitz, con la mediazione dell’Austria, il 4 luglio, che avrebbe dovuto durare fino al 20 luglio, mentre poi venne prolungato sino al 16 agosto. In realtà, entrambi i gruppi di eserciti avevano bisogno di una pausa per potersi riorganizzare; entrambi avevano esercitato il massimo sforzo, ma i loro capi si rendevano conto che una soluzione definitiva era ormai prossima, se fossero riusciti ad infliggere all’avversario il colpo finale. Entrambi avevano subito ingenti perdite, dovevano integrare gli armamenti, le munizioni, i cavalli e i viveri; entrambi, che avevano fatto ricorso alla coscrizione straordinaria, erano afflitti dalla piaga delle diserzioni, perché le truppe erano stanche e provate dalle incessanti campagne militari. A Lutzen, Napoleone aveva potuto disporre di una superiorità numerica schiacciante: 180.000 uomini contro meno di 70.000 Russi e Prussiani, con un vantaggio di oltre due a uno; ma a Bautzen i rapporti si erano invertiti e aveva dovuto affrontare 250.000 nemici con soli 200.000 uomini. E siccome, per usare la sua celebre massima, Dio sta dalla parte dei grossi battaglioni, era già un successo insperato che fosse riuscito a strappare la vittoria, sia pure una vittoria tattica e non una decisiva vittoria strategica. Aveva, tuttavia, occupato Breslavia; l’Austria, resa prudente dalle precedenti disfatte, e vedendo che Russi e Prussiani non riuscivano a spuntarla neppure dopo la campagna del 1812, conservava la propria libertà d’azione, seguendo attentamente l’evolversi della situazione e riservandosi, secondo ogni evidenza, di entrare in campo, al momento per lei più favorevole, dalla parte del probabile vincitore. Stando così le cose, alcuni storici ritengono che Napoleone abbia commesso un errore accettando di firmare l’armistizio di Pleiswitz, che consentì ai suoi nemici di riorganizzarsi e di superare un momento particolarmente difficile: se non avesse dato loro respiro, come tante volte aveva fatto in passato, e li avesse premuti ed inseguiti a fondo, così essi ritengono, è probabile che sarebbe riuscito ad infliggere loro il colpo decisivo. Vedremo che questa tesi non è immune da critiche.
Il secondo errore, politico questa volta, fu quello di respingere la proposta di mediazione attiva da parte dell’Austria, che già si era rivelata preziosa per giungere alla tregua di Pleiswitz. A Praga, dopo le battaglie di Lutzen e Bautzen, erano stati iniziati dei negoziati di pace, che, in effetti, servirono soprattutto allo zar Alessandro e al re di Prussia, Federico Guglielmo, per rafforzarsi, e al re di Svezia, Carlo XIII, su pressione del principe Jules Bernadotte (ex maresciallo francese) per decidere l’intervento al loro fianco; all’Austria, infine, nella persona del ministro Metternich, di tastare il polso a Napoleone e rendersi conto di quale fosse il suo gioco. Ed ecco come lo stesso Metternich, inviato dal suo imperatore, Francesco I d’Asburgo (dal 1810 suocero di Napoleone per via del matrimonio di questi con Maria Teresa, sua figlia) narra, nelle sue memorie, l’incontro che ebbe con Napoleone, a Dresda, il 26 giugno 1813, nel quartier generale del sovrano francese. La sua missione era di convincere quest’ultimo a sottoscrivere una pace definitiva con la Sesta coalizione, lasciando però capire che, in caso contrario, l’Austria si sarebbe sentita libera di agire in conformità ai propri interessi, cioè di unirsi ai coalizzati; dietro i quali, lo si tenga ben presente, c’era sempre la potenza navale, economica e finanziaria della Gran Bretagna (cit. in: Pietro Silva, Lezioni di storia civile ed economica, Milano, Principato Editore, 1954, pp. 394-396):
Napoleone mi aspettava ritto in piedi, in mezzo al suo gabinetto, con la spada al fianco ed il cappello sotto il braccio. Si avanzò verso di me affettando una grande calma; e mi domandò notizie dell’imperatore d’Austria. Ma ben presto la sua fisionomia si oscurò, e piantandosi davanti a me mi parlò in questi termini: "Dunque,voi volete la guerra; ebbene, l’avrete. Io ho distrutto l’armata prussiana a Lutzen; ho battuto i russi a Bautzen; voi volete avere il vostro turno: vi dò appuntamento a Vienna". "La pace e la guerra — gli risposi — sono nelle mani di Vostra Maestà. La sorte dell’Europa, il suo avvenire e il vostro, tutto dipende soltanto da voi. Fra le aspirazioni dell’Europa e le vostre esiste un abisso. Il modo ha bisogno di pace. Per assicurare codesta pace occorre che voi rientriate nei limiti che sono conciliabili con la pace e la tranquillità di tutti, oppure che voi siate vinto nella lotta. Oggi voi potete concluderla pace; domani forse sarebbe troppo tardi. L’imperatore mio signore si lascia guidare nella propria condotta unicamente dalla voce della propria coscienza; a vostra volta, Sire, consultate la vostra".
"Ebbene che cosa si vuole da me? — disse bruscamente Napoleone — che io mi disonori? Giammai! Io saprò morire, ma non cederò giammai un pollice di territorio. I vostri sovrani, nati sul trono, possono lasciarsi battere venti volte di seguito e ritornare malgrado ciò sempre nelle loro capitali; io non lo posso, perché io sono un soldato venuto su dal nulla. Il mio potere non continuerebbe a sussistere il giorno in cui io avessi cessato di essere forte e di conseguenza di essere temuto". A queste affermazioni aggiunse l’altra, che egli in Russia non era stato vinto; e che la sua armata era ormai pienamente ricostituita. Io gli obiettai che la sua armata voleva la pace. "No, non è l’armata, — disse Napoleone interrompendomi bruscamente — sono i miei generali che vogliono la pace. Io non ho più generali degni di questo nome. Il freddo di Mosca li ha demoralizzati. Ho visto i migliori ed i più coraggiosi piangere come bambini. Erano spezzati fisicamente e moralmente. Quindici giorni fa io potevo fare ancora la pace, oggi non lo posso più. Ho guadagnato due battaglie: non farò la pace". "In tutto ciò che Vostra Maestà mi dice — gli feci osservare io — vedo una nuova prova che l’Europa e Vostra Maestà non possono intendersi. I trattati conclusi tra l’Europa e Vostra Maestà non sono stati mai altro che armistizi. I rovesci al pari dei successi vi spingono alla guerra. È giunto il momento in cui voi e l’Europa vi gettiate scambievolmente il guanto di sfida: voi e l’Europa lo raccoglierete; ma non sarà l’Europa che soccomberà nella lotta".
Il colloquio si era prolungato fino alle otto e mezzo di sera, faceva ancora notte e nessuno aveva osato entrare nel gabinetto. Quando Napoleone mi congedò, il suo volto era ritornato calmo e quasi amichevole. Mi condusse fino alla porta della sala di servizio e mettendo la mano sul bottone della porta mi disse: "Noi ci rivedremo, spero". "Ai vostri ordini, Sire; – gli risposi — ma io non ho speranza di conseguire gli scopi della mia missione". "Ebbene — continuò Napoleone battendomi sulla spalla — sapete voi che cosa accadrà? Voi non farete la guerra". "Voi siete perduto, Sire; — gridai vivacemente — ne avevo il presentimento venendo qui, ora che me ne vado ne ho la certezza".
Ammesso che il colloquio si sia svolto realmente un questi termini – e, per varie ragioni, possiamo forse dubitare che Metternich lo abbia un po’ colorito, ma non che ne abbia sostanzialmente alterato il contenuto — giungiamo alla conclusione che Napoleone aveva visto molto bene quale fosse la necessità che lo spingeva a rifiutare la pace e a giocare il tutto per tutto sul campo di battaglia, ciò che lo avrebbe condotto alla sconfitta irreparabile di Lipsia, il 16-19 ottobre, dove, con un esercito di 190.000 uomini insufficientemente addestrati e con poca cavalleria, si trovò ad affrontarne uno di ben 380.000 (salito a oltre 400.000 dopo il voltafaccia di molti reparti tedeschi), formato da Russi, Prussiani, Austriaci e Svedesi. Del resto, la debolezza della cavalleria si era già fatta sentire nelle operazioni precedenti, a Lutzen e a Bautzen, rendendo impossibile l’inseguimento a fondo del nemico sconfitto, che avrebbe trasformato quei successi parziali in una vittoria risolutiva. Perciò, non è detto che la vera causa della sconfitta di Lipsia sia da ricercare nel breve armistizio di Pleiswitz, anche se Napoleone lo avrebbe poi definito la più grande sciocchezza della mia vita. Ma questo giudizio serviva forse a medicare il suo orgoglio ferito di guerriero infallibile, attribuendo le cause della sconfitta a un errore politico. Nella situazione di sostanziale stallo esistente alla fine di giugno 1813, il tempo lavorava a favore della Coalizione: il mito della invincibilità napoleonica si era infranto sulle nevi della Russia, e anche, in maniera meno appariscente ma altrettanto significativa, sulla Meseta iberica, ove gli eserciti francesi si logoravano in una lotta sanguinosissima che li vedeva sempre più costretti sulla difensiva (anche per l’attiva partecipazione britannica alla riscossa spagnola). Vi era un nocciolo di verità nelle parole di Metternich, che l’Europa era contro Napoleone, perché essa voleva la pace e lui la guerra. Se, infatti, l’armistizio di Pleiswitz fu un errore politico, fu un errore contingente; l’errore di fondo di Napoleone fu quello d’illudersi di poter governare la Francia, e dominare l’Europa, combattendo sempre e vincendo sempre. Nella sua ammissione di essere costretto a combattere per non mostrarsi debole davanti ai suoi sudditi e davanti ai nemici esterni, vi era l’implicita ammissione che tutta la sua costruzione politica era fragile e illusoria. È vero, infatti, che i sovrani dell’ancien régime potevano permettersi di subire sconfitte su sconfitte, senza rischiare il trono, mentre per lui anche una sola sconfitta sarebbe risultata fatale: ma ciò significa che egli era, di necessità, il vero ostacolo alla pace, per il suo Paese e per l’intero continente. Era dunque inevitabile che si formasse una coalizione generale contro di lui, e che anche all’interno della Francia si organizzassero le forze desiderose di abbattere il suo potere. Dopo oltre vent’anni di guerre pressoché ininterrotte, tutti i popoli europei erano sfiniti e non desideravamo che la pace. Oltre a questo, Napoleone, per i suoi scopi di politica estera, aveva incoraggiato la nascita, o la rinascita, del sentimento nazionale del popolo italiano e di quello polacco (i due ultimi che gli rimasero fedeli, infatti, sia pure parzialmente, sin quasi all’ultimo); ma lo stesso sentimento non poté non essere sollecitato anche negli altri popoli, che, come quello spagnolo, o tedesco, o russo, subirono l’invasione francese e videro messa in pericolo la loro indipendenza. In altre parole, Napoleone aveva acceso nei popoli il sentimento nazionale, sfidando la loro lealtà dinastica: ma il sentimento nazionale, una volta ravvivato, non poteva essere regolato a comando, e finì per ritorcersi inevitabilmente contro di lui, quando egli mostrò il suo vero volto di conquistatore avido di potere, non di liberatore dei popoli oppressi. Inoltre, cercando di creare nei suoi sudditi una nuova fedeltà dinastica, basata su un compromesso coi principi democratici della Rivoluzione del 1789, egli mise mano a un progetto complesso e articolato, che avrebbe richiesto molto tempo per realizzarsi, mentre tempo non ne aveva, per le ragioni anzidette. Alla fine, la fedeltà dinastica dei sudditi russi, prussiani, austriaci, spagnoli, per non parlare dei britannici, ebbe la meglio sulla fedeltà dei francesi a un monarca venuto su dal nulla, che pretendeva di fondare dall’oggi al domani una nuova dinastia (anzi, tutta una serie di dinastie fra loro imparentate). In questo senso, la sconfitta di Napoleone, al di là dei fattori militari, era solo una questione di tempo…
Fonte dell'immagine in evidenza: Immagine di pubblico dominio