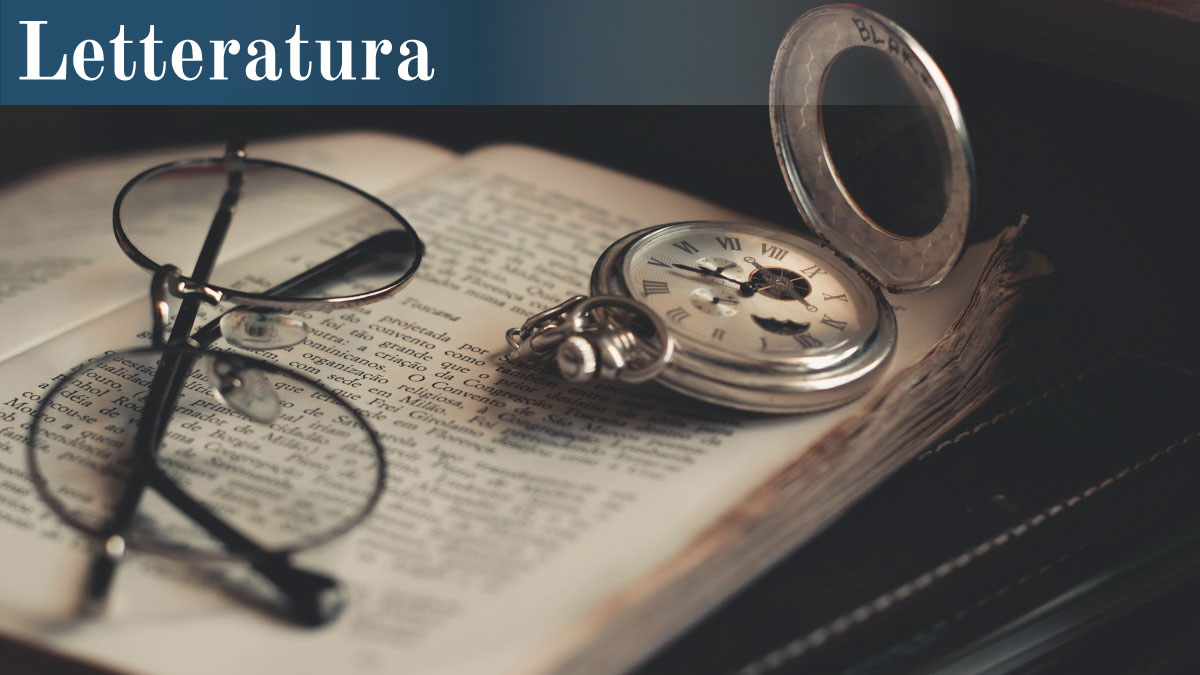Alain Fournier, il poeta del miracolo quotidiano
21 Luglio 2017
Mihail Sadoveanu, limpida eco d’un mondo sparito
23 Luglio 2017Nella narrativa di Joseph Conrad, pseudonimo di Jozef Teodor Nalecz Konrad Korzeniowski (Berdicev, presso Žitomir, Ucraina, 3 dicembre 1857-Bishopsbourne, Kent, 3 agosto 1924), scrittore polacco naturalizzato britannico, e universalmente noto come autore di romanzi quali La follia di Almayer (1895), Il negro del "Narciso" (1897), Cuore di tenebra (1899), Lord Jim (1900), Tifone (1902), Nostromo (1904), L’agente segreto (1907), vi è, silenziosa e inquietante, la presenza di una sorta di coinquilino segreto, un "doppio" del protagonista, di solito un capitano di nave – come lo era lo scrittore — che lo accompagna nei suoi viaggi su mari lontani e non si separa mai da lui, e che, talvolta, lo spinge ad azioni brusche e inopinate, o lo trattiene e lo paralizza quasi inspiegabilmente, come accade al protagonista di Lord Jim, imprimendo una svolta repentina e decisiva alla sua vita, e rivelandogli, nello stesso tempo, un aspetto di sé che era rimasto sino ad allora pressoché ignorato.
Questa presenza ambigua, questo ospite sgradito, ha qualcosa d’inquietante, di opprimente: l’eroe di Conrad sente che non sarà mai del tutto al sicuro, finché costui gli starà da presso: e sembra che l’unica maniera per esorcizzarlo sia quella di levare le ancore e puntare al largo, con il vento nelle vele, perché solo nella libertà del mare aperto, laggiù, fra mare e cielo, lontano dal mondo degli uomini, egli trova la pace con se stesso. Ma è soltanto un’illusione, naturalmente; una tregua momentanea. Proprio per la sua natura di inquilino interiore, lo scomodo personaggio non può essere liquidato così, semplicemente lasciandolo a terra, come un passeggero che resta sulla banchina e che si saluta dalla murata, agitando il fazzoletto. Egli è dentro l’eroe conradiano, e, presto o tardi, farà la sua comparsa; è vero, però, che il fatto di salpare le ancore e riempirsi le narici con il profumo della salsedine e delle vaste distese di mare aperto, attenua l’angoscia e dà la sensazione di una liberazione, di uno spazio riguadagnato e strappato ai propri fantasmi interiori. Ma di quali fantasmi si tratta?
C’è, in tutti gli eroi di questo scrittore, un lato oscuro, che emerge sotto forma d’improvvisi cedimenti, anzi, di "assenze" della coscienza, la cui vigilanza si allenta d’improvviso, e provoca una catastrofe repentina. Così è nel suo libro forse più famoso, Lord Jim: un giovane ufficiale di belle speranze, forte, volitivo, apparentemente sicuro di sé, le cui certezze vanno in briciole da un momento all’altro, quando, di notte, mentre tutti dormono, il panico s’impadronisce del capitano e dei macchinisti per una supposta collisione, che, si pensa, provocherà a momenti il naufragio: e anche lui si lascia convincere a salire sulla scialuppa di salvataggio, abbandonando al loro destino centinaia di pellegrini musulmani diretti alla Mecca. In quel momento cruciale, egli si muove come un automa, e troppo tardi si rende conto della gravità e, soprattutto, della irreparabilità dell’azione commessa: fino a un momento prima si sentiva capace di sfidare il mondo, e ora non è che un sopravvissuto, pieno di vergogna e di rimorsi, anche se il vecchio e malandato Patna, dopotutto, non è affondato, e nessuno è morto: ma la viltà del comportamento di quei quattro uomini, fra i quali Lord Jim, bollati ormai per sempre a fuoco dalla loro codardia, non potrà più essere cancellata, e tutta la vita del giovane, da quel momento in poi, sarà rivolta a cercare una seconda occasione, mezzo indispensabile per giungere all’agognato ma impossibile riscatto.
In questo caso, almeno, le cose sono chiare, e il protagonista se bene quale sia la sua colpa, che lo esclude dal consorzio degli uomini e lo spinge a cercare la redenzione lontano dal mare e dalla sua vita di prima, nella quale ha clamorosamente fallito, tradendo se stesso; ma in altri casi il senso di colpa non ha una radice altrettanto facilmente identificabile, e somiglia piuttosto a quel diffuso, impalpabile e inspiegabile senso d’inadeguatezza, e quindi di colpa (perché, specialmente nel modo moderno, dominato dalla tecnica e dalle leggi dell’efficienza produttiva, essere inadeguato è la colpa più grave di tutte), che perseguita i personaggi di Kafka. Nel caso di Conrad, pare che questo senso penoso di non essere all’altezza abbia a che fare essenzialmente con un difetto della volontà. I suoi eroi sono solidi, ma solo all’apparenza; in realtà, sono divorati da una timidezza, da una goffaggine, da una desiderio di fuga, che li respingono dalla vita degli altri e che li spingono a cercare la pace nella solitudine del mare aperto. Ecco perché gli eroi di Conrad sono un po’ più sereni solo quando sciolgono le vele al vento; sulla terraferma, si muovono con il disagio e la pesantezza dell’albatro nella famosa poesia di Baudelaire. A terra, nelle città, in mezzo agli altri, non si sento mai a loro agio: hanno bisogno di spazio, di silenzio e solitudine; e questo li accomuna a quanti scelgono la vita contemplativa, ai monaci che si chiudono in convento per trovare Dio, e, con Lui, anche la parte più vera di se stessi. Se non fosse per la loro sensualità, per il loro bisogno della donna, gli eroi di Conrad sarebbero degli asceti, o degli aspiranti asceti: rifuggono i piaceri materiali, e specialmente l’avidità del guadagno; sono impermeabili a quasi tutte le ambizioni dei comuni mortali, e, in fondo, sono proiettati verso un qualcosa cui non sanno dare un nome – e non sa farlo neppure Conrad -, ma che ha forse a che fare proprio con Dio. Ma non possiedono ali abbastanza ampie e robuste per volare così in alto; restano intrappolati a metà strada, fra il piano della vita di ogni giorno e la dimensione dell’assoluto, alla quale si protendono, ma che, in ultima analisi, non sanno riconoscere. Sono dei sognatori, anche se le apparenze, sovente, ingannano. Nello stesso tempo, si vergognano della loro debolezza e ci tengono moltissimo a non sfigurare davanti agli altri.
Inoltre, dato che si muovono, per professione e per vocazione, in un ambienti esotici, sentono anche il dovere di non far sfigurare la razza bianca e di mostrarsi agli indigeni come persone volitive, forti, immuni da dubbi paralizzanti, e perciò degne anche di comandare, perché solo chi sa comandare a se stesso è degno di comandare sugli altri; tanto che qualcuno, come lo scrittore nigeriano Chinua Achebe, non si è peritato di accusarlo di "razzismo" (il che, naturalmente è una grossa sciocchezza; ma valle a sradicare, o anche solo a scalfire, le sciocchezze politically correct). Dentro di sé, tuttavia, questi eroi conradiani non sono così saldi come vorrebbero apparire: e questa è la loro contraddizione fondamentale. Almeno Petrarca lo sapeva, di vivere in un perenne sdoppiamento: quel doppio uomo che è in me, diceva di se stesso nella lettera del monte Ventoso, citando sant’Agostino. Gli eroi di Conrad non sanno veramente chi sono: quando la realtà li urta con sufficiente ruvidezza, tutto ciò che credevano di sapere a proposito di se stessi va in mille pezzi, e si trovano a dover riscoprire il proprio io partendo da zero, dalla dura necessità di una espiazione radicale.
A proposito del "doppio" degli eroi conradiani, ha osservato lo scrittore e giornalista Ottavio Cecchi (Grosseto, 1924-ivi, 2005), nella nota introduttiva al volume Racconti di mare e di costa di Joseh Conrad (titolo originale: ‘Twixt Land and Sea; traduzione di Piero Jahier, Milano, Mondadori, 1958, 1971, 1980, pp. IX-XI):
Nell’opera complessiva di Conrad c’è un personaggio definibile come "coinquilino segreto", l’alter ego di un capitano che racconta le sue avventure di mare e di costa.
Finché questo "compartecipe" non si allontana, il capitano non ha pace. Per sfuggirlo deve abbandonare la costa, andarsene di nuovo sul mare, magari nell’occhio del tifone, dove la calma è assoluta. La presenza dell’altro è incomoda, è una sorta di malattia o insomma un rimorso che affiora quando, lontano dall’alto mare, torna alla memoria un senso di trasgressione: per quel momento di "assenza interiore" che un marinaio può aver sofferto una volta o un’altra durante le sue peregrinazioni. Il capitano che racconta la sua avventura, nasconde in sé la coppa per quel momento di assenza. Ma l’esorcismo deve avvenire e prima o poi avviene: l’alter ego allora, è risucchiato nell’ombra dalla quale è sorto. Il momento della scomparsa del personaggio segreto coincide con l’uscita della nave in mare aperto: la liberazione. Quando la prua fende il mare verso il largo, il capitano si lascia alle spalle insieme alla miseria piccolo borghese della costa (lembi di terra, isole, porti, dove può avere la meglio — come sta per accadere in "Un briciolo di fortuna" o in "Freya delle Sette Isole" — un trafficone che tenta la fortuna in modo poco pulito, ma anche il vischioso sentimento d’amore per una donna), quell’altro se stesso, quel complice sgradito che impedisce all’uomo Conrad di essere capitano, un uomo che domina se stesso e gli altri dal posto di comando.
Capitani si è dunque soltanto in mare aperto, fra tempeste e bonacce, quando si riesce a dominare tutto ciò che è sconosciuto. Nel grande racconto La linea d’ombra, in "Tifone", nel "Negro del ‘Narciso’"e in "Nostromo" l’esorcismo si ripete. Necessari compagni dell’uomo che guida la nave sono il rischio e la morte; ma energia e calma disprezzo per chi non sappia mantenere un assoluto dominio di sé esorcizzando l’"altro", contrastando ogni potere a quelle presenze,e, alle furie del mare e del cielo, allo sgomento umano, alla paura, alla fragilità della barca. Microcosmo sul quale regna lui — sovrano assoluto — il Capitano.
L’uomo di Conrad pare discendere così, in linea retta, da un "esprit fort" settecentesco e tuttavia non fugge la costa per ritrovare, sul mare, un paradiso perduto, quanto invece per affermare il proprio dominio sulla natura e su se stesso. È, in realtà, un romantico, un uomo scisso alle prese con il trasgressore, con l’altro capitano che, come Jim, ha abbandonato la barca e il suo carico umano, secondando quel momento di assenza interiore.
La solitudine sul mare aperto non è una condanna ma un riscatto e una vittoria sull’"altro", che si è materializzato nel giuoco dei rapporti sociali fra gli uomini di terraferma, tra quegli uomini che, raccontando le loro avventure, come cacciatori dopo una battuta, popolano le case dei marinai nei porti: capitani alla fine della carriera, giovanotti che aspettano il momento buono per il primo comando. Patetici, gli uni e gli altri: morsi dall’inquietudine per una vita spesa male, o per una giovinezza che non dà sfogo al desiderio di tentare il mondo. Incapaci di tener testa a un qualsiasi spacciatore di cattiva merce, che può permettersi di dar dello straccione a un lupo di mare, incerto sulla terraferma, stranamente vestito, con un cappello borghese poco adatto alla sua faccia, con un ombrello agganciato al braccio… o peggio (come alla fine della storia accade al capitano del "Narciso"), con una quieta moglie piccolo-borghese al fianco.
Tutta l’opera do Joseph Conrad appare come un lungo racconto fra mare e costa. Protagonista il capitano; antagonista, il compagno segreto che il capitano porta con sé, clandestino a bordo finché la nave non riprende il mare. L’alter ego è una coscienza rammemoratrice di quell’assenza, di quella trasgressione. Tutto sta a vedere quando la trasgressione sia avvenuta. Può essersi prodotta durante il primo comando, in mare aperto, nel momento preciso in cui il giovane capitano stava per oltrepassare la linea d’ombra. Può essere stato un atto corrispondente al saltar fuori dalla barca abbandonando un carico di pellegrini, ma anche un momento di terrore dell’ignoto: nell’un caso o nell’altro, sia che s’"interri" e tenti la fortuna tra la gente di costa, sia che continui il suo viaggio, per mare e porti, il capitano dovrà portarsi dietro l’altro, il trasgressore. […]
L’uomo conradiano non s’illude alla maniera di Robinson, di rifare il mondo su un’isola deserta; né ricostruisce per sé solo il miglior angolo possibile del mondo che si è lasciato alle spalle, alla maniera di Stevenson. Egli intuisce che dovunque andrà si porterà accanto la sua colpa, il mondo che ha lasciato e il tormento che gli viene da un rapporto sociale in cui, a un tratto, per quell’assenza di un attimo, si è verificato un "disaccordo". Non può farsi illusioni, può solo tentare di vivere una solitaria vita eroica che lo costringa ad affrontare sempre di nuovo la paura dell’ignoto e dell’altro se stesso. La fuga sul mare, è veramente così un atto romantico; sciogliere le vele, puntare al largo la polena corrisponde al solo possibile tentativo di redenzione.
C’è qualcosa di Conrad nei protagonisti dei suoi romanzi e racconti di mare; anzi, c’è molto, moltissimo di lui. Si sa che tutta la sua vita di marinaio fu caratterizzata da brusche partenze e fughe improvvise, da impiegabili malattie e rinunce dell’ultimo istante, come se fosse stato inseguito e tormentato da un malessere interiore che gl’impediva di essere quel lupo di mare forte e sicuro di sé che avrebbe voluto, e del quale aveva l’apparenza. Il suo motto era: non lasciar trasparire in nulla i propri turbamenti interiori; ricacciarli sotto la superficie, dove nessuno li possa scorgere. Era un aristocratico polacco sino alla punta delle dita (come disse di lui Bertrand Russell, che volle conoscerlo di persona), e il suo aristocraticismo gli rendeva impossibile far vedere le lotte interiori che doveva sostenere per essere saldamente se stesso, per non vacillare. Anche lui ospitava un coinquilino segreto; anche lui era alle prese con un compagno, con un doppio indesiderato, del quale non sapeva come liberarsi. Il tema diventa esplicito nel racconto Il coinquilino segreto, che fa parte dei citati Racconti di mare e di costa; tuttavia si direbbe che la soluzione narrativa non riesca a rendere ragione sino in fondo del significato di questa oscura presenza a bordo della nave (cioè dell’inconscio di Conrad). Infatti, i fantasmi dei quali si può parlare a voce alta, sono già, per metà, esorcizzati; ma quelli che fanno più paura, o, in ogni caso, quelli che destano maggiore inquietudine, sono quelli dei quali non si può dire nulla, perché nessuno li ha mai visti. Come Le Horlà di Maupassant, si tratta di visitatori indesiderati, ma talmente abili da spargere solo gli indizi della loro presenza, senza farsi scoprire neppure una volta. E ciò crea una tensione sempre più acuta, una tensione di tutta la sensibilità, come quando si attende lo scoppio del tuono, dopo il bagliore del fulmine, ma quello scoppio tarda ad arrivare, e così la tensione cresce sempre più e diventa minacciosa, ossessiva.
La contemporaneità di Conrad consiste nell’aver messo al centro della sua narrativa questa presenza umbratile e inquietante, questo "altro" che si tiene nascosto in ciascuno di noi, fino a quando le circostanze esterne, all’improvviso, gli daranno l’occasione di manifestarsi, sconvolgendo le nostre vite. Vite che, di conseguenza, si svolgono all’insegna della precarietà: perché, pur non vedendolo, noi sospettiamo l’esistenza di questo coinquilino segreto, e, naturalmente, ne proviamo sia curiosità, sia timore. Curiosità, perché siamo annoiati dalle certezze "scientifiche" che la cultura dominante, sotto il segno del positivismo e del neopositivismo, ci ha costruito intorno, e ci ha imposto anche nei confronti di noi stessi: certezze che sentiamo essere ingannevoli, e che viviamo come le sbarre di una invisibile prigione. Timore, perché non abbiamo la minima idea della natura, della potenza, o della debolezza, di questo nostro ospite clandestino, e non siamo affatto sicuri di essere, noi, abbastanza limpidi e in pace con noi stessi, da potergli resistere. Oh, alla luce del giorno, quando tutto procede nella routine, e noi siamo coi piedi ben piantati sul ponte della nostra navicella, allora sì, che ci sentiamo sicuri del fatto nostro; ma di notte, quando si allungano le ombre e nulla ha più l’aspetto abituale, e qualsiasi cosa potrebbe sbucar fuori dal buio, cogliendoci impreparati, allora la musica è ben diversa: allora sappiamo, sentiamo, cosa intendeva Conrad, allorché popolava i suoi romanzi di questa strana, elusiva e tuttavia inquietante presenza.
L’importante è stare attenti a non superare la linea d’ombra, perché, del paese che si estende al di là di essa, nulla sappiamo, e ignoriamo quali sorprese ci potrebbe riservare. Il problema è che, quando la si oltrepassa, ciò avviene quasi sempre in maniera del tutto inavvertita: come direbbe Pirandello, non si sa come…
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels