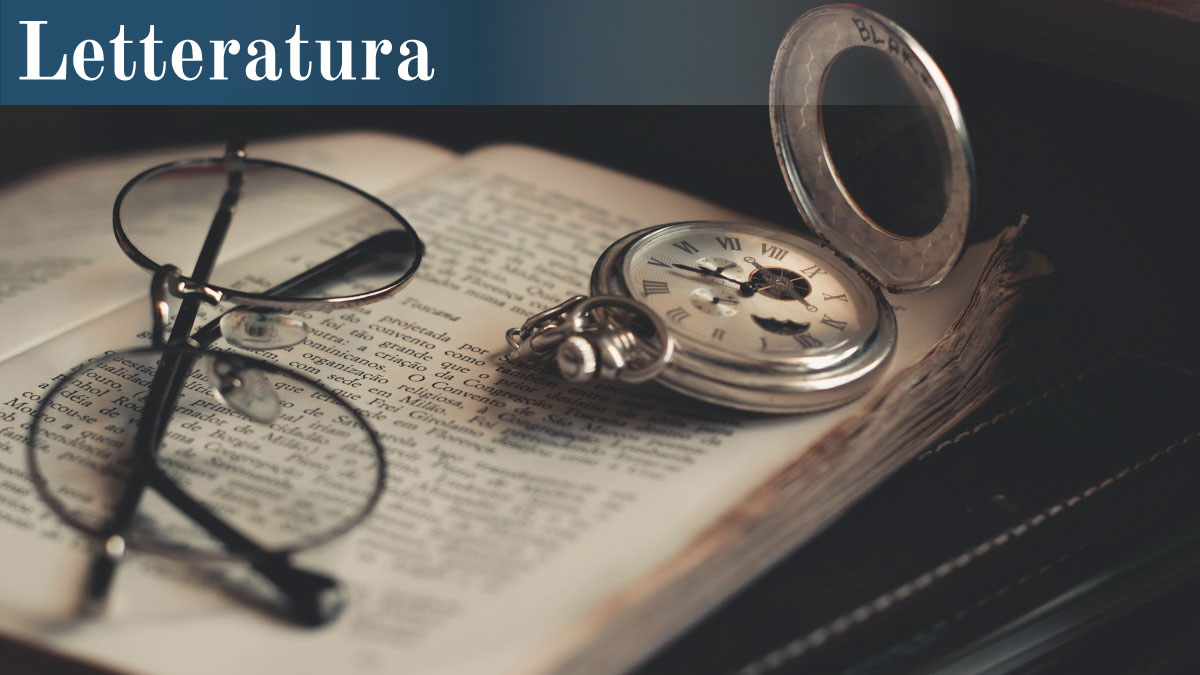Questo è uno strano, stranissimo Paese
25 Aprile 2017
Tu solo hai parole di vita eterna
25 Aprile 2017C’è, ne I fratelli Karamazov – una delle maggiori opere letterarie del XIX secolo, e di tutta la letteratura mondiale – un episodio in cui entra in scena, anche se per poche pagine, colui che è senza dubbio il protagonista più ignorato e misconosciuto della storia umana, e in particolare della storia moderna: l’antico Avversario, colui che sin dall’alba della vicenda umana si è adoperato, e non cessa di adoperarsi, anzi, raddoppia viepiù gli sforzi, per allontanare l’uomo da Dio, e, con ciò, per sradicare l’uomo anche da se stesso, dalla propria umanità, spingendolo, così, verso l’abisso tenebroso della pazzia e dell’autodistruzione.
Già il fatto che sia quasi il solo episodio in cui appare il diavolo fra le opere moderne — a parte la narrativa di genere gotico e fantastico, e a parte la poesia, specialmente romantica, in cui egli compare nelle vesti di bel Tenebroso, sulla scia dell’Angelo Caduto di Milton — fa profondamente riflettere. Tolto il Faust di Goethe e Il Maestro e Margherita di Bulgakov, fra la metà del XIX e la metà del XX secolo sono ben poche le opere in cui egli si manifesta. E la cosa singolare è che sono proprio gli scrittori cristiani i più restii a parlarne, quasi temessero il dileggio altrui, mentre non lo teme un Baudelaire, quando afferma che la più grande vittoria del diavolo è quella di essere creduto inesistente. Nemmeno una parola su di lui, per esempio, ne I promessi sposi di Alessandro Manzoni, l’epos del romanzo cattolico moderno: come mai? Forse l’illuminista Manzoni, il liberale Manzoni, temeva di evocare i fantasmi del Medioevo o i processi agli untori, da lui giustamente criticati? Anche Tolstoj, anche Chesterton, anche Graham Greene sono restii a parlarne; preferiscono lasciare il campo ai massoni anticristiani come Carducci, che ne parla per esaltarlo come la personificazione del Progresso. Dostoevskij, dunque, è uno dei pochissimi scrittori cristiani che non teme di tirare il diavolo per la coda: non teme di attirare sui di sé il biasimo, l’ironia, il ridicolo, i sorrisetti di sufficienza degli intellettuali, primi fra tutti quelli sedicenti cristiani: ma, beninteso, cristiani al passo con il mondo moderno e con le idee moderne. Per non parlare dei teologi modernisti: quando mai hanno parlato del diavolo? E quando mai ne hanno parlato gli scrittori cattolici di tendenza modernista, come Antonio Fogazzaro, che pure non si perita di parlare di reincarnazione, spiriti e ossessioni spiritiste?
In secondo luogo, il diavolo di Dostoevskij rinuncia alle corna e all’odore di zolfo, si veste in maniera decente e borghese, assume i toni compiti dell’uomo di mondo, e sia pure del parassita di professione: una figura sociale abbastanza caratteristica della Russia di fine Ottocento, dove molti nobili e proprietari terrieri tenevano alla loro tavola una o più di codeste figure di commensali a sbafo, di ospiti fissi, quasi di cortigiani, così, per passatempo, per ammazzare la noia delle lunghe serate in campagna, specialmente d’inverno, quando mancavano le altre distrazioni — la caccia, i giochi di società all’aperto. Poteva essere un parente povero, o un giovane studente, o un attempato pseudo intellettuale con un grande avvenire dietro le spalle; comunque era presente quasi ovunque, ravvivava la conversazione, metteva a giorno le signore sulle ultime novità della moda di Parigi, scherzava, teneva allegri gli altri, facendo un po’ il buffone; ed era sempre disponibile per completare il tavolo di una partita a carte. Per i possidenti russi afflitti dal male nazionale della chandrà (quel misto di noia e di accidia così ben descritto da Puškin, e ribattezzato da Gončarov oblomovismo) era quasi una necessità vitale disporre d’un tale parassita. Ed ecco il lampo di genio di Dostoevskij: l’uomo moderno, rimasto orfano di Dio, si annoia mortalmente, ha bisogno di diversivi: e chi più idoneo a riempire il vuoto, dell’antico Avversario, il camaleonte dai mille volti, che sa intrufolarsi così bene nelle case in preda alla noia e alla malinconia? Più che un nemico aggressivo e minaccioso, il diavolo si presenta all’uomo moderno in vesti dimesse, quotidiane, e si offre come un ospite venuto a fugare la noia, a tenere un po’ di briosa compagnia: un ospite a volte un po’ seccante, ma , tutto sommato, del quale non si saprebbe fare a meno.
Parassita. Sì, è proprio la mia parte. Che cosa sono io sulla terra se non un parassita?, dice il diavolo ad Ivàn; ad Ivàn che, inconsapevolmente, lo ha evocato, con la sua filosofia incentrata sul concetto che, se Dio non esiste, allora tutto è permesso. L’uomo moderno, avendo creato il vuoto intorno a sé, e, soprattutto, dentro di sé, si messo nelle condizioni di essere parassitato da qualcosa, da qualcuno: ha socchiuso tutta una serie di porte che avrebbero dovuto rimanere chiuse e ben custodite. Lo spiritismo, per esempio. Dostoevskij ne parla, o meglio, ne fa parlare al diavolo, con lapidaria chiarezza: gli spiritisti credono di aver raggiunto, evocando i morti, le prove "materiali" della vita dopo la morte: ma sono solo dei poveri zimbelli nelle mani del diavolo. È il diavolo che parla con loro, li circuisce, li illude: essi credono di parlare con i loro cari defunti, e invece si sono messi in comunicazione con l’inferno. È la pena del contrappasso per una civiltà che non crede più se non a quello che vede, o che crede di vedere, accecata com’è dai suoi pregiudizi scientisti; che pretende le prove scientifiche dell’esistenza di Dio e dell’aldilà.
ÈEd ecco l0inizio dell’episodio in cui Ivàn Karamazov, alla vigilia della deposizione decisiva che intende fare al processo del suo fratellastro Dimitrij – quando rivelerà davanti alla corte la responsabilità materiale di Smerdjakov nell’assassinio del padre, e se ne assumerà, se necessario, la paternità morale, per quanto involontaria e inconsapevole – ha un faccia a faccia con il diavolo, in casa sua, mentre è in preda alla febbre cerebrale.
Ne riportiamo un passaggio centrale (Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, Pare quarta, Libro XI, cap. 11; traduzione di Giacinta Dominicis Jorio, Edizioni San Paolo, 1995, pp. 1003-1007):
Ivàn Fedorovic taceva accigliato, non parlava e non voleva essere il primo a iniziare un discorso. L’ospite aspettava precisamente come un buon parassita che, sceso appena dalla camera assegnatagli per prendere il tè in compagnia del padrone di casa, se ne sta zitto e quieto nel vedere quest’ultimo assorto e accigliato, sempre pronto però a qualsiasi cortese conversazione, non appena l’altro dimostri di voler iniziare. Il suo viso, a un tratto, espresse una improvvisa inquietudine.
"Ascolta", incomincò, rivolgendosi a Ivàn Fedorovic, "e scusami, ma lo dico solo per ricordartelo: tu sei andato da Smerdjakov per informarti sul conto di Katerina Ivanovna, ma sei venuto via senza saper nulla. Certo te ne sei dimenticato…
"Ah, sì", esclamò di scatto Ivàn e il suo viso si abbuiò; "sì, me ne sono dimenticato. Del resto, ormai non importa, tutto rimandato a domani", mormorò tra sé. "Tu, però… "e si rivolse all’ospite in tono irritato "questa cosa me la devo essere ricordata proprio poco fa; per questo mi sentivo oppresso e agitato. Pensi che, siccome sei saltato su a dirmelo tu dovrò credere che sei stato tu a suggerirmelo, e non io a ricordarmelo?"
"E tu non crederlo!", rispose quel signore con un affabile sorriso. "Che importanza ha la fede ottenuta per forza? E poi, in fatto di fede, non ci sono prove che servano, specie quelle materiali. Tommaso credette non perché aveva visto Cristo risorto, ma perché già prima desiderava credere. Così, per esempio, gli spiritisti… A me piacciono molitissimo… Figurati che credono di servire la fede perché i diavoli mostrano loro le corna dell’altro mondo. È già una prova materiale che esiste un altro mondo", dicono. L’altro mondo e le prove materiali, ah, che gente! Infine, anche se p provata l’esistenza del diavolo, è forse certo che sia provata quella di Dio? Io voglio iscrivermi a una società di idealisti e poi far loro opposizione: Sono realista, dirò, non materialista, ah, ah!"
"Ascolta" e Ivàn Fedorovic si alzò di colpo, allontanandosi dalla tavola — mi sembra di avere il delirio… sì, certo ho il delirio… Puoi raccontarmi quante storie vuoi, non me ne importa niente! Tu non mi porterai all’esasperazione come la volta scorsa. Provo solo vergogna… non so di che cosa… Voglio passeggiare per la stanza… In qualche momento non ti vedo e non odo neppure la tua voce, ma indovino sempre quello che stai blaterando perché SONO IO STESSO CHE PARLO, E NON TU! Non so però se l’ultima volta dormivo o se ti ho veduto da sveglio. Ecco, ora inzuppo di acqua fredda un asciugamano e me lo applico sulla testa, e forse tu sparirai".
Ivàn Fedorovic andò in un angolo, prese un asciugamano, fece quello che aveva detto e poi, con il panno agnato sul capo, cominciò ad andare avanti e indietro per la stanza.
"Mi fa piacere che ci siamo dati subito del tu", ricominciò l’ospite.
"Imbecille!" scoppiò a ridere Ivàn; "vuoi forse che ti dia del voi? Ora sono di buon umore, mi dolgono solo le tempie… e la sommità del capo… Ti prego, però, di non ricominciare a filosofeggiare come l’altra volta. Se proprio non puoi alzare i tacchi, inventa almeno qualcosa di allegro. Spettegola, da quel parassita che sei, spettegola pure! È un bell’incubo che incomincia! Ma io non ti temo. Sarò più forte di te. Non mi porteranno al manicomio!
"C’est charmant, parassita. Sì, è proprio la mia parte. Che cosa sono io sulla terra se non un parassita? A proposito, io ti ascolto e sono un po’ sorpreso: in verità sembra che a poco a poco tu cominci a considerarmi qualcosa di reale e non solo una tua fantasia, come insistevi l’atra volta.."
"Nemmeno per un attimo ti considero una realtà" gridò Ivàn, addirittura rabbioso. "Tu sei una menzogna, sei la mia malattia, sei un fantasma. Però non so come distruggerti, e capisco che per un po’ di tempo dovrò soffrire. Tu sei una mia allucinazione. Sei un’incarnazione di me stesso, ma solo di una parte di me… dei miei pensieri, e sentimenti, ma di quelli più vili e più stupidi. Da questo lato potresti persino riuscire a interessarmi, se avessi del tempo da perdere con te…".
"Permetti, permetti, io ti smentirò: poco fa, accanto al lampione, ti sei slanciato su Alësa gridandogli: L’hai saputo DA LUI! Come mai hai saputo che EGLI viene a trovarmi? Alludevi certamente a me. Per un brevissimo istante hai dunque creduto che io esista davvero" e il signore rise con garbo.
"Sì, è stata una debolezza della natura… ma non era possibile che ci credessi. Io non so se l’altra volta dormivo o camminavo. Forse ti ho visto solo in sogno, non da sveglio…"
"Ma perché poco fa sei stato così duro con Alësa? È un ragazzo, e io ho dei torti verso di lui per via dello starec Zosima".
"Non parlare di Alësa! Come osi, lacché?" e Ivàn rise di nuovo.
"Mi insulti, ma ridi anche tu: buon segno. Del resto, oggi sei molto più gentile verso di meche la volta scorsa, e io ne capisco il motivo: è a causa di una rande decisione".
"Non parlare della mia decisione!" gridò Ivàn furioso.
"Capisco, capisco, c’est noble, c’est charmant, domani vai a difendere tuo fratello e a sacrificarti… c’est chevaleresque!"
"Taci, o ti piglio a calci!"
"Da un lato sarei contento, perché allora avrei raggiunto il mio scopo: se mi pigli a calci vuol dire che credi nella mia realtà., perché i fantasmi non si possono prendere a pedate. Scherzi a parte, per me fa lo stesso.: insultami pure, se vuoi, però faresti meglio a essere un pochino più cortese anche con me. Imbecille, lacché,… che razza di parole!"
"Insultando te, insulto me stesso!" e Ivàn rise di nuovo. "Tu sei me, me stesso, ma con un altro muso. Tu dici le stesse cose che io penso… e non sai dirmi nulla di nuovo!"
"Se i miei pensieri concordano con i tuoi, la cosa mi fa soltanto onore" disse il signore, con delicatezza e dignità.
"Però tu scegli i miei pensieri peggiori e, soprattutto, i più sciocchi. Sei stupido e volgare. Sei terribilmente stupido! Non ti sopporto! Che posso fare? Che posso fare? " e Ivàn strinse i denti.
Riassumendo. L’uomo moderno si annoia, ha un incolmabile vuoto interiore: e il diavolo si offre di riempirlo. Si avvicina in veste di parassita, quasi di amico; gli offre i suoi servigi per combattere la noia. È seducente, dialettico, astuto, ma senza strafare. Sa che basta gettare una piccola esca perché l’uomo abbocchi. Inoltre, è talmente abile che preferisce restare in bilico fra realtà e fantasia: non vuol provare all’uomo la sua esistenza; questi potrebbe avere degli scrupoli di coscienza a intrattenersi con lui. Si tiene nella zona grigia; adotta, come si dice, un basso profilo: tutti gli indizi della sua presenza, della sua opera, potrebbero trovare una spiegazione diversa, perfettamente razionale. Preferisce lasciare un margine di dubbio: che senso avrebbe una fede cui l’uomo sia costretto? E poi, per dominare meglio l’uomo, non è forse preferibile lasciargli un margine d’illusione su ciò che sta facendo? Sarà più facile conquistare la sua anima, se questi si rifiuta di credere in lui del tutto. Sarà come quando la moglie che tradisce il marito si auto-convince che, in fondo, non è stata lei a tradire, ma quell’altra, che abita in lei, e della quale non è responsabile, ci mancherebbe: non possiamo mica rispondere di tutto e di tutti, non è vero? Sarebbe una pretesa veramente eccessiva.
Eppure, a ben guardare, un indizio della sua presenza c’è; c’è un indizio che rende l’uomo consapevole dell’opera del diavolo, e gli ricorda che quell’ospite sgradevole, ma a suo modo utile, è stato veramente in casa sua, gli ha parlato, e qualcosa ne è venuto fuori, anche se poi la mente razionale ha rimosso ogni cosa. E l’indizio, che il finissimo Dostoevskij ha colto con magistrale precisione, è quel certo vago senso di vergogna, che, talvolta, in maniera apparentemente inspiegabile, assale l’uomo quando meno se lo aspetta. Egli sa di aver fatto qualcosa di vergognoso, e stenta a ricordare cosa. Però qualcosa c’è stato davvero: non è il senso di colpa del nevrotico, inafferrabile perché irrazionale; è la vergogna per qualcosa di reale, di positivo, che è accaduto realmente, anche se, forse, per il momento, solo al livello dei suoi pensieri.
Provo solo vergogna… non so di che cosa…, dice Ivàn a se stesso, tentando di ricordare, di capire. Qualcosa gli sfugge, qualcosa non torna. Ma che cosa?
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels