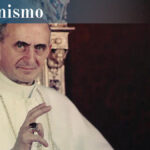
Ineffabili modernisti: se la dicono e se la godono
10 Febbraio 2017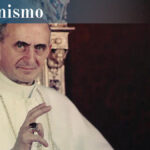
Il problema fondamentale della Chiesa, oggi, è il democraticismo
11 Febbraio 2017Gesù, durante l’Ultima Cena, dice a un certo punto ai suoi discepoli (Gv 13, 34-35): Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
E un poco più avanti (Gv 15, 9-14): Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando.
Queste sublimi parole, che sono il compendio di tutto il messaggio di Gesù agli uomini, sembrano di per sé tanto chiare ed evidenti, che chiunque, leggendole o ascoltandole, è portato a pensare che il loro significato sia univoco e intuitivo e non presenti la benché minima difficoltà; addirittura, ci si dimentica che qualsiasi discorso deve essere opportunamente contestualizzato, e ciò vale anche per queste parole di Cristo.
Orbene, il contesto è non solo solenne, ma drammatico: i discepoli sono attanagliati dall’angoscia e dalla paura, si aspettano da un momento all’altro quello che inevitabilmente dovrà accadere: che il Sinedrio di Gerusalemme decida la cattura e il processo a carico del loro Maestro. Ve ne sono state numerose avvisaglie; Gesù è sfuggito di poco a un primo arresto, mentre insegnava nel Tempio, e adesso, venendo a festeggiare la Pasqua nella Città Santa, e non nascondendosi affatto ai suoi nemici, è come se Gesù avesse firmato la propria condanna; al punto che Tommaso, mentre s’incamminavano verso Gerusalemme, aveva esclamato con trasporto ai suoi compagni (Gv 11, 16): Andiamo anche noi a morire con Lui!
Oltre a questo, Gesù si trova alle prese con la difficoltà di farsi capire dai suoi discepoli, i quali non hanno compreso la reale natura della sua missione, né in che senso Egli sia il Messia da loro e da tutti gli Ebrei così intensamente atteso: tanto è vero che, di lì a poco, davanti alla facilità con cui Egli verrà catturato, essi si sarebbero scandalizzati di lui e, dubitando d’essersi ingannati, lo avrebbero lasciato solo nel momento più difficile di tutta la sua vita. Molte altre cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non siete capaci di portarne il peso, dice loro Gesù (Gv 16, 12), promettendo loro, dopo che se ne sarà andato, di mandare ad essi lo Spirito Santo, per illuminarli su ciò che ora non potrebbero comprendere.
Quanto al tono generale di questi ultimi discorsi di Gesù ai suoi, veri e propri discorsi di commiato e suo testamento spirituale ai discepoli, il quadro teologico generale che li caratterizza e che fa da sfondo è quello di una dura, implacabile contrapposizione tra il "mondo", che ostinatamente e protervamente rifiuta la Verità del Cristo, e la Paola di Dio, che si manifesta nell’amore, ma che sgorga dalla Verità, garantita dalla stretta fedeltà di Gesù al mandato ricevuto dal Padre. Rivolgendosi al Padre nella sua preghiera per i dodici, infatti, o meglio, per gli undici — Giuda è già uscito per andare a denunciarlo – Gesù dice (Gv 17, 15-23): Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me.
Insomma: quando Gesù dice ai suoi discepoli: vi lascio un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, intende dire: vi lascio un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io, che sono la Verità, ho amato voi, e dunque secondo verità e non secondo il modo di giudicare del mondo. Non è un amore "qualsiasi", quello che Gesù raccomanda ai suoi discepoli, ma l’unico amore che sia giusto e vero al cento per cento: l’amore nella Verità da Lui insegnata. La cosa può sfuggire anche perché, subito dopo, Gesù dice che nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici, lasciando chiaramente intendere che Egli sta per offre la sua vita per la loro salvezza e per quella di tutti coloro i quali crederanno in Lui. La parola "amici" fa subito venire alla mente il concetto umano dell’amicizia; e, nell’amicizia umana, può esserci luogo anche all’errore, si può anche amare in modo sbagliato, oppure un oggetto sbagliato; e si può anche dare la vita per essi, ma, evidentemente, non è e non può essere questo il "comandamento nuovo" che Gesù ha affidato così solennemente ai suoi discepoli. Se lo chiama un "comandamento nuovo", vuol dire che non è l’amore umano, quello che raccomanda ai suoi come l’elemento distintivo del credente. Se per lui la cosa più importante fosse l’amore, in qualsiasi modo e forma (ad esempio, anche quello di Paolo e Francesca, di cui parla Dante Alighieri nel quinto canto dell’Inferno, che è un amore adultero), allora non sarebbe un comandamento nuovo, e, soprattutto, non sarebbe il compendio della dottrina di Cristo. No, non può essere un amore qualsiasi; non può essere anche un amore mal diretto, anche un amore mal riposto, disordinato, intrinsecamente sbagliato, quello di cui parla Gesù, e che viene innalzato a sintesi perfetta del suo Vangelo; ma solo e unicamente l’amore nella Verità.
Ed ecco, per fare un confronto, quel che dice Enzo Bianchi a proposito del comandamento nuovo" trasmesso da Gesù ai suoi discepoli durante l’Ultima Cena (da: E. Bianchi, Ascoltate il Figlio amato! Il Vangelo festivo, Edizioni San Paolo, 2008, pp. 84-85):
Sì: di tutti i comandamenti contenuti nella Scrittura, dopo la venuta di Gesù sulla terra, non ne resta che uno solo, il comandamento "nuovo" perché ultimo e definitivo! Se già secondo i vangeli sinottici Gesù aveva sintetizzato tutta la legge nell’unico comandamento dell’amore di Dio e del prossimo (cfr. Lc, 10,25-28); e Paolo aveva affermato che "tutta la Legge trova compimento in un’unica parola: amerai il prossimo tuo come te stesso" (Gal 5,14; cfr. Rm 13,8-10), Giovanni, il discepolo amato, va oltre e compie la sintesi decisiva. Nel quarto vangelo, infatti, il comandamento nuovo è in definitiva l’unico che Gesù ha ricevuto dal Padre e come tale, l’ha osservato fino all’estremo, fino a fornire un modello e una misura — "come io vi ho amati" — all’amore dei suoi discepoli, i cristiani, verso gli altri.
"Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati": ecco IL comandamento dei cristiani, l’unico che, se attuato in verità, consente di riconoscere i discepoli di Gesù (cfr. Gv 13,35); ecco la condizione in cui si fa esperienza del Dio invisibile e lo si contempla con gli occhi della fede, secondo le parole dello stesso Giovanni nella sua Prima lettera: "Dio nessuno l’ha mai visto, ma se se ci amiamo gli uni gli altri Dio dimora in noi e in noi il suo amore è giunto a pienezza" (1 Gv 4,12). Questo è il cristianesimo, non altro! E ogni volta che, per colpa di noi cristiani, il comandamento nuovo sbiadisce, perde la sua centralità e unicità, allora anche il cristianesimo smarrisce il suo carattere di vangelo, di buona notizia; anzi, può giungere fino ad assumere i tratti di una cattiva notizia, perché troppo carico di leggi e comandamenti, che gli uomini tendono sempre a moltiplicare e a rendere più pesanti.
In questa mezza pagina di prosa sono presenti alcuni spropositi teologici, insieme ad affermazioni quantomeno discutibili; ma, per non farla lunga, ci limiteremo a evidenziare i più grossi.
Primo: che Gesù chiami il comandamento dell’amore come "il comandamento nuovo" perché è l’ultimo e definitivo, non appare per niente convincente. Da quando in qua una cosa, che è già stata detta e ridetta, diventa "nuova", solo perché resta per ultima?
Secondo: che cosa autorizza l’autore ad affermare che Giovanni "va oltre" nell’interpretazione del comandamento di Gesù, e realizza, lui, l’apostolo, la sintesi definitiva? Questo modo di leggere i Vangeli (che noi, essendo all’antica, ma essendo anche amanti della buona grammatica, ci ostiniamo a scrivere con l’iniziale maiuscola), è più che azzardato, teologicamente non cattolico. Per i cattolici, gli evangelisti non hanno fatto nessuna operazione dogmatica sui Vangeli, tranne presentare ciò che hanno visto e udito; e tanto meno si sono permessi di "andare oltre". Oltre rispetto a chi, a che cosa? Giovanni sarebbe andato oltre i sinottici, oltre san Paolo? Speriamo non anche oltre Gesù Cristo… Eppure, si direbbe proprio di sì: perché nel quarto Vangelo non è Giovanni che parla a nome proprio, ma è l’evangelista che riferisce le parole e gli atti di Gesù. Non c’è nulla "oltre" cui andare, ma solo da meditare le parole del Maestro. Questo modo di procedere è tipicamente protestante: ciascuno si legge il suo brano di questo o quel Vangelo, e ciascuno lo interpreta come gli pare; non solo: ciascuno si industria ad attribuire a questo o quell’evangelista, a questo o quell’autore biblico, un proprio pensiero, una propria "sintesi" della Rivelazione. Ma quando mai? La Bibbia è la Parola di Dio, e la Parola di Dio è unica. Almeno per un cattolico. Enzo Bianchi è cattolico, facendo queste affermazioni?
Terzo: come si fa a dire che il comandamento "nuovo", quello del’amore, è l’unico che Gesù ha ricevuto dal Padre? Non ha ricevuto nient’altro? E allora, se ha detto qualcos’altro e insegnato anche dell’altro, lo ha fatto, per così dire (e ci si passi l’irriverenza) a titolo personale? Una simile idea non è cattolica, perché Gesù non è altro dal Padre, è la seconda Persona della Trinità, e dunque lo stesso Dio che è presente anche nel Padre, e che si effonde nello Spirito Santo. Gesù prega in questo modo il Padre, affidandogli i suoi apostoli, prima dell’addio (Gv 17, 6-11): Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. Dunque, la cosa più importante che Gesù ha fatto, a nome del Padre, è stata quella di far conoscere agli uomini il suo nome. Non, dunque, quella d’insegnar loro l’amore, genericamente e umanamente; ma d’insegnar loro il vero modo di amare Dio, che si manifesta, sì, e si riflette nell’amore al prossimo, ma che deve essere rivolto verso il vero e unico Dio, non verso altri dei, non verso altre immagini di dio, non verso altre fedi. E qui casca l’asino del dialogo interreligioso, e anche dell’ecumenismo, se li si intende come un "superamento" del cattolicesimo. Il cattolicesimo non può essere superato, perché è la Parola di Dio: e passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole non passeranno, dice il Signore.
Quarto: come i protestanti, si cita un certo passo del Nuovo Testamento e, staccandolo dal resto, lo s’interpreta a piacere. Il passo in questione è quello della prima lettera di Giovanni, che dice: Dio nessuno l’ha mai visto, ma se se ci amiamo gli uni gli altri Dio dimora in noi e in noi il suo amore è giunto a pienezza. Ma sempre Giovanni, nel quarto Vangelo (Gv 14, 8-11), riporta questo scambio di battute tra l’apostolo Filippo e Gesù, ugualmente durante l’Ultima Cena: Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse. Dunque, l’espressione: Dio, nessuno l’ha mai visto, adoperata da Giovanni nella Prima lettera, non va presa alla lettera: come Gesù stesso ha insegnato, aver visto Lui e aver visto il Padre è la stessa e identica cosa.
Quinto (e qui si vede perché Bianchi scrive sempre vangelo con la minuscola): dicendo che il vangelo, da buona novella, può diventare una cattiva notizia, se annunciato da cristiani indegni (pare che tutti i mali del mondo siano sempre e solo colpa dei cristiani; mai dei giudei, o dei musulmani, o degli atei, o dei massoni), egli degrada la Parola di Dio a semplice parola umana, che può perfino diventare "cattiva". Immensa confusione teologica: la Parola di Dio è la Parola di Dio, cioè perfetta, luminosa, infallibile e immutabile; il fatto che alcuni cristiani siano privi di amore (e chi è senza peccato, scagli la rima frecciata…), non può in alcun modo togliere il suo carattere di Lieto Annunzio, e tanto meno degradarlo ad annunzio di sventura. La condotta inadeguata dei cristiani non può potrebbe mai e poi mai svilire il carattere di verità e di assoluta perfezione, completezza e necessità del Vangelo di Gesù Cristo (con la maiuscola). Ma Bianchi, da buon semi-protestante, non ha presente il Vangelo, bensì i vangeli; e pensa che il fatto di essere annunziati da esseri umani, sia sufficiente a renderli veritieri o fasulli, benefici o malefici, a secondo della circostanze.
Per finire, e sesto, Enzo Bianchi poteva ben risparmiarsi, almeno per una volta, almeno mentre sta parlando dell’importanza fondamentale dell’amore, la sua solita, velenosa frecciata contro quei cristiani che, a suo dire, rendono poco credibile il cristianesimo, perché manchevoli di amore verso il prossimo. Sarebbe perfino troppo facile collezionare i passi degli interventi di Bianchi contro le sue bestie nere, i cattolici "tradizionalisti", dai quali traspare pochissimo amore, certo molto, ma molto meno di quanto non ne dimostri, e non ne proclami continuamente, verso i non cristiani. Ma il punto vero è un altro, e cioè che egli se la prende con un nemico inesistente, in maniera demagogica e perfino grottesca. Ci dica, ci mostri dove sono questi cristiani che "moltiplicano leggi e comandamenti", rendendoli sempre più pesanti. In che luogo e in quale secolo vive, il signor Bianchi? Forse nella Palestina di Anna, Caifa e dei farisei, sempre pronti a stracciarsi le vesti con somma ipocrisia? Oppure nella Spagna di Torquemada? A noi, in questo inizio del terzo millennio, non risulta proprio che il problema sia costituito, nel cristianesimo, da un eccesso di leggi e regolamenti; tutto il contrario: semmai, da un eccesso di anarchia e d’improvvisazione, di estemporanee interpretazioni del vangelo secondo me.
In conclusione: al cristiano è sufficiente il fatto di amare? Certamente no. È necessario amare così come Gesù ha amato i suoi, cioè con discernimento, con prudenza, con assoluta fedeltà alla Parola di Dio. L’indegnità di singoli cristiani, che non possiedono sufficiente amore, non toglie valore o verità al Vangelo. Viceversa, la generosità e l’ardore dell’amore di chi non possiede la verità del Vangelo, non basta a compensare il fatto che, fuori dalla Verità di Cristo, non c’è alcuna verità degna di questo nome…
Fonte dell'immagine in evidenza: Foto di Chad Greiter su Unsplash
