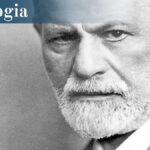
Cosa c’è dietro l’astio anti-Trump di Francesco
27 Gennaio 2017
Ecco perché l’Italia non è più uno Stato sovrano
28 Gennaio 2017Basta dare una scorsa distratta al giornale o ascoltare, altrettanto distrattamente, un telegiornale, per avere la conferma (fatta la tara al sensazionalismo di un sistema dell’informazione che vive enfatizzando i fatti di cronaca nera e gli scandali, dato che la notizia è stata completamente mercificata e quindi si vendono le notizie che suscitano orrore, spavento, disgusto, paura, e non le altre), del fatto che siamo afflitti da una perdita di senso morale, perdita che ormai dilaga ovunque e che è qualcosa di assai diverso dal libertinismo o dall’edonismo sfrenato, dall’utilitarismo selvaggio o dall’opportunismo calcolato, teorizzati da vari pensatori moderni, a cominciare da Machiavelli, nel corso degli ultimi cinque secoli (Il Principe ha compiuto e superato i 500 anni, essendo stato scritto nel 1513).
È qualcosa di diverso, infatti, nel senso che si tratta non di una anti-morale, ma di una assenza di morale; non di una opposizione alla morale corrente, o tradizionale, ma di uno smarrimento, diciamo così, "naturale", del senso etico. Fino ad ora, nessuna società, e dunque neanche la nostra, aveva mai potuto vivere senza un sistema di norme morali, e senza impegnarsi a trasmetterlo ai suoi figli, e a farlo rispettare dagli eventuali trasgressori; mentre, nel corso della modernità, è come se la nostra società — quella che suole dirsi occidentale – si fosse gradualmente sbarazzata della morale, più o meno come, all’arrivo della primavera, ci si sbarazza degli indumenti invernali e si fa a meno del cappotto, del maglione, dei guanti, delle scarpe pesanti: non senza scoprire, proprio come nell’esempio in questione, che la cosa è molto piacevole, e non senza meravigliarsi di come si potesse, prima, sopportare una condizione così "sacrificata".
L’uomo moderno, pertanto, si è sbarazzato della morale, così come ci si sbarazza di qualcosa che non serve più, che non ha ormai ragione di essere, e che, se venisse conservato, causerebbe fastidio, disagio, insofferenza; come qualcosa che è stato utile in passato, ma che adesso deve sparire, perché ha perso ogni funzione e ogni significato. La cosa è avvenuta non solo senza che l’intellighenzia lanciasse l’allarme, senza che un solo intellettuale, fra quelli più quotati e più ascoltati, dicesse a voce alta: Ehi, ragazzi, ma che diavolo state facendo? La nostra società non può vivere senza una morale; nessuna società può sopravvivere senza di essa: ne va, quindi, della nostra sopravvivenza!; ma, addirittura, con la volonterosa, meglio, della entusiastica partecipazione dell’intellighenzia. Gli scrittori, i poeti, gli artisti, i musicisti, i registi cinematografici e teatrali, hanno fatto a gara nel denigrare la "vecchia" morale e nell’esaltare non già una nuova morale, ma l’abbandono e il rifiuto – a livello pratico, se non teorico – di qualsiasi morale; e parecchi pensatori, o sedicenti tali, hanno benedetto e sancito la pena legittimità di tale scriteriata operazione: basta vedere l’atteggiamento di gran parte dei "nuovi filosofi" spuntati come funghi dopo la pioggia all’ombra della rive gauche parigina (ed europea, anzi, mondiale) nel 1968 e dintorni. Tutto quel che hanno saputo fare costoro è stato di lanciare quantità industriale d’immondizia contro la morale dei loro padri (nonché contro i loro padri stessi) e contro qualsiasi morale, in nome della vita, o della giovinezza, o della libertà, o altri slogan fasulli e pazzamente demagogici di tal genere.
Ebbene, c’è stato almeno un pensatore europeo che vide questa deriva per tempo e che la denunciò, benché il suo libro, notissimo e citatissimo, anche nelle aule universitarie, non abbia stimolato alcuna seria riflessione: lo spagnolo Ortega y Gasset. Troppo forte era l’ubriacatura nichilista e troppo impopolare sarebbe stato proporre alle "masse" un cambiamento di rotta.
La ribellione delle masse, il famoso saggio di José Ortega y Gasset, venne pubblicato nel 1930, ma, in essa, il filosofo spagnolo condensò alcun aspetti essenziali del suo pensiero, elaborati nel corso di un ampio arco do tempo (nato a Madrid nel 1883, si era laureato nel 1902 con una tesi su I terrori dell’anno Mille. Critica di una leggenda; e si sarebbe poi spento nel 1955, dopo un intermezzo in esilio volontario, per non partecipare alla guerra civile spagnola). Si può dunque affermare che le tesi contenute ne La rebelión de las masas sono il risultato di una riflessione che risale a circa un secolo fa; ed è interessante constatare quanto poco siano cambiate le cose rispetto all’analisi che in quel libro viene tracciata della civiltà europea. Semmai, le cose sono cambiate in peggio, e di molto; ma, quanto al problema essenziale che Ortega y Gasset poneva sul tappeto, non c’è stata alcuna risposta, e perfino alcun tentativo di risposta: la cultura europea non ha saputo mettere in cantiere nulla, assolutamente nulla, che rispondesse al quesito: dove andrà a finire una società che ha perso per strada ogni senso morale?
Al termine del suo saggio, infatti, il pensatore spagnolo concludeva con queste taglienti, ma realistiche osservazioni (da: José Ortega y Gasset, La ribellione delle masse; traduzione dallo spagnolo di Salvatore Battaglia, Bologna, Il Mulino, 1962, e Roma, La biblioteca di Libero, 2003, pp. 152-154):
Questo è il problema: l’Europa è rimasta senza morale. Non è che l’uomo-massa disprezzi la morale antiquatta a vantaggio di un’altra che s’annunzia, ma è che il centro del suo regime vitale consiste precisamente nell’aspirazione a vivere senza sottoporsi a nessuna morale. Non è da prestar fede a nessuna parola quando si sentono parlare i giovani di "nuova morale". Nego recisamente che esista oggi in qualunque angolo del continente un qualsiasi gruppo informato da un nuovo "ethos" che abbia sembianze d’una morale. Quando si parla di "nuova morale", non si fa altro che commettere una immoralità di più e tentare il mezzo più comodo per compiere un contrabbando.
Per questa ragione sarebbe un’ingenuità rinfacciare all’uomo d’oggi la sua carenza di moralità. L’imputazione lo lascerebbe senza disagio e, anzi, lo lusingherebbe. L’immoralismo è arrivato a un prezzo molto basso, e chiunque ostenta di esercitarlo.
Se mettiamo da parte […] tutti i gruppi che significano sopravvivenza del passato — i cristiani, gli "idealisti", i vecchi liberali, ecc. — non si troverà fra tutti quelli che rappresentano l’epoca attuale uno solo la cui attitudine dinanzi alla vita non si riduca a credere che gli spettino tutti i diritti e nessun obbligo. È indifferente che si mascheri di reazionario o di rivoluzionario: per modi attivi o per vie passive, alla fine, il suo stato d’animo consisterà, in maniera decisiva, nell’ignorare ogni obbligo e nel sentirsi, senza che egli stesso sospetti perché, soggetto di illimitati diritti. […]
Perciò, non bisogna nobilitare la crisi attuale considerandola come il conflitto fra due moralità o civiltà, l’una caduca e l’altra albeggiante. L’uomo massa manca semplicemente di morale, che è sempre, per essenza, sentimento di sottomissione a qualcosa, coscienza di osservanza e di obbligo. Però forse è un errore dire "semplicemente". Perché non si tratta soltanto del distacco di questo tipo di creatura dalla morale. No: non rendiamogli così facile la sua fatica. Dalla morale non è possibile affrancarsi senz’altro. Ciò che con un vocabolo perfino difettoso dal lato grammaticale, si chiama "amoralità" è una cosa che non esiste. Se non ci si vuole affidare ad alcuna orma, bisogna pure, si voglia o no, sottostare alla forma di negare ogni morale: e ciò non è amorale, ma immorale. È una morale negativa che conserva dell’altra la forma vita.
Come si è potuto credere nella "amoralità" della vita? Senza, dubbio, perché ogni cultura e la civiltà moderna conducono a questa convinzione. Adesso l’Europa raccoglie le penose conseguenze della sua condotta spirituale. Si è gettata senza riserve nella direzione d’una cultura magnifica ma sprovvista di radici.
C’è stato, recentemente, un filosofo, compatriota di Ortega y Gasset, il quale ha avuto l’ardire di proporre un nuovo sistema di morale pratica, ispirato ai "valori" della modernità; una morale, ovviamente, interamente laica e razionale: Fernando Savater, del quale abbiamo altra volta parlato (cfr. il nostro articolo L’etica atea di Fernando Savater non è che una mescolanza di stoicismo e cristianesimo, pubblicato sul sito di Arianna Editrice il 13/12/20112, e ripubblicato su Il Corriere delle Regioni il 14/12/2015). Ma si è trattato di un tentativo così fiacco e mediocre, così screditato in partenza, così inconsistente e quasi ridicolo, da rientrare, semmai, in quei conati che il buon Ortega y Gasset definiva come nuove forme d’immoralità, o, se si vuole, come dei nuovi tentativi di contrabbando. Perché la verità è che, dopo l’abbandono della morale tradizionale, che era, essenzialmente, la morale cristiana, niente è stato costruito al suo posto; e, anche se molto se ne è parlato e sproloquiato, niente si potrà mai fare, perché un sistema di morale non si costruisce in due o tre generazioni, e, soprattutto, non si costruisce sul nulla: e la basi della civiltà moderna sono il nulla, ossia il nichilismo più radicale.
In effetti, le cose sono arrivate a un puto tale che l’uomo moderno sembra aver perso non solo ogni residuo di morale (ci vorrebbero un carabiniere e un giudice per sorvegliare ogni cittadino; ma chi sorveglierebbe il carabiniere e il giudice?), ma perfino gli organi per percepire la morale, proprio come un cieco dalla nascita che non sa cosa sia il vedere, o un sordo dalla nascita che ignora che cosa siano i suoni. Un numero sempre più grande di persone mentono, tradiscono, calunniano, truffano, rubano, rapinano, stuprano, feriscono e uccidono, senza quasi provare emozioni, e quindi senza provare rimorso. È diventato un mestiere durissimo, oggi, quello del magistrato inquirente: a differenza di un tempo, il reo non è soggetto ad alcun rimorso, e la sua unica preoccupazione è quella di scansare le conseguenze delle sue azioni; azioni che sa benissimo di aver compiuto (altro che incapace d’intendere e di volere, come troppo spesso dicono gi avvocati difensori dei peggiori criminali), sapendo benissimo che erano illecite, ma per le quali non prova alcuna vergogna e alcun disagio, anzi, sarebbe pronto a compierle di nuovo. I tempi di Delitto e castigo sembrano appartenere a una lontanissima preistoria; e il commissario Maigret, oggi, molto probabilmente, chiederebbe il pensionamento anticipato. Come si fa a ristabilire la giustizia, in un mondo dal quale è stata bandita l’esistenza del male?
Parliamoci chiaro: un sistema etico presuppone l’esistenza del bene e del male (e dunque rifiuta qualunque naturalismo), nonché la capacità, da parte dell’uomo, di riconoscere, e pertanto distinguere, l’uno dall’altro. Però del male, ormai, non si parla più; ha smesso di parlarne la società civile; ha quasi smesso di parlarne anche la Chiesa cattolica. L’una non parla più del reato, l’altra non parla più del peccato. Pare che solo il bene abbia ormai cittadinanza; e, naturalmente, i diritti, questo nuovo idolo laico, sempre più esigente e sempre più insaziabile. Ma questa è una menzogna, perché, se ci fosse solo il bene, vorrebbe dire che la società è formata solamente da angeli: il che è manifestamente falso.
A questa situazione siamo arrivati per gradi, ma con una coerenza costante. Del resto, ciò era inevitabile, da quando la nostra civiltà ha deciso di gettarsi Dio dietro le spalle, fra i ricordi del passato, e di andare avanti da sola, basando ogni cosa sulle sole capacità dell’uomo. La cultura dei diritti esagerati ha fatto il resto: ogni serio progetto educativo è stato abbandonato, e ai bambini è stato fatto credere che va bene qualsiasi comportamento, che tutto è permesso, che si può fare qualsiasi cosa, senza doverne poi rispondere (cfr. i nostri precedenti articoli: Parliamo ai giovani di mille cose superflue, ma non parliamo più loro del Bene e del Male, pubblicato sul sito di Arianna Editrice il 15/10/2008; e Abbiamo smarrito il senso del bene e del male, del vero e del falso, del giusto e dell’ingiusto, pubblicato sul Il Corriere delle Regioni il 22/02/2016). Non avremmo perciò alcun diritto di lamentarci delle conseguenze disastrose di questa anti-pedagogia e di questa contro-educazione, perché abbiamo fatto tutto con le nostre mani.
Il problema è che nella società di massa la persona tende a disgregarsi, a scomparire, a evaporare, per sciogliersi, appunto, nella massa: e la massa, per definizione, è priva di etica, è amorale. Per ristabilire la morale a livello sociale, bisognerebbe realizzare il processo inverso a quello che ha condotto alla nascita della società di massa: riportare le persone ad essere se stesse, farle uscire dalla massa e restituirle alla loro individualità: perché solo dove c’è individualità, c’è anche responsabilità. La massa non è responsabile di quel che fa, perché la massa non ha un nome, non ha un volto, non ha uno stato civile, e tanto meno un indirizzo. È formata da tutti e da nessuno. Dunque, non è nemmeno punibile: è giuridicamente irresponsabile dei propri atti, nel senso tecnico dell’espressione, come lo erano, secoli addietro, i sovrani per diritto divino: un bel paradosso, sul quale gli adoratori acritici della democrazia dovrebbero riflettere a lungo. Così come dovrebbero riflettere sul fatto che i peggiori crimini della storia umana sono stati perpetrato nella modernità, da parte di società che avevano deciso di crearsi una nuova etica: quella giacobina, che benedisse il genocidio del popolo della Vandea; quella comunista, con gli stermini staliniani; quella nazista, con il genocidio delle razze "inferiori"; e quella democratica, con i vari genocidi dei quali non si parla mai, alcuni dei quali in corso, a cominciare da quello dei nascituri, perfettamente legalizzato con le leggi sulla interruzione volontaria della gravidanza, presentate come la realizzazione di un diritto sacrosanto della donna a disporre pienamente di se stessa.
La verità è che l’unico sistema di morale che abbia dimostrato di saper resistere alla sfida dei secoli e delle trasformazioni sociali, è quello cristiano; ma ad esso abbiamo voltato deliberatamente le spalle. Avremo il coraggio e l’onestà di rendercene conto e di tornare sui nostri passi, prima di essere travolti dalle forze distruttive da noi stessi scatenate in nome del’umanismo?
Quanto all’ultima osservazione di Ortega y Gasset, e cioè che la "perdita" della morale corrisponde, in concreto, e sia pure inconsapevolmente, alla adozione di una "contro-morale", questo suggerisce al credente uno spunto di riflessione estremamente serio, per non dire drammatico. Il filosofo spagnolo sostiene che le società umane non possono rimanere neutre di fronte alla morale: se non scelgono una morale, cioè un principio di distinzione del bene e del male, e quindi l’adozione del punto di vista del bene, allora, necessariamente, scelgono il male. Questa, in termini religiosi, sarebbe la vittoria definitiva del diavolo: e, di questi tempi, se ne scorgono numerosi indizi, tali che perfino una mente perfettamente laica, ma che sia onesta dal punto di vista intellettuale, non può non essersene resa conto anch’essa. L’avventura della civiltà moderna è destinata dunque a concludere la sua parabola nelle braccia del diavolo?
Ciascuno è libero di trarre le proprie conclusioni. A colui che possiede uno spirito religioso resta una sola cosa da fare, dopo tante celebrazioni dell’attivismo e del volontarismo umano: pregare, pregare sempre, come raccomandava il Maestro, senza stancarsi mai…
Fonte dell'immagine in evidenza: Wikipedia - Pubblico dominio
