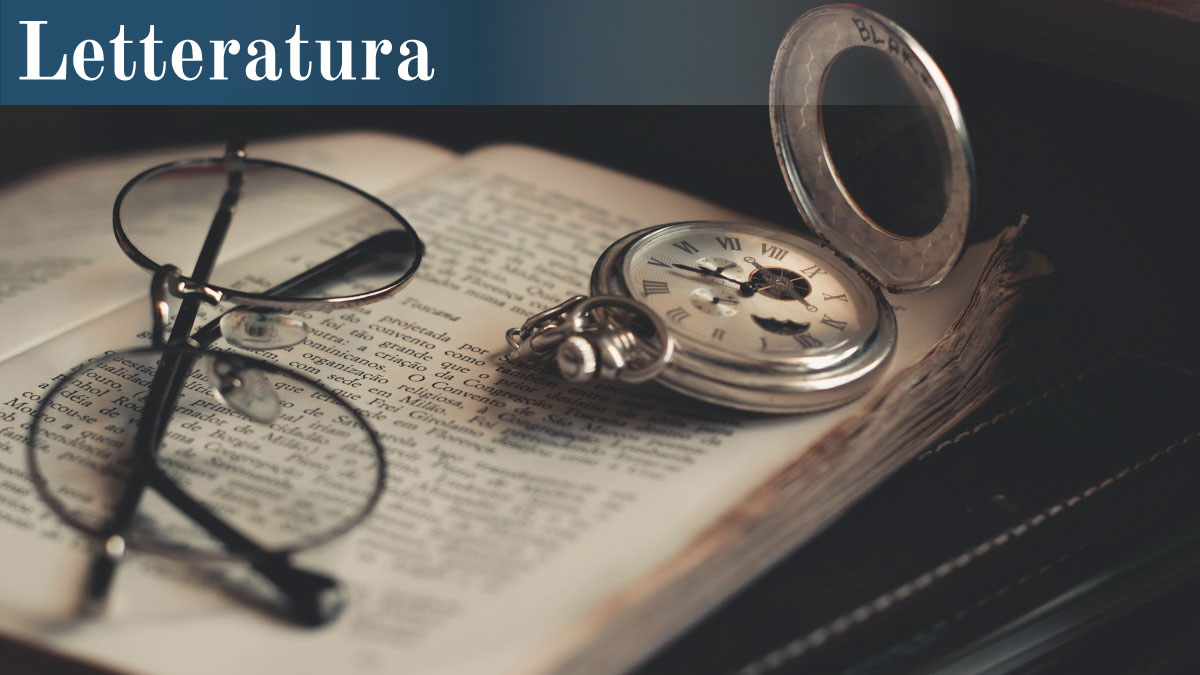«L’invisibile corsa di animali vaganti, l’urlo selvaggio
31 Ottobre 2016
Una società che non sia fondata sulla giustizia è come un castello costruito sulla sabbia
1 Novembre 2016Ogni bosco ha una sua particolare atmosfera, una sua specifica tonalità, una sua voce, o perfino un silenzio, assolutamente inconfondibili.
L’uomo di città, l’uomo moderno che non ha mai vissuto a contatto con la natura, e che, anche se entra in contatto con essa, lo fa per mezzo di troppi strumenti artificiali, e, quel che è peggio, foderato di troppe intercapedini mentali, tanto che ben poco vede, ode e comprende, di ciò che gli sta dinanzi, non riesce, forse, nemmeno a immaginare che un bosco non sia uguale ad un altro, neppure se si tratta di un bosco popolato dalle stesse specie arboree, e neppure se due boschi si trovano a breve distanza l’uno dall’altro. In realtà, ogni bosco ha una sua fisionomia particolare, inconfondibile; specialmente se si tratta di boschi primevi, cioè di foreste vergini, o, in ogni caso, di boschi piuttosto antichi, nei quali non si riconosca più tanto, o non si riconosca affatto, la mano ordinatrice dell’uomo, ma nei quali si respiri ancora l’alito possente della natura, così com’era quando essi ancora non conoscevano impronta di piede umano, né mai erano stati visti e percorsi da creature intelligenti.
Ebbene: chi, dotato di un minimo d’esperienza e di un certo gradi sensibilità e fantasia, si addentri in un bosco antico, allontanandosi dai sentieri e dai segni della presenza umana, là dove i boscaioli hanno aperto dei varchi nella barriera di tronchi, o dove le tracce delle ruote dei trattori o dei fuoristrada sono rimaste impresse nel terreno molle dopo la pioggia, e si lasci, per così dire, prendere per mano e condurre dal senso dell’avventura e dall’istinto della libertà, a patto che liberi la mente dai pensieri quotidiani, e dai riflessi condizionati e dai ricordi della vita cittadina, si troverà come proiettato, in men che non si dica, letteralmente in un altro mondo, anzi, addirittura in un’altra dimensione, della quale non aveva neanche sospettato l’esistenza, pur se, mano a mano che i sensi si adeguano a quel nuovo paesaggio e si familiarizzano con quelle nuove impressioni, in qualche strana maniera egli si rende conti di aver sempre saputo, di aver sempre sospettato l’esistenza di quella dimensione, che non si trova realmente al di fuori di lui, ma che giaceva semi-assopita proprio nelle profondità dell’animo suo.
In altre parole, esiste, fin dai primordi, una silenziosa e misteriosa empatia, anzi, di più, una sorta di alleanza, se non di vera e propria simbiosi, fra l’anima dell’uomo e l’anima del bosco: perché anche un’antica selva, crediamo, possiede, a suo modo, un’anima; non nel senso propriamente teologico della parola, senza dubbio, e nondimeno in un senso profondo, e non puramente simbolico: una specie di vita intima e nascosta, che è qualcosa di più della semplice somma aritmetica delle funzioni vitali delle singole piante che la compongono, e dei singoli animali che vi abitano; qualche cosa d’inesprimibile a parole, perché non vi sono concetti razionali capaci di afferrarla in tutta la sua estensione e la sua profondità, e tuttavia indubitabilmente, inequivocabilmente viva e presente, così come la si può percepire non appena si penetri un poco al suo interno e ci si lasci afferrare dal suo fascino primordiale — beninteso, dopo essersi spogliati dai gingilli della tecnologia: radioline, computer e telefonini, ma spogliati anche, e soprattutto, del modo di pensare, materialista ed utilitaristico, tipico della vita moderna. Non tutti, forse, sono in grado di farlo: in alcune persone, i ritmi e le abitudini della vita moderna sono penetrati così a fondo, che non se ne possono più spogliare — e, del resto, non ne provano alcun desiderio.
Ecco un brano dell’ottimo Daniello Bartoli (Ferrara, 1608- Roma, 1685), Selva antica, che rievoca queste arcane sensazioni in maniera, come al solito, straordinariamente viva ed efficace (da: Daniello. Bartoli, Dei simboli trasportati al morale, ed. di Bologna, 1677, pp. 573-574; cit. in: Fausto Montanari-Mario Puppo, Antologia della letteratura italiana, Torino, Società Editrice Internazionale, 1967, vol. II, pp. 405-406):
Evvi mai venuto in talento di darvi a trasportare dalla curiosità, o dal diletto, per entro una selva; e a guisa di smarrito, entrar passo passo d’uno errore in un altro, avvolgendovi per essa come per un laberinto, fino a venir dov’ella, nel suo più intimo e più segreto, è parimente più orrida, più solitaria, più oscura, più densa? Dico là, dove non giugnendo a farsi sentire né taglio di scure, né violenza di turbine che vi possa, vi si vive da quelle piante in pace fino all’ultima decrepita de’ quattro e de’ cinquecento anni. Que’ gran corpi d’albero selvaggi e robusti, e que’ loro gran rami, che sono ciascun da sé un intero e grande albero, e tutti insieme fanno una selva in aria, piantata sopra un medesimo tronco: e di quegli stessi tronchi i più vecchissimi, smidollati e cavernosi: e quelle ombre sopra ombre, d’alberi sopra alberi: e quella luce, mezza tra viva e morta, che v’è fatta non dal giorno che non vi nasce, non dal sole che non vi penetra, ma da un non sapete qual misto d’infiniti riverberi senza niuno primo lune da cui si veggono cominciati: e finalmente, quell’eterno silenzio, quel’eterna solitudine, quel maestoso orrore; non v’avran riempito l’animo d’ammirazione, di stupore, d’un non so che simile a riverenza? Quanto si è a noi (dirà Plinio, scrivendone come idolatro): non magis auro fulgentia atque ebore simulacra, quam lucos, et in silentia ipsa adoramus [non adoriamo le statue splendenti di oro ed avorio più dei boschi e in essi gli stessi silenzi: Pl., Nat. Hist., 1, XII, cap. I].
I boschetti di piante o sterili e sempre vive, o fruttifere e di bello aspetto, piantati a mano e ad arte, con gli alberi interzati, con lunghi e diritti viali per entro, con ombre per tutto chiare e dolci, cagionano diletto al vederli, e al passeggiarli, e vi si diporta cantando. Ma in una tal selva si riman tutto immobile, rimirando e tacendo; e sì dilettevole è quell’innocente orrore ch’ella mette, che tutta l’anima sembra adunarsi in se stessa al goderne. Gli antichi dunque credevano esservi una, diremo così, rustica divinità.
Meraviglioso, straordinario scrittore, il padre Bartoli, anche se non è mancato e non manca – fra i critici moderni, ovviamente — chi vorrebbe quasi negargli la qualifica di autentico scrittore, riducendolo al livello d’un semplice mestierante, o, addirittura, a quello di un giocoliere della parola, ma di una parola vuota di contenuto e sprovvista di qualsiasi profondità interiore. Che sciocchezza! Parla così colui che, sprofondato sino al collo nei suoi pregiudizi razionalisti e positivisti, ma, nondimeno (anzi, appunto per questo!), ritenendosi la persona più libera che vi sia mai stata al mondo nei confronti di qualunque pregiudizio — perché così vuole il vangelo della modernità, laica e tollerante, si capisce, ma sempre a senso unico — non arriva neppure a sospettare che vi sia un’altra forma di conoscenza, diversa da quella scientifico-matematica, e che esistano altre maniere di sentire e di scoprire la realtà, che non seguono le vie del Logos strumentale e calcolante. Tuttavia, ciò detto, non indugiamo oltre su questo terreno e rimandiamo ad altra occasione una più ampia contestazione dei detrattori di Daniello Bartoli come scrittore — del resto, un certo Giacomo Leopardi lo teneva in altissima stima, e tanto crediamo che possa già bastare — e ritorniamo al fascino arcano di un antico bosco.
Fascino indefinibile, abbiamo detto: fascino che non tutti arrivano a percepire, ma che, quando lo si percepisce, se ne rimane incantati, estasiati, e come trasportati improvvisamente fuori dal tempo e dallo spazio ordinari. Inutile dire che esso aumenta a dismisura se si tratta, per caso, di una escursione notturna: in tal caso, le ombre, i silenzi, la stessa qualità dell’aria, assumono una intensità differente, che non ha nulla a che vedere con ciò di cui si può fare esperienza alla luce del giorno, per quanto flebile questa possa apparire a causa del cielo nuvoloso o della densità dei tronchi e del fogliame. Allora, anche l’improvviso sbattere d’ali di un barbagianni, anche il semplice stormire delle fronde alla brezza notturna, evocano immediatamente emozioni intense e indescrivibili, che attingono agli strati più sommersi della nostra vita interiore e che ci riportano alle memorie confuse dell’inconscio collettivo, allorché, in balia di forze naturali tanto più possenti di loro, i nostri progenitori guardavamo allo spettacolo del mondo con un animo infinitamente più umile e disposto allo stupore, di quel che non accadrebbe, oggi, al bambino più ingenuo e propenso a fantasticare.
Benché siano quasi tutti solenni, e, in un certo senso, augusti, pure vi sono dei boschi dall’aspetto relativamente gaio, o sereno, ed altri dai quali, invece, promana una indefinibile tristezza, una atmosfera che intimidisce; e ciò non dipende solo dal tipo di specie vegetali che lo costituiscono, o dalla struttura del paesaggio — di pianura, di collina, di montagna — ma anche da qualcos’altro, più sottile e più arduo da riconoscere e definire. Può essere l’età delle piante: quelle più antiche tendono ad assumere proporzioni imponenti, ma anche a contorcersi, a piegarsi, e infine a rovinare al suolo, scoprendo le radici; può essere la presenza, o l’assenza, di specie epifite, di liane, di rampicanti, di edera selvatica, di muschi, di licheni sparsi sui tronchi; può essere la natura del sottobosco, "pulito", tranne il tappeto di foglie morte, come nelle faggete, oppure arduo, intricato, quasi impenetrabile, simile ad un groviglio labirintico di cespugli, di arboscelli, di erbacce, di ortiche, di felci, di equiseti dalle proporzioni insolitamente sviluppate. Oppure può trattarsi della presenza, o dell’assenza, di animali, specialmente di uccelli, con i loro rumori ed i loro versi caratteristici, che il bravo ornitologo non fatica a riconoscere, uno per uno. Perché vi sono boschi ove s’intuisce una fitta presenza di animali, di caprioli, di scoiattoli, di tassi, d’insetti; e altri nei quali sembra regnare uno strano, irreale silenzio, e non si vede volare neppure un moscerino, neppure una libellula, e non si ode il richiamo d’un uccello, né si riconosce, sul terreno, l’impronta d’uno zoccolo, come se quel luogo fosse stato silenziosamente e misteriosamente abbandonato da tutti i suoi abitanti alati, nonché da quelli a due o a quattro zampe.
Le sensazioni che si provano in un antico bosco dipendono, poi, in gran parte, dall’ora del giorno e dalle condizioni atmosferiche, oltre che dalla stagione. Un bosco in primavera fa un effetto ben diverso dal medesimo bosco, allorché vi si penetra in autunno; e un bosco visto nella luce radente dell’alba non suscita le stesse emozioni di un bosco che incomincia a dileguare nelle ombre rosseggianti del tramonto. Quando l’aria è limpida e tersa, poi, l’effetto che fa un bosco è completamente diverso da quello che produce se vi è la presenza della nebbia: la nebbia è come un sudore vivo, che sgocciola sui tronchi e lungo il fogliame, e provoca un sottofondo di minuscoli tonfi, quando le gocce di umidità condensata cadono a terra. E che dire di un bosco che pare trattenga il respiro nell’ardore implacabile di una torrida estate, o di un bosco congelato nel ghiaccio del crudo inverno, magari in montagna, quando la galaverna ricopre i tronchi con il suo incredibile vestito scintillante, e nuvolette di vapore si solidificano in maniera sorprendente, non appena escono dalla bocca o dalle narici del solitario visitatore?
Eppure, per quanto possano variare le condizioni esterne, vi è una nota di fondo che è sempre la stessa, perché non trae origine dal paesaggio esteriore, ma dalle profondità dell’anima. Ed è questo l’aspetto più prezioso, più delicato e più inesprimibile che produce una escursione nel fitto di un’antica foresta: in un certo senso, è come ripercorrere all’indietro il viaggio dell’anima e ritrovare la strada di casa, della nostra vera dimora, che non è di questo mondo, ma di un altro. Il mistero più grande di tutti, infatti, non è mai nelle cose che sono fuori di noi, ma dentro noi stessi: è il mistero del nostro esserci, del nostro stupirci e del nostro interrogarci; è il mistero della nostra origine e del nostro ultimo destino. Per questa ragione, una escursione nel fitto di un bosco, specialmente se si è da soli e in uno stato di serenità e di distacco dalle preoccupazioni e dalle ansie d’ogni giorno, è, prima di tutto, una vera e propria esperienza mistica, e solo secondariamente una esperienza di tipo materiale, turistica o sportiva, o in qualunque altro modo vogliamo chiamarla. Perché già il bisogno di dare un nome preciso a tutte le cose, di classificarle, di catalogarle, per quanto sia indubbiamente utile sul piano della chiarezza scientifica, non è di nessun aiuto, anzi, si rivela decisamente dannoso, quando si va alla ricerca dell’essenziale.
Ecco: una passeggiata nel bosco è un viaggio alla ricerca di ciò che è essenziale. Si tratta di mettersi in ascolto, di spogliarsi del falso sapere, d’imparare dalla semplicità delle piante: le quali altro non chiedono, per vivere, che i sali disciolti nel terreno, acqua e luce; indi si slanciano verso il cielo, con tutte le loro energie, in una maniera che nessuno scienziato ha mai saputo spiegare. La biologia, infatti, non sa dire in qual modo la linfa salga lungo il tronco di venti, trenta metri d’altezza: secondo le leggi della fisica, ciò è semplicemente impossibile. Eppure avviene, e possiamo vederlo dovunque. E anche l’anima nostra si protende verso l’alto: come e perché, non sappiamo spiegarlo..
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels