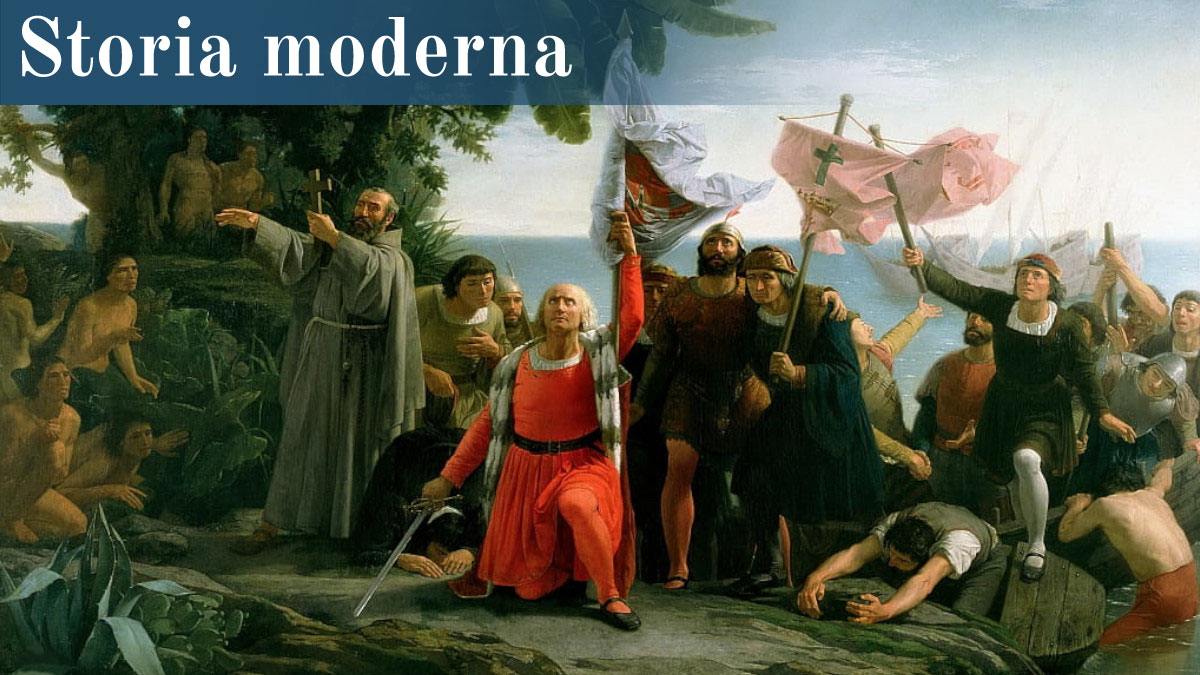Nello sposalizio di Sara e Tobia la Bibbia celebra la santità e la castità del matrimonio
23 Agosto 2016
Distruggerò la sapienza dei sapienti e squalificherò l’intelligenza degli intelligenti
24 Agosto 2016Garrett Mattingly non è stato un grande storico, tanto è vero che quasi nessuno, fuori degli Stati Uniti (e anche dentro, a soli pochi anni di distanza dalla sua morte) ne conosce il nome; ma è stato uno storico popolare, uno storico di successo, quanto può esserlo uno che ha vinto il Premio Pulitzer nel 1960, per un suo libro dedicato alle vicende dell’Armada spagnola.
Era nato a Washington, D. C., il 6 maggio 1900 ed è morto il 18 dicembre 1962, al culmine della carriera e della notorietà, dopo avere occupato per parecchi anni la cattedra di Storia d’Europa alla Columbia University. Le sue opere maggiori sono state: Caterina d’Aragona, del 1942; Diplomazia del Rinascimento, del 1955; e L’Armada, del 1959, che, come si è detto, gli valse il Pulitzer e consacrò la sua fama anche presso il grande pubblico dei non specialisti.
Se ora siamo qui a parlare di lui, non è perché questo mite e decoroso professore americano abbia lasciato una traccia particolarmente originale o profonda nel suo campo di studi, tutt’altro; ma piuttosto perché in lui bene si esemplificano certe caratteristiche peculiari degli storici di estrazione protestante, specialmente nell’area anglo-sassone, nei quali l’orgoglio di stirpe e di nazione si fonde con la rocciosa convinzione di avere Dio dalla propria parte, sicché il loro nazionalismo si tinge di austere venature religiose — essi hanno una missione decisiva da svolgere nella storia dell’umanità: diffondere la "giusta" maniera di adorare il Dio dei cristiani — e il loro protestantesimo si alimenta e si rafforza di nobili motivazioni patriottiche — l’espansione imperiale dei loro stati finisce per realizzare i misteriosi disegni della Provvidenza divina.
Prendiamo, a titolo di esempio, la sua opera più famosa e celebrata, nella quale egli rievoca una delle battaglie decisive nella storia d’Europa, e non solo per ragioni militari e politiche, ma anche, e soprattutto, religiose e culturali: la spedizione condotta dalla flotta spagnola di Filippo II contro l’Inghilterra della regina Elisabetta, risoltasi nella sua sconfitta, nel Canale della Manica, presso Gravelines, l’8 agosto del 1588 (sconfitta in realtà non fu decisiva, ma cui si aggiunsero le tre violentissime tempeste che semidistrussero le navi superstiti sulla via del ritorno). In quell’opera, traspare chiaramente l’influsso della teologia proestante, e, insieme, di un ideale di tipo pacifista e socialista, quale poteva nutrirlo un americano che fosse anche buon cittadino e timorato di Dio, secondo il modello rappresentato, in politica, dal pastore presbiteriano Norman Mattoon Thomas (1884-1968), che fu anche esponente di spicco del Partito Socialista d’America. Di quell’opera vogliamo andare a rileggerci, perché particolarmente significativa ai fini del nostro discorso, la riflessione conclusiva (da: Garrett Mattingly, L’invincibile Armada; titolo originale: The Armada, Boston, Houghton Mifflin Co., 1959; traduzione dall’inglese Eladia Rossetto, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1967, pp. 324-326):
… Ad ogni modo, la sconfitta dell’Armada spagnola fu in un certo senso un evento decisivo, non tanto per i combattenti, quanto per gli osservatori. Sorprendente per gli esperti delle due parti l’esito di Gravelines, soprattutto avendo l’Armada fatto tutto il possibile. Ma a terra inglesi e spagnoli erano meno sicuri di sapere da che parte si sarebbe inclinato il piatto della vittoria, e altri lo erano ancora meno. Francia, Germania, Italia, avevano visto il colosso spagnolo passare di vittoria in vittoria. La Provvidenza, il disegno di Dio sempre più chiaro, il corso della storia futura, tutto sembrava in favore degli spagnoli: ma i cattolici francesi, tedeschi, italiani, che in quanto tali si compiacevano che la Spagna fosse evidentemente il campione prescelto della Chiesa di Dio, apprezzavano mediocremente l’eventualità di un dominio spagnolo, e dappertutto i protestanti erano altrettanto preoccupati e inquieti. Quando l’Armada sfidò gli antichi signori della Manica in casa loro, il conflitto in corso prese l’aspetto di un giudizio di Dio, in cui, come avviene in questi casi, Dio avrebbe preso le parti del giusto. La solennità dell’occasione fu ancora aumentata dalle profezie prodigiose riguardanti l’anno del conflitto, così antiche e venerabili che neppure i più scettici e disincantati potevano ignorarle del tutto. E quando le due flotte si avvicinarono alle acque prestabilite dello scontro, tutta l’Europa stava ad osservarle.
Per gli spettatori delle due parti, l’esito, determinato anche, come si credeva, da una grande burrasca, fu davvero decisivo. I protestanti di Francia e d’Olanda, di Germania e di Scandinavia scoprirono con sollievo che Dio era realmente dalla loro parte, come avevano sempre creduto. E i cattolici di Francia, Italia, Germania scoprirono con pari sollievo che la Spagna in fondo non era il campione scelto da Dio. Benché la preponderanza spagnola durasse ancora per più di una generazione, da quel momento si chiuse il periodo di massimo prestigio. Soprattutto la Francia, dopo il colpo di Stato di Enrico III a Bois, incominciò a ritornare all’antica funzione d’equilibrio di fronte alla casa d’Austria, e ad essere la maggior garante delle libertà europee, finché quelle libertà erano minacciate dagli Asburgo. Senza la vittoria inglese a Gravelines e la successiva conferma delle notizie dall’Irlanda, Enrico III forse non avrebbe mai trovato il coraggio di scuotere il giogo della lega e forse la storia successiva d’Europa sarebbe stata imprevedibilmente diversa.
Così, nonostante la lunga guerra non risolutiva che ne seguì, la disfatta dell’Armada spagnola fu realmente decisiva. Essa dimostrò che l’unità religiosa non poteva essere imposta con la forza agli eredi della Cristianità medioevale, e se, così facendo, convalidò soltanto quella che era già la conseguenza probabile, forse le battaglie cosiddette decisive hanno avuti sempre soltanto questa funzione. Non sapremo mai se il duca di Parma sarebbe riuscito a riconquistare alla Spagna Olanda e Zelanda, come aveva fatto per le province meridionali. Dopo il 1588 non ebbe più occasioni favorevoli, troppe delle sue scarse forze si erano logorate per sostenere la Lega contro Enrico di Navarra. Cominciavano a delinearsi gli stati territoriali, poi "nazionali", tipici dell’Europa moderna, e dopo il 1588 ciascuno dei grandi stati non soltanto tese alla libertà, ma ancor più volle sentirsi libero, sviluppare le proprie energie individuali senza conformarsi a un sistema di credenze imposto dall’esterno. Tuttavia le potenze europee non erano abbastanza forti, né lo sarebbero state per secoli, per infliggersi reciprocamente danni irreparabili, e il problema di come combinare la libertà d’essere diversi con la sicurezza dalla distruzione totale fu rinviato al secolo in cui esso si sarebbe presentato.
Intanto, man mano che l’episodio dell’Armada si allontanava nel passato, influiva sulla storia in modo diverso. La sua vicenda, esaltata e deformata in un velo di nebbia dorata, divenne l’apologo eroico della difesa della libertà contro la tirannide, il mito eterno della vittoria del debole sul forte, del trionfo di Davide contro Golia. Nelle ore buie, infuse coraggio ai cuori degli uomini e fece sì che l’uno dicesse al’altro: "Quel che abbiamo fato una volta, possiamo di nuovo farlo". Per aver raggiunto questo risultato, la leggenda della sconfitta dell’Armada spagnola divenne tanto importante quanto l’evento reale, e forse di più.
A conclusione del suo ragionamento, dunque, il Mattingly — dopo essere incorso nella cattiva abitudine di dire solo delle mezze verità, tipico della storiografia ideologica, come quando esalta la funzione della Francia quale arbitro e modello delle "libertà" d’Europa, e la sua utile funzione di contrappeso agli Asburgo d’Austria, ma tace sulla scellerata alleanza con i Turchi Ottomani quando essi minacciavano non solo Vienna, ma l’Europa intera — ammette, sì, che la "leggenda" della sconfitta dell’Invincibile Armata fu più reale dell’evento stesso, ma, nel medesimo tempo, sembra compiacersene, visto il tono piuttosto trionfalistico della sua osservazione finale. E si capisce perché: da quella leggenda ebbe inizio la riscossa delle nazioni protestanti contro il fronte cattolico e contro la Chiesa di Roma, il che — secondo lui — ebbe una funzione decisiva nella nascita e nello sviluppo della moderna idea di "tolleranza", che, altrimenti, non ci sarebbero stati, o, tutt’al più, si sarebbero verificati chissà quanto tempo dopo. Ora, a parte il fatto che ciò equivale ad accaparrarsi, anacronisticamente, i meriti di un determinato evento o fenomeno storico, non solo con il senno del poi, ma soprattutto mediante un giudizio arbitrario su chi o cosa ebbe quei meriti, e chi non li ebbe, o avversò quella benefica evoluzione; a parte questo, dicevamo, il Mattingly compie una forzatura inaccettabile quando suggerisce che, nella storia, l’importante non è quel che accade, ma quel che si crede sia accaduto, senza poi prendere le distanze, storiograficamente appunto, da una simile prospettiva, e senza evidenziare come il compito dello storico sia proprio quello di separare ciò che è leggenda da ciò che è realtà, per porre in risalto solo quest’ultima.
Il fatto è che la "leggenda" della sconfitta dell’Armada (l’espressione è sua, non nostra) fa troppo comodo alla sua tesi precostituita, ossia che quella sconfitta fu un bene, non solo per i protestanti di tutta Europa — e perfino, secondo lui, per i cattolici — ma per l’Europa in se stessa, in quanto creò le condizioni che avrebbero reso possibile la nascita e lo sviluppo dell’idea di tolleranza. Come dire che l’idea di tolleranza (Spinoza e Locke lo "dimostrerebbero") è una acquisizione del pensiero protestante; mentre una eventuale vittoria spagnola, cioè cattolica, avrebbe ripiombato il nostro continente nelle tenebre del Medioevo, cioè nella repressione religiosa e nella superstizione. Ma tutto questo è falso, o, quanto meno, è altamente opinabile: e il compito dello storico che voglia portare avanti una propria tesi, semmai, è proprio quello di argomentare, di mettere avanti dei ragionamenti e, se possibile, delle prove a sostegno di ciò che afferma: non di darlo per acquisito solo perché, col senno del poi (vale a dire, con la ragione che sempre i vincitori avocano a se stessi), così dicono "tutti". Ribadiamo il concetto: non vi sono affermazioni false nel modo di procedere di Mattingly, bensì delle frequenti mezze verità; e una verità incompleta, e tenuta volutamente come tale, equivale, di fatto, a una menzogna. Ciò che egli suggerisce è che, se l’Armada avesse vinto e l’Inghilterra fosse stata invasa e sottomessa dalle truppe del duca di Parma, e quindi, verosimilmente, anche ricattolicizzata, lo sviluppo dell’idea di libertà sarebbe stato ritardato per dei secoli; ma tace sul fatto che, nell’Inghilterra protestante, vigeva lo squartamento per i preti cattolici, la confisca dei beni e l’esilio per i cittadini che praticassero il culto cattolico, anche in privato, anche in segreto. Il fanatismo, l’intolleranza e la violenza a sfondo religioso esistevano da entrambe le parti, la protestante non meno della cattolica: e come tacere del rogo di Michele Serveto, nella "libera" Ginevra calvinista, per volontà esplicita dello stesso Calvino? Il rogo di Michele Serveto era divampato nel 1553, ben trentacinque anni prima dell’epica battaglia navale nel Canale della Manica: chi voleva prendere atto della brutale intolleranza religiosa dei protestanti, aveva avuto tutto il tempo per farlo. A maggior ragione uno storico americano del XX secolo, che aveva tutti i documenti a disposizione. Né si dimentichi che, nell’Europa protestante, si bruciavano più streghe, o presunte streghe, e stregoni, di quanti se ne bruciassero nell’Europa cattolica.
Dove, tuttavia, il modo di procedere dell’Autore ci sembra più criticabile, è proprio nella conclusione: che le ripercussioni della leggenda della sconfitta dell’Armada furono altrettanto reali, anzi, persino più notevoli, del fatto in se stesso. Tradotto nel linguaggio della storia moderna, sarebbe come affermare che la leggenda dell’attacco "inaspettato" di Pearl Harbor, da parte del Giappone, fu più importante della realtà: una affermazione che si può anche fare, a patto di soggiungere, subito dopo, che di una leggenda, appunto, si trattava, e che l’opinione pubblica americana fu abilmente manipolata dal presidente Roosevelt per trascinarla là dove egli aveva solennemente promesso di non condurla, se fosse stato rieletto: alla guerra. E la stessa cosa si può dire, restando nell’ambito della storia americana recente, a proposito dell’esplosione della corazzata Maine, nel 1898, nel porto dell’Avana, che diede occasione allo scoppio della guerra contro la Spagna; oppure all’affondamento del transatlantico Lusitania, nel 1915, che preparò al presidente Wilson il terreno per portare l’America in guerra contro gl’Imperi centrali. Gli storici anglosassoni sembrano pensare che il loro mestiere consiste nel dimostrare che il Dio dei protestanti è dalla parte delle loro nazioni, e che esse, come Davide contro Golia, lottano e vincono (ieri come oggi) perché rappresentano la causa della giustizia. Ma è proprio vero che la Spagna del 1588 era il gigante Golia e l’Inghilterra era il piccolo Davide? Perché, se cadesse questa tesi, cadrebbe anche tutto il resto…
Fonte dell'immagine in evidenza: Immagine di pubblico dominio