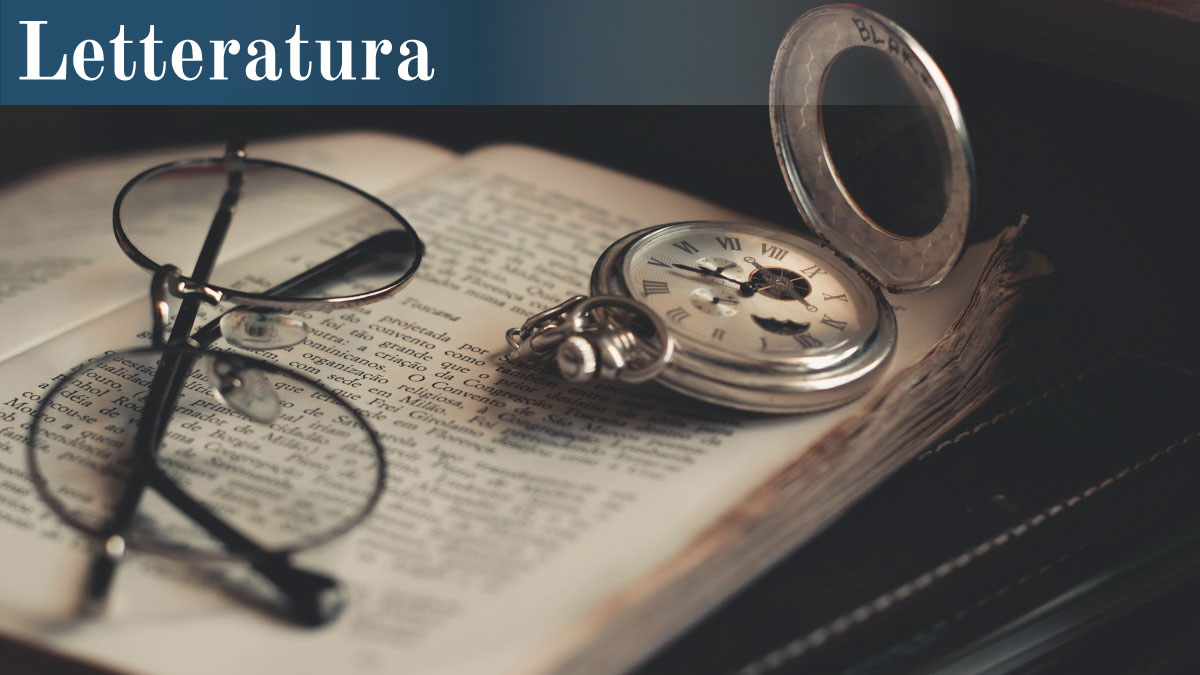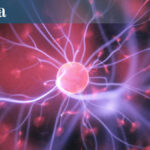
Le origini della vita secondo l’evoluzionismo politicamente corretto
14 Giugno 2016
Ma l’Italia è sempre il centro del mondo
15 Giugno 2016Forse non tutti sanno, fra le giovani generazioni, chi sia stato Fabrizio Maramaldo (a noi, le maestre lo insegnavano già sui banchi della scuola elementare): un capitano di ventura vissuto nel XVI secolo, postosi al servizio di Carlo V e dei Medici, questi ultimi cacciati da Firenze e bramosi di rientrarvi, il quale, dopo la battaglia di Gavinana del 1530, uccise di sua mano il condottiero fiorentino Francesco Ferrucci, oppure lo ferì a morte e lo abbandonò ai suoi soldati, perché lo finissero, dopo che questi si era arreso, ed era già ferito ed inerme, ricevendone — pare — le estreme parole di disprezzo: Vile, tu uccidi un uomo morto! Il nome e il (tristo) episodio sono diventati paradigmatici, tanto che "fare il Maramaldo" o "macchiarsi di una maramalderia" sono espressioni entrate nell’uso corrente, anche se, probabilmente, molti di coloro i quali le adoperano, non ne conoscono l’esatta origine. Sia come sia, il fatto è questo: e Maramaldo, da allora, è diventato il vile per antonomasia, colui che si accanisce contro un avversario già vinto e impossibilitato a difendersi. Anche se noi moderni siamo abituati a fellonie ben più raccapriccianti, l’episodio di Gavinana fece scalpore già all’epoca: epoca cavalleresca, appunto (almeno nelle intenzioni), laddove, ad esempio, Ludovico Ariosto immaginava — nel primo canto dell’Orlando furioso – che Ferraù, prima di affrontare in duello Rinaldo, scendesse da cavallo, per non godere d’un vantaggio sul nemico appiedato (come avrebbe poi fatto Tancredi nei confronti di Clorinda, nella Gerusalemme liberata di Tasso, quando ancora il guerriero cristiano non sapeva d’aver di fronte una donna).
Il fatto è che, nella storia e nella cultura italiana dell’ultimo settantennio, ossia dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale (conclusione che va sotto il nome pomposo, e assai impreciso e ambiguo, di "liberazione", anzi, di "Liberazione" con la lettera maiuscola, come del resto la Resistenza), la maramalderia è stata letteralmente la regola nei confronti di quella parte che era stata sconfitta, ossia il fascismo, e anche di quella parte della cultura – assai esigua, in verità — che, dopo il 1943, e anche dopo il 1945, non volle saltare sul carro dei probabili vincitori e rimase fedele ai propri morti e ai propri ideali, giusti o sbagliati che fossero, meritandosi una emarginazione pluridecennale, un ostracismo politico e intellettuale quasi granitico, e fungendo da testa di turco per tutti i malumori, per tutte le frustrazioni, per tutti gli errori, le meschinità e le miserie dell’Italia politicamente corretta, la quale era tutta, si sa, debitamente antifascista e democratica e con le carte in regola, lei sola, per sentenziare e giudicare su tutto e su tutti, avendo dato il suo contributo (per quanto modesto, per quanto simbolico, o anche, diciamolo pure, del tutto immaginario) alla nobile causa della "lotta di Liberazione" (leggi: guerra civile); mentre gli altri, i fascisti, e specialmente quelli di Salò (molti dei quali fascisti non erano neppure, come non lo era quel Nicola Bombacci, comunista della prima ora, che volle andare a morire con Mussolini, per non rinnegare la sua amicizia verso di lui ed il suo sogno di una pacificazione nazionale), non meritavano altro che disprezzo, essendo stati solo dei vili ed abietti manutengoli del tedesco invasore.
Una cultura maramaldesca è una cultura che si accanisce contro i morti, che sputa sui cadaveri (come a Piazzale Loreto), che se la prende coi ciechi di guerra e decorati al valor militare (come il povero Carlo Borsani), o coi preti che vollero restar fedeli al regime morente (come don Tullio Calcagno) o coi con gli innocui professori (come il filologo Goffredo Coppola), e che poi, per anni e per decenni, continua a prendersela con gli stessi morti, con gli stessi vinti, e, in dieci, in venti contro uno, contro quei pochi studenti, quei pochi intellettuali, quei pochi cittadini i quali mostrano simpatia per il progetto politici del Ventennio. Qualcuno si ricorda ancora, ad esempio, del rogo di Primavalle, a Roma, dove, nel 1973, militanti di Potere Operaio bruciarono vivi i due giovani figli di un segretario della sezione locale del Movimento Sociale Italiano (ma poco mancò che perisse tra le fiamme l’intera famiglia, formata da otto persone)? Ma le azioni maramaldesche, ripetiamo, traggono origine da una cultura maramaldesca: e gran parte della cultura democratica e antifascista dell’Italia post 1945 è stata una cultura maramaldesca. Maramaldesca è stata l’opera di Carlo Emilio Gadda intitolata Eros e Priapo, e quel suo vile infierire contro la memoria del morto dittatore (cfr. il nostro articolo: Nausea dell’esistenza e bassezza morale nell’opera di un falso "grande" della letteratura: C. E. Gadda, pubblicato sul sito di Arianna Editrice in data 12/05/2010). E maramaldesco è stato, da parte del filosofo marxista Alfonso Maurizio Iacono, aver ripreso un giudizio stupido e cattivo di Antonio Gramsci su Giovanni Gentile: di quel Gentile che, vecchio inerme di oltre settant’anni, fautore della riconciliazione nazionale durante la Guerra civile, e personalmente impegnato a salvare vite di persone cadute nelle mani dei tedeschi, venne assassinato dai partigiani comunisti su istigazione di nobilissimi intellettuali, comunisti anch’essi, come il latinista Concetto Marchesi (il quale, se pure è dimostrato che non firmò la famigerata frase di condanna a morte del filosofo, è altrettanto vero che non volle mai neppure smentirla).
Ecco: soffermiamoci su questo episodio. È il 1979 quando Alfonso Maurizio Iacono firma un pezzo dedicato a Giovanni Gentile, in una antologia che dovrebbe delineare i tratti salienti dei principali pensatori contemporanei; pezzo che ci permettiamo di riportare pressoché nella sua interezza, visto che è molto breve, affinché il lettore possa giudicare se si tratta, o no, di un classico esempio di cultura maramaldesca (da: La cultura del 900, Milano, Edizioni Gulliver, pp. 171-173; la sezione Filosofia è a cura di Remo Bodei):
Misurandosi, alla fine del secolo scorso, con i temi della "necessità" nella storia e della previsione scientifica dell’avvenire posti dal dibattuti sul marxismo, Gentile [… ] sostiene che la necessità e l’obiettività nel processo storico sono soltanto una sorta di trasferimento di ciò che si vuole debba accadere nella storia in un contesti di previsione scientifica. La previsione di Marx è interpretata come una trasfigurazione oggettivata della volontà: in questo senso il marxismo è per Gentile utopia. Il punto centrale della sua argomentazione critica consiste nella messa in evidenza di ciò che egli considerava la contraddizione fondamentale della teoria di Marx, l’impossibilità di conciliare la previsione con la prassi, poiché se si ammette la prima, la prassi diventa superflua, mentre se si ammette quest’ultima come indipendente dal pensiero, allora la previsione diventa inutile. Gentile rivendica l’originarietà della prassi e la sua unità con il pensiero: non si dà alternativa fra pensiero e prassi in atto, né differenza qualitativa. Ciò significa che la filosofia assume la continuità della tradizione consolidata e se ne presenta come la coscienza. Anzi la filosofia trova le sue radici proprio nella traduzione. Con ciò si spiega la ricerca gentiliana dell’unità attraverso la "tradizione nazionale", che doveva eliminare le forme dualistiche in cui si manifestava la realtà sociale di classe, anche per mezzo della violenza che poteva incorporare una filosofia dell’azione.
Questo tema della ricerca dell’unità tra prassi in atto e pensiero come superamento violento del dualismo sociale di classe segna almeno due aspetti fondamentali della riflessione genti liana, che spiegano il significato filosofico della sua adesione al fascismo. Quest’ultimo è considerato come la realizzazione di quell’unità nei termini dinamici in cui egli la concepiva. Il primo aspetto è quello dell’educazione. È noto che Gentile fece approvarla riforma della scuola media secondaria. La scuola è per lui il luogo per eccellenza in cui può realizzarsi il suo progetto di filosofia in atto. Il rapporto fra dicente e discente appare come sviluppo e approfondimento del’interiorità: l’unità fra docente e discente si realizza infatti nel farsi del loro spirito. L’elemento autoritativo, che sta a fondamento della sua pedagogia,consiste nel fatti che l’educazione deve eliminare tutti i suoi presupposti oggettivi: il maestro e lo scolaro sono espressione di pura soggettività che ha dimenticato il reale. L’ideale educativo è dunque la ricerca di una unità dinamica fittizia capace di sublimare il dualismo sociale in una illusoria soggettività pura in movimento, il cui punto di aggancio rimaneva la tradizione nazionale. Il secondo aspetto è quello del rapporto Stato-individuo. Per Gentile il superamento del’individualismo, espressione della società liberale, si realizza dentro lo Stato. Il rapporto non immediato, ma nel "suo farsi", nel "tendere" all’unità, l’elemento caratterizzante è il "processo" di realizzazione e di identificazione. "… lo Stato è sempre e non è mai quello Stato che dev’essere; né vi potrà esser mai un giorno, in cui, compiuto il processo, l’individuo si sia risoluto completamente nello Stato; poiché quel giorno non vi sarebbe più individui ma non vi sarebbe neanche Stato". Il senso strategico di simile teorizzazione sta nel tentativo di comprimere il luogo della società civile, senza con ciò appiattire l’individuo nello Stato; il risultato pratico è quello di ricucire la scissione di classe attraverso il richiamo all’ordine come espressione corporativa e primitiva di dominio diretto della classe dominante.
Gramsci, riprendendo la frase di Gentile sulla "filosofia che non si enuncia in formule ma si afferma nell’azione", si chiedeva come mai essa non fosse stata applicata al vero processo di trasformazione della società civile qual era l’americanismo, che tendeva a cambiare i contenuti esterni delle relazioni fra gli uomini, ma anche la loro stessa interiorità, ed evidenziava in questa mancanza il sintomo di quell’aspetto del fascismo in cui poteva riconoscersi la filosofia di Gentile, che proprio nel mentre affermava il nesso Stato-individuo nel "suo farsi" ed esaltava l’interiorità nell’educazione come base per assumere la "tradizione nazionale", veniva ad eliminare surrettiziamente il luogo complesso dell’azione e del pensiero degli uomini, quale è la società civile. Per questo l’affermazione gentiliana sopra citata diventò nella "prassi in atto" soltanto espressione di un "gladiatorismo gaglioffo che si autoproclama azione e modifica solo il vocabolario, non le cose, il gesto esterno, non l’uomo interiore" (Gramsci).
Intanto prendiamo atto che, per delineare, nello spazio di una paginetta, l’intero senso della filosofia di Gentile, l’ottimo Iacono non trova di meglio — pensate quale originalità — che partire dal marxismo, quasi che il problema speculativo fondamentale di Gentile sia stato quello di confutare il marxismo. Da questa distorsione prospettica, che si spiega solo con l’auto-ubriacatura marxista degli anni in cui questo pezzo fu scritto, anni nei quali era impossibile, per gli intellettuali politicamente corretti, parlare di alcunché, fosse pure la religione degli indigeni della Terra del Fuoco, senza portare il discorso su Marx e Freud, e, naturalmente, sui mille rivi del post-marxismo, da Gramsci a Foucault, e senza interpretare ogni cosa alla luce del socialismo scientifico e della psicanalisi. Ad ogni modo, voler spiegare l’attualismo attraverso il prisma del marxismo è una operazione ideologica del tutto arbitraria, e tale da creare aprioristicamente le conseguenze negative di una premessa sbagliata, secondo il noto principio di non falsificabilità evidenziato da Popper, che rende il marxismo appunto una teoria non scientifica, ma pseudo-scientifica (come si può falsificare una teoria che bara sistematicamente al gioco delle tre carte, pur di avere sempre ragione?).
E non solo: dopo aver così impostata la critica all’attualismo, Iacono assume, per criticarlo, le categorie del marxismo, che l’attualismo, a sua volta, criticava: il risultato, tanto scontato quanto banale, è la "dimostrazione" che il fascismo, abbracciato da Gentile come controparte concreta della sua filosofia dell’atto puro, è capace di cambiare la realtà solo a parole, ben diversamente non solo dal marxismo, ma anche dall’americanismo, che — ce lo assicura Antonio Gramsci — sa cambiare, quello sì, tanto le relazioni oggettive tra le persone, quanto la loro condizione soggettiva, interiore. Fra parentesi, questa celebrazione dell’americanismo, da parte di Gramsci, è molto significativa e dovrebbe essere meditata a fondo, alla luce degli eventi più recenti: essa aiuta a capire come tanti ex marxisti siano divenuti strenui e appassionati difensori della politica americana e dello stile di vita americano. Contraddizione solo apparente, se si considera come Gramsci, e non lui solo, vedesse nell’americanismo una vera filosofia della prassi, di tanto superiore a ogni forma di idealismo, quanto l’etica protestante del capitalismo è superiore, per i marxisti, alla cattolica, tutta ripiegata sulla mera interiorità. In definitiva, Iacono trova quel che aveva posto in essere fin dall’inizio: che l’attualismo è una filosofia velleitaria e screditata, perché ignora il "reale" a vantaggio dell’ideale. Si capisce, così, anche la citazione gramsciana dell’attualismo come "gladiatorismo gaglioffo".
E questo non è un modo di far storia della filosofia degno di Fabrizio Maramaldo? A noi pare di sì…
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels