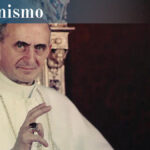
Quanti preti di sinistra sono massoni ed ex agenti sovietici infiltrati nei seminari?
1 Giugno 2016
La svolta dell’arte nel XIII secolo preannuncia l’avvento della modernità
2 Giugno 2016Se l’atomica fu necessaria per abbreviare la guerra, perché la campagna delle Filippine?

Al margine del suo ultimo G8, svoltosi in Giappone alla fine del maggio 2016, il presidente americano Barack Obama ha visitato Hiroshima, la città che il 6 agosto 1945 venne colpita con la prima bomba atomica, e ha reso omaggio alle vittime e auspicato un futuro di pace per l’umanità; non ha visitato l’altra città martire, Nagasaki, distrutta da una seconda (e ancor più inutile) bomba atomica, il 9 agosto, e, soprattutto, non ha domandato scusa per quanto il governo degli Stati Uniti fece settantun anni fa. Ciononostante i media asserviti di tutto il mondo hanno levato alte lodi allo "storico" gesto, come se il presidente statunitense, già premiato con il Nobel per la pace poco dopo l’elezione al suo primo mandato, quando ancora non aveva fatto assolutamente nulla di notevole, né per la pace, né per qualsiasi altra cosa (e c’è da chiedersi con quale coraggio glielo avrebbero dato, se avessero avuto la pazienza di metterlo un po’ alla prova), avesse mostrato chi sa quale coraggio e avesse dato prova di chi sa quale mirabolante sensibilità. In effetti, evitando di scusarsi (ma quando mai gli Stati Uniti si sono scusati di qualcosa, anche davanti al torto più clamoroso?; si sono forse scusati per la strage del Cermis, o per l’uccisione di Nicola Calipari all’aeroporto di Baghdad?; e si sono scusati per il genocidio dei pellerossa o per la schiavitù dei neri? o, più recentemente, per l’ingiusta aggressione all’Iraq del 2003, basata su pretesti menzogneri?), Obama ha ribadito la versione ufficiale della storiografia del suo Paese, e di quella di gran parte del mondo, succube della prima: cioè che l’impiego della bomba atomica su Hiroshima era necessario, anzi, indispensabile (ma lo era anche la seconda bomba?) per porre fine rapidamente alla guerra, risparmiando così un milione di vite umane. Vite americane, s’intende: non certo vite giapponesi. Quanto valessero le vite giapponesi, il governo americano lo aveva già mostrato con il bombardamento "convenzionale" di Tokyo, il 9-10 marzo 1945 (e dunque, a guerra ormai quasi finita), che costò alla capitale nipponica la perdita di qualcosa come 200.000 morti, soprattutto vecchi, donne e bambini, e la distruzione del 20% dell’area edificata.
Perché Barack Obama avrebbe dovuto chiedere scusa?, domanderà qualcuno. La guerra è guerra; e la guerra del Pacifico furono i Giapponesi a scatenarla, con il proditorio attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941. E poi, come si è detto, i morti di Hiroshima (140.000) e di Nagasaki (70.000) furono, dopo tutto, meno numerosi di quelli di Tokyo, o del bombardamento aereo di Dresda del 13-14 febbraio 1945 (250.000), anch’essi del tutto inutili sul piano strategico, perché la guerra in Europa era giunta quasi alla fine, e la città di Dresda non era un centro industriale, in compenso era affollata di donne e bambini fuggiti dalle province orientali della Germania, davanti all’avanzata sovietica. Stando ai numeri, dunque, ciò che gli Americani fecero ad Hiroshima e a Nagasaki non fu più grave di altri crimini della guerra, e specialmente della guerra aerea, compiuti sia da loro stessi e dai loro alleati, sia dal nemico: ad esempio dall’aviazione tedesca con i bombardamenti su Varsavia e su Rotterdam, o dall’esercito giapponese dopo la conquista di Nanchino. Ma gli Americani, nell’agosto del 1945, erano i soli detentori dell’arma atomica, e non si fecero scrupoli ad usarla, anzi, per buona misura, vollero sganciare due ordigni, a tre giorni di distanza l’uno dall’altro; e ciò pur sapendo che migliaia di persone avrebbero continuato a soffrire e a morire per anni, per decenni, a causa delle radiazioni atomiche. Non per il numero dei morti, dunque, ma per il tipo di arma sperimentata su Hiroshima e Nagasaki – un’arma che, se impiegata massicciamente, può mettere in pericolo, e persino distruggere, l’umanità intera – Barack Obama avrebbe potuto e dovuto domandare scusa: non solo al popolo giapponese, ma agli uomini di tutto il mondo.
Vale quindi la pena di esaminare un po’ da vicino la giustificazione "ufficiale" della storiografia americana, della quale Obama si è fatto forte, come, a suo tempo, il presidente Harry S. Truman (divenuto tale, da vicepresidente che era, non mediante elezioni politiche, ma a causa della scomparsa improvvisa di Roosevelt), per la decisione di sganciare le due atomiche del 1945, e cioè che il governo statunitense desiderava accorciare i tempi della guerra e risparmiare il maggior numero di vite umane, e sia pure al tragico prezzo di sacrificare delle altre vite (innocenti). Tale motivazione risponde a verità? Ha essa un reale fondamento storico; può essere sostenuta con perfetta onestà intellettuale?
Vediamo. Nel 1941-42 i Giapponesi avevano conquistato le Filippine, infliggendo una umiliante sconfitta alle forze americane che le presidiavano. Il comandante di queste, generale Douglas MacArthur, l’11 marzo 1942 era fuggito dalla base sull’isola di Corregidor, sottoposta a un duro assedio, ed era riparato a Darwin, nell’Australia settentrionale. Prima di partire, abbandonando a se stesse le sue truppe, già alquanto demoralizzate, aveva pronunciato la frase che, in seguito, sarebbe stata trasformata in una specie di grido di rivincita: Tornerò. Ma era stato solo un penoso tentativo di attenuare la pessima impressione che la sua fuga aveva suscitato e di smorzare il biasimo dei suoi ufficiali, con una vana promessa, che lui ben sapeva essere priva di qualunque significato: prima che fosse immaginabile organizzare una qualsiasi spedizione di soccorso, l’ultima roccaforte sulla Penisola di Bataan certamente sarebbe caduta, e la guarnigione americana sarebbe stata costretta ad arrendersi, andando incontro a una durissima prigionia e offrendo alla popolazione filippina lo spettacolo deprimente di un esercito di uomini bianchi, già potente e orgoglioso, ridotto in condizioni miserevoli dalla fame e dalle malattie tropicali e costretto a cedere le armi a un’armata giapponese, presentata come lo strumento per la nascita di una Grande Asia Orientale libera dalla presenza occidentale.
Erano passati due anni e mezzo e la flotta americana, con la battaglia del Mare delle Filippine, combattuta il 19-20 giugno 1944, si assicurò definitivamente la supremazia aeronavale nell’area del Pacifico occidentale, eliminando praticamene tutti gli aerei da combattimento giapponesi imbarcati sulle portaerei. A quel punto, gli Americani erano liberi di scegliere quale direzione imprimere al loro sforzo bellico, senza dover più temere iniziative giapponesi realmente pericolose sul piano strategico. La direzione d’attacco più logica sembrava quella passante per l’isola di Formosa (Taiwan), da dove sarebbe stato possibile tagliare il traffico marittimo fra il Giappone e le Indie Orientali olandesi (oggi Indonesia), privando il primo degli indispensabili rifornimenti di petrolio e altre materie di vitale importanza industriale e militare. Senza il petrolio delle Indie orientali, la flotta giapponese, già rimasta praticamente priva di aerei da combattimento e da bombardamento (la sola marina ne aveva perduti 400 nella battaglia del Mar delle Filippine, e altri 200 l’esercito; non esisteva un’arma aerea indipendente), sarebbe stata costretta, nel giro di qualche mese, a restare ferma nei porti per mancanza di combustibile. Di questa opinione era l’ammiraglio Ernest King, spalleggiato da altri comandanti americani; ma il generale Mac Arthur era di tutt’altro avviso. Lui aveva subito i fatti del 1942 come un affronto personale, tanto più che correvano voci poco lusinghiere sulla sua inettitudine, o sulla sua superficialità, nella mancata adozione di misure efficaci per la difesa dell’arcipelago alla fine del 1941, dal momento che l’imminente attacco giapponese era ben noto ai servizi segreti statunitensi. MacArthur voleva rifarsi della figuraccia rimediata con la sua fuga da Corregidor e onorare la promessa del suo fatidico Ritornerò, promessa che aveva rinnovato e alimentato, a mezzo di volantini scaricati dal cielo, coi quali aveva inondato le Filippine per oltre due anni.
In un primo tempo anche l’ammiraglio Chester Nimitz la pensava come King ed era fautore di uno sbarco a Formosa: per lui, la sconfitta del Giappone era l’obiettivo prioritario, e, per raggiungerlo, bisognava colpire il nemico nel cuore del suo territorio, passando per la via più breve. Ma Nimitz non aveva particolari ambizioni politiche; MacArthur, invece, sì. Fu così che il contrasto venne portati davanti al presidente Franklin Delano Roosevelt, il quale preferì il piano di MacArthur, soprattutto per considerazioni di prestigio, e cioè per rifarsi una reputazione davanti ai Filippini e all’opinione pubblica dei Paesi dell’Asia orientale, compromessa dalla ritirata del 1941-42. Alla fine, anche Nimitz cambiò parere e fu deciso lo sbarco nelle Filippine. Fu l’inizio di una campagna durissima e spossante, preceduta da un’altra battaglia navale, quella del Golfo di Leyte (23-26 ottobre 1944), nella quale, grazie alla superiorità numerica e operativa e anche a una certa dose di fortuna, la marina americana riuscì a spazzare via praticamente l’intera flotta giapponese, in quella che è passata alla storia come la più grande battaglia aeronavale della Seconda guerra mondiale e, probabilmente, di tutto il corso della storia umana. Ma la campagna di riconquista via terra fu lenta e difficile: iniziata il 20 ottobre, con lo sbarco nell’isola di Leyte, si concluse ufficialmente solo il 5 luglio 1945, con l’annuncio ufficiale di MacArthur, il quale, appena messo piede a terra, si era affrettato ad annunciare enfaticamente: Sono tornato. Ma le ultime operazioni ebbero termine solo dopo la resa dello stesso Giappone.
Ha osservato ne La campagna di Iwo Jima l’ammiraglio e studioso di cose navali Giorgio Giorgerini (in: Storia della Marina, Milano, Fratelli Fabbri Editori, 1978, vol. 5, pp. 1505-1506):
La battaglia aeronavale del Golfo di Leyte era terminata coll’annientamento della flotta giapponese: per gli americani iniziava la campagna per la riconquista delle Filippine, di esito certo ma di arduo svolgimento, mentre quell’impegno nell’arcipelago influiva sui tempi di avanzata verso le isole metropolitane del Giappone. Nel libro del capitano di vascello britannico Donald MacIntyre "Leyte Gulf: armada in the Pacific", l’introduzione scritta da G. Giorgerini, tra l’altro dice: "L’obiettivo americano nel Pacifico era la sconfitta e l’occupazione del Giappone. Tale meta non passava assolutamente attraverso le Filippine, ma si trovava al termine del cammino tracciato dall’ammiraglio Nimitz, che, iniziato a Guadalcanal, nell’agosto 19042, aveva portato gli americani, col ‘salto della rana’, sino alle Marianne, e che sarebbe poi proseguito con Iwo Jima e con Okinawa, annullare quello a Formosa e allontanare quindi la data del’assalto finale all’arcipelago giapponese. Ciò anche se la guerra poi si concluse per altri avvenimenti e con altri mezzi: l’esplosione delle prime bombe atomiche. Se quindi l’attacco alle Filippine non fu giustificato o richiesto dalle esigenze delle operazioni, è lecito chiedersi perché invece fu fatto… il motivo unico e essenziale lo si trova ne generale Douglas MacArthur… (che)… voleva riscattare a tutti i costi la figura che aveva fatto nel 1941-42 quando dovette abbandonare le Filippine…: pur essendo ormai a conoscenza dell’attacco giapponese… e dei preparativi in corso verso le Filippine, egli non prese alcuna efficace misura di sicurezza e di difesa. Fece distruggere i suoi aerei a terra, non contrastò gli sbarchi, non organizzò un’ordinata difesa a terra e rinchiuse nella trappola di Corregidor buona parte delle sue forze. Poi se ne andò dicendo: "Ritornerò". Negli eventi militari spesso si trovano componenti, note o ignote, di convenienza politica… che condizionano i primi. Il caso MacArthur potrebbe essere… stato uno di questi. Il che spiegherebbe anche casi come la campagna delle Filippine, operazione non essenziale per la conclusione della guerra nel Pacifico, ma di un certo interesse politici generale e individuale: l’ascesa di MacArthur nel Giappone occupato, quasi un regime personale…; il suo mantenimento in servizio ben oltre i limiti di età previsti dalle leggi; la spregiudicatezza nella pianificazione della guerra di Corea che portò alla sua destituzione da parte del presidente Harry S. Truman, ma anche l’immediata sua entrata nell’agone politico americano e quindi in quello industriale.
Gli ammiragli King e Nimitz… non ritenevano utili lo sbarco e l’occupazione delle Filippine. Puntavano… decisamente su Formosa, Iwo Jima, Okinawa, basi ideali per la preparazione e l’appoggio della forza d’assalto destinata all’attacco finale al Giappone. MacArthur, in contrapposizione, sostenne che le Filippine, e precisamente Luzon, avrebbero rappresentato il trampolino più opportuno per l’assalto al Giappone. Inoltre, secondo lui, vi era da tenere nel dovuto conto la negativa ripercussione politica che gli Stati Uniti avrebbero riportato in Asia se non avessero liberato, combattendo, le Filippine dai giapponesi… il contrasto tra MacArthur e Nimitz venne portato davanti al presidente Roosevelt. Questi dette ragione al primo, convinto più dalle argomentazioni politiche e anche di interesse economico che non a quelle militari basate solo sull’obiettivo di raggiungere al più presto il Giappone e porre fine ala guerra".
Sbarcati quindi a Leyte, gli americani incontrarono per oltre un mese notevoli difficoltà ad avanzare e a stabilire aeroporti e strutture d’appoggio, e fu necessario mantenere le navi della Terza e della Settima flotta nella zona per assicurare una adeguata copertura aerea.
Giungiamo, così, alla conclusione che non è possibile sostenere, in buona fede, che il governo americano decise il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki per ragioni puramente militari, ossia per accorciare il corso della guerre e per risparmiare il prezzo di vite umane che uno sbarco in forze sull’arcipelago giapponese avrebbe comportato. Se tali fossero state le vere ragioni, la campagna delle Filippine — inutile, lunga e costosa — non ci sarebbe stata: gli Americani avrebbero puntato direttamente su Iwo Jima, Okinawa e il Giappone metropolitano, lasciando le Filippine da parte. Tagliate fuori dalla madrepatria, prive di difesa aerea, a corto di carburante, pezzi di ricambio, munizioni, e persino viveri e medicinali, le truppe giapponesi sarebbero state comunque costrette ad arrendersi, quando la loro madrepatria avesse deciso di chiedere l’armistizio; la loro presenza non era in grado di ritardare in alcun modo le ulteriori operazioni americane. E che le condizioni dei soldati giapponesi di guarnigione nelle Filippine fossero disperate, prima ancora di dover fronteggiare lo sbarco americano, fino al puto di arrivare a commettere degli episodi di cannibalismo per sopravvivere, ciò risulta dai documenti ufficiali e anche dalla memorialistica e dalla letteratura di guerra, ad esempio dalle pagine del bel romanzo di Shoei Ooka, La guerra del soldato Tamura (titolo originale: Nobi), del 1951.
La verità è che il governo americano, nella persona del presidente Truman (Roosevelt era morto nel frattempo, di cancro, il 12 aprile 1945), voleva che il mondo intero sapesse che gli Stati Uniti disponevano di una nuova arma d’inconcepibile potenza, e che erano pronti ad usarla senza pietà, per imporre su tutto il globo terracqueo la pax americana — e quindi, anche e soprattutto per lanciare un monito all’Unione Sovietica, formalmente alleata, ma con la quale, avvicinandosi la fine della guerra, era facile prevedere che sarebbero esplose tutte le divergenze latenti in quella strana e innaturale alleanza. Il Giappone, già prostrato e moribondo, non contava più nulla nei futuri scenari mondiali, almeno a breve termine: la partita era fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Se lo scopo degli americani fosse stato davvero quello di risparmiare vite umane, sarebbe bastato porre il blocco all’arcipelago nipponico, cosa facilissima e quasi priva di rischi (a parte gli ultimi, disperati attacchi dei piloti kamikaze, strategicamente ininfluenti), dato l’assoluto dominio del mare e del cielo, e attendere che il paese nemico si fermasse per mancanza di petrolio, carbone, acciaio, generi alimentari. Non sarebbe stato necessario mettere a repentaglio la vita di un solo soldato americano; non sarebbe stato necessario effettuare uno sbarco, almeno fino a quando i Giapponesi stessi non fossero stato costetti ad alzare bandiera bianca, oppure fino a quando la fame e la mancanza di risorse primarie li avessero talmente indeboliti, da togliere qualunque mordente alla loro difesa. La sproporzione esistente fra i due Paesi in fatto di armamenti, di produzione industriale, di risorse finanziarie e di materie prime, era talmente schiacciante, talmente inverosimile, che la sola domanda che venga naturale porsi è come abbia fatto il Giappone a resistere così a lungo; ma è vero che, nell’estate del 1945, esso era giunto al collasso.
Ecco, dunque, di che cosa il presidente Barack Obama avrebbe potuto e dovuto chiedere scusa: non del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki in se stesso, ma della gigantesca bugia con la quale lo si è sempre tenacemente giustificato; e, in ultima analisi, della cinica, machiavellica ipocrisia di cui gli Stati Uniti si sono sempre ammantati per presentare nella luce migliore, idealistica e umanitaria, la loro brutale politica di potenza a livello planetario. Ma è chiaro che non era disposto a farlo. Perché, per farlo, sarebbe necessario che il governo americano scendesse dal piedestallo e prendesse atto di essere uno dei tanti governi esistenti al mondo: non il solo che abbia il diritto di porsi al di sopra di tutti gli altri, cioè il solo che abbia ricevuto un mandato divino riguardo alle sorti dell’intera umanità.
Fonte dell'immagine in evidenza: Wikipedia - Pubblico dominio