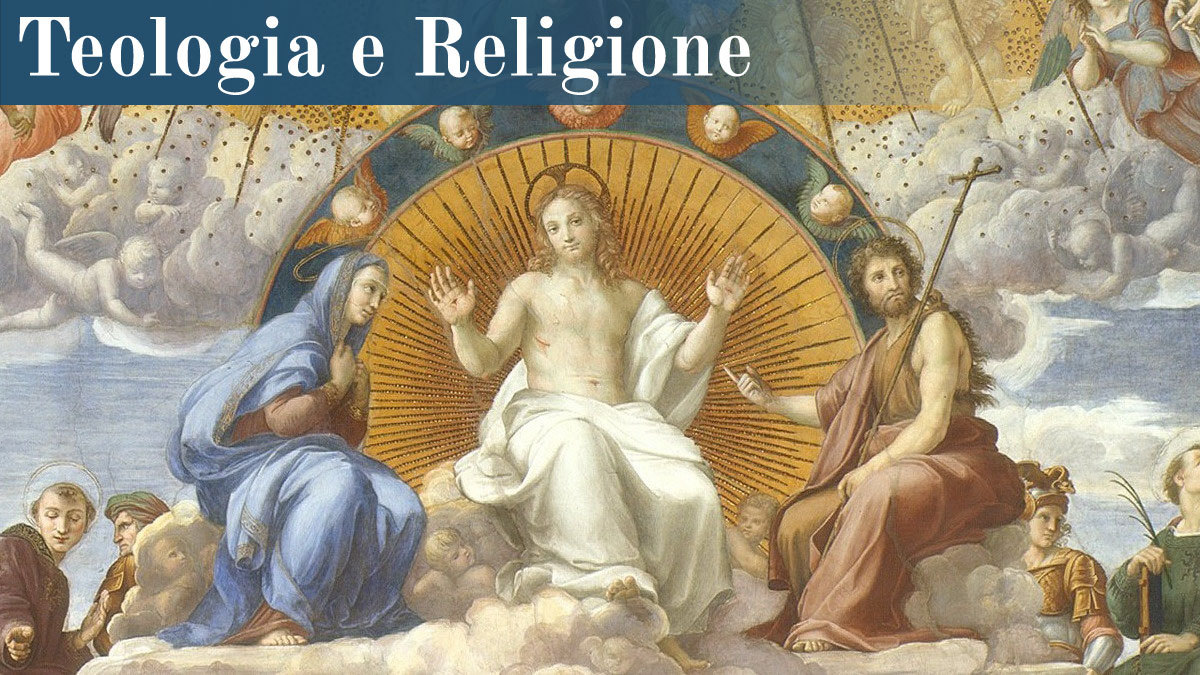Il fascismo volle sottomettere il Partito allo Stato, e non viceversa
8 Ottobre 2015
Il trionfo del rinoceronte, ovvero l’antisocrate trionfante
9 Ottobre 2015La facoltà creativa di un artista è un dono, che il perfezionamento sul piano tecnico e stilistico può, in una certa misura, perfezionare, ma che mai potrà sostituire, e che l’ambiente sociale e culturale può aiutare a comprendere, non spiegare nella sua essenza; in quanto dono, poi è anche un mistero, che rimane celato al nostro sguardo, perché non esiste uno sguardo umano capace di sondarne le abissali profondità.
È stato detto che la grande arte è sempre intimamente religiosa, o, quanto meno, che presuppone un atteggiamento di fondo profondamente spirituale da parte dell’artista (e, aggiungiamo, anche da parte del pubblico, almeno se la si vuol comprendere nella sua essenza e non solo nei suoi aspetti formali): bisogna aggiungere che, qualora l’artista si rivolga esplicitamente a Dio, e chieda a Lui di ricevere in dono la maestria che gli consenta di celebrarne degnamente la gloria; qualora, insomma, egli concepisca la propria arte non come uno strumento di glorificazione per se stesso, ma come una testimonianza, una lode e un ringraziamento da rivolgere a Dio, allora più che mai appare chiara la sorgente divina di quella ispirazione. È come se l’arte, che è, di per se stessa, un fatto spirituale, si spiritualizzasse ancor più e si slanciasse, leggera come un corpo liberato del proprio peso, verso le sublimi altezze dell’Assoluto.
Questo tipo di atteggiamento, che era tipico degli artisti medievali, compresi i poeti — si pensi a Dante Alighieri e alla «Divina Commedia» – si spingeva così avanti da indurre molti di essi a non preoccuparsi affatto di firmare in maniera clamorosa le proprie opere, delle quali, infatti, non si ritenevano realmente gli autori, se non nel senso più pratico e materiale del termine; non ritenevano importante che il pubblico conoscesse i loro nomi, tanto è vero che persino di molte cattedrali romaniche e gotiche non conosciamo gli architetti che le concepirono e che le realizzarono, oppure ignoriamo quasi tutto della loro biografia.
Si tratta di un modo di pensare che a noi sembra alquanto strano e, diciamolo francamente, quasi inconcepibile, solamente perché l’uomo moderno è talmente pieno del suo ego, da non riuscire nemmeno a immaginare che l’artista si ponga in una disposizione d’animo così disinteressata. E non si tratta affatto del moderno concetto di "impersonalità" dell’artista, caro alla scuola naturalista (e al nostro verismo): per Flaubert o per Zola, infatti, come pure per Verga, l’autore deve, sì, scomparire, eclissarsi rispetto ai personaggi e alle situazioni rappresentati, ma non certo per modestia; egli si considera, al contrario, come una specie di scienziato della dimensione umana (più i francesi che l’italiano) e, se desidera che l’opera sembri essersi fatta da sé, ciò non avviene perché egli ne rispetti l’intimo mistero (atteggiamento che sarebbe, semmai, di tipo spirituale e "religioso"), ma perché, secondo lui, non esiste alcun mistero nella dimensione umana. Come diceva il buon vecchio Hyppolite Taine: nell’uomo, visto come un organismo puramente biologico, non vi è nulla che l’ereditarietà, l’ambiente sociale ed il momento storico in cui egli si trova a vivere, non possano perfettamente spiegare, al punto da poterne predire il destino.
L’impersonalità dell’artista medievale è tutta un’altra cosa; anzi, a ben guardare, non si tratta per nulla di impersonalità, ma di anonimità, nel senso alto della parola; mentre oggi, ed è significativo, la parola anonimo fa subito venire in mente qualcosa di negativo: si pensi a una lettera anonima, oppure ad una esistenza anonima, espressioni dal significato immediatamente sgradevole. L’arte medievale — che è quasi tutta, nella maniera più profonda e anche più esplicita, arte religiosa – è arte corale, nel senso originario della parola: è simile a un corale rivolto a Dio, nel quale ciascun cantore offre il dono della sua voce, in un tutto armonico nel quale sarebbe vano, e soprattutto assurdo, voler discernere ciò che è di uno e ciò che è di un altro; quel che conta non è la bravura individuale, ma lo scopo che ci si prefigge: innalzare una preghiera di lode e di ringraziamento a Dio, creatore, signore e padre amorevole di tutte le cose, perciò anche dell’istinto del bello, dell’arte, della musica. È giusto che tutto canti le Sue lodi, perché tutto viene da Lui e tutto a Lui deve ritornare: anche il talento artistico, o poetico, o musicale, altro non sono che le note di un concerto che è stato reso possibile solo dalla Sua infinita sapienza e bontà e che a Lui si dirigono, devotamente e giustamente, per testimoniare l’adorazione e la riconoscenza delle Sue creature.
Così, gli architetti delle cattedrali non volevano primeggiare: ciò che si proponevano era di rendere gloria a Dio e celebrare la di Lui grandezza. Come recita il «Cantico delle creature» di San Francesco d’Assisi: «Altissimu, onnipotente, bon Signore, / tue so’ le laude, la gloria e l’honore et honne benedictione. / Ad te solo, Altissimo, se konfàno et nullu homo éne dignu te mentovare». La gloria spetta a Dio, non agli uomini; le creature sono lodate perché rispecchiano la bellezza, lo splendore e la bontà del Creatore, non già in se stesse. Così sentiva e pensava l’uomo medievale: così egli vedeva il mondo, la vita terrena, e anche l’espressione della bellezza prodotta dalle mani dell’uomo: perché nessuno, allora (e anche in seguito, almeno fino ad Hegel), si era mai sognato di pensare che l’arte potesse essere qualcosa di diverso dall’arte bella; a nessuno, prima di quella particolare malattia che si chiama modernità, era venuto in mente che l’arte possa essere anche l’espressione del brutto. Semmai, la bruttezza intenzionale era percepita come lo sghignazzo del Demonio: e così la rappresentavano lo scultore o il pittore nelle chiese, quale monito contro le potenze dell’Inferno, nemiche dell’uomo e invidiose della sua amicizia con Dio.
Ma quei tempi sono cambiati, sono finiti. Con l’Umanesimo, l’uomo incomincia a lodare se stesso e a celebrare la bellezza delle cose e del mondo non in quanto creature, ma in quanto realtà autonome, dotate di piena dignità per se stesse; con il Rinascimento, ad allentare o a rescindere tacitamente i legami con il Creatore (dov’è Dio nei due massimi scrittori del 1500, Ariosto e Machiavelli?), ad esasperare il concetto della propria autosufficienza, a sentirsi padrone e misura di tutto ciò che esiste sulla terra (e del Cielo, ormai, poco si ricorda); con la Rivoluzione scientifica, a ritenersi capace, beninteso se scienziato e matematico, di leggere i segreti del gran libro della Natura, e di conoscerne alcune proposizioni — quelle della matematica — con lo stesso grado di precisione e di con cui le conosce Dio stesso (ossia intensive, come non si perita di affermare Galilei); con l’Illuminismo, a giudicare che la Ragione umana è strumento perfettamente adeguato non solo a conoscere il vero, ma a cambiare il mondo, a perfezionare l’opera della natura, a sostituirsi al disegno di Dio, ridotto, quest’ultimo, ad un grande ma remoto e silenzioso Architetto, il quale, dopo aver dato avvio e movimento al gigantesco meccanismo dell’universo, lascia poi che tale movimento procedere da solo, senza più intervenirvi in alcun modo.
Scompare, così, di fatto, il concetto di Provvidenza; ed è logico: che altro è la Provvidenza, se non la presenza costante e amorevole di Dio nella vicenda umana? Ma Dio non è più Amore, è diventato un Architetto, cioè uno Scienziato pure Lui: e lo Scienziato non interviene nella propria opera, dopo che l’ha terminata; si limita ad osservarla, con occhio freddo e distaccato. Ancora un secolo, e la Provvidenza cola a picco, letteralmente: è la sorte della barca da pesca della famiglia Toscano, ne «I Malavoglia»: non si chiama essa, forse, Provvidenza? E non è vero che, a partire da quel naufragio, le disgrazie incominciano ad accanirsi contro quei poveri pescatori? Eppure, non più di quarant’anni prima, Manzoni aveva fatto della Provvidenza il vero protagonista de «I promessi sposi». Che cosa è dunque accaduto? È accaduto, come avrebbe detto il buon Verga (e non certo con una sottintesa ammirazione, tutto al contrario) che è avanzata, travolgente, irresistibile, la grande novità del mondo moderno: la fiumana del progresso. Spazzando via ogni cosa davanti a sé: ogni cosa che non serva al suo disegno di potenza. Disegno di potenza che parte da lontano: almeno da quella formula di Francis Bacon, «Knowledge is Power», «Sapere è potere», che tiene a battesimo la cosiddetta Rivoluzione scientifica del XVII secolo e inaugura le magnifiche sorti e progressive che culmineranno nella manipolazione genetica, nella fecondazione eterologa e nella clonazione.
Nel corso del tempo, dunque, gli artisti hanno seguito queste linee di tendenza generali, rispecchiando, nel loro modo di intendere la propria opera, le idee del loro tempo; ben pochi di essi hanno fatto eccezione alla regola di uniformarsi al sentire generale degli altri intellettuali, e specialmente di quelli ritenuti i più autorevoli nel definire che cosa sia il reale e quali siano le strade idonee per giungere alla sua conoscenza: vale a dire dei teologi e dei filosofi sino al XVII secolo, degli scienziati e dei matematici a partire da quell’epoca. Perché l’artista raramente è un intellettuale nel senso specifico del termine: egli può anche essere un genio nel proprio ambito espressivo, ma, per quanto riguarda la struttura generale di pensiero entro la quale si muove, e per quanto concerne i presupposti culturali dai quali prende avvio la sua opera, solitamente egli non si discosta affatto dalle opinioni comuni del proprio tempo, che sono state fissate, appunto, da filosofi e scienziati.
Ma ecco che, agli albori del XVIII secolo, un artista, un musicista, un virtuoso dell’organo, che è anche un sommo compositore (ma questo sostanziale dettaglio i suoi contemporanei lo ignorano, o, per meglio dire, preferiscono ignorarlo), fa irruzione con la possanza di un mare dalle onde maestose e tranquille, e innalza la musica del suo tempo ai livelli più eccelsi mai raggiunti: per dire il vero, la innalza non solo nel contesto del suo tempo, ma per tutta l’eternità. E Bach, questo genio assoluto, impareggiabile (e largamente incompreso, o snobbato, o addirittura ignorato dai colleghi e dal pubblico del suo tempo), sente e pensa ancora come un artista pienamente medievale, cioè pienamente ed esplicitamente religioso. Egli non si considera affatto come il vero e solo autore delle "sue" innumerevoli composizioni, ma come l’umile e volonteroso artigiano che presta la sua mente e le sue mani all’opera di Dio, riempiendo uno spartito dopo l’altro e provando poi, alla tastiera, con tutta la sua numerosissima e semplice famiglia, le opere così composte, al solo ed unico scopo di celebrare la magnificenza del Signore, per innalzare ed offrire sino ai piedi sul Suo trono la preghiera e l’invocazione degli uomini.
Le opere così composte — più di 1.000: impressionante! — sono tutte contrassegnate dalla formula «Soli Deo Gloria», che poi è il quinto ed ultimo dei cosiddetti "cinque sola" che caratterizzano la teologia luterana. Gli altri quattro sono: «sola Scriptura» (cioè aprirsi alla Rivelazione per mezzo della sola Bibbia, e non anche — come i cattolici — con la Tradizione, che, pur non essendo attestata dalle Scritture, fa parte della vita della Chiesa fin dalle sue origini); «sola Fide» (cioè la salvezza si consegue con la sola fede, e non anche con le opere buone); «sola Gratia» (cioè si riceve la vita soprannaturale con la sola Grazia divina e non anche con i sacramenti, la preghiera e le pratiche religiose; e infine «solus Christus» (solo Cristo; negando, perciò, il culto dei santi, della Madonna, eccetera). Così chiarita, la formula «Soli Deo Gloria» potrebbe avere qualcosa di angusto, di dottrinario; ma qui sta il bello: perché Bach, come uomo, non sorpassa il tipo comune del suo tempo, coi suoi pregi e le sue limitazioni; quel che lo fa grande, immenso, è l’umiltà della sua fede.
Giustissima, nella sua lineare semplicità, ci pare la chiave del "mistero" dell’arte di Bach offerta da Camillo Tommasi di Vignano (in «Guida alla musica sinfonica», Milano, Mondadori, 1968, p. 42):
«La personalità di Bach, nella sua gigantesca ed irripetibile statura artistica costituisce un mistero. Scarsamente apprezzato dai suoi contemporanei, se non come organista, ignorato per tutto un secolo dopo la morte, oggi trionfa nella Storia della Musica come uno dei più grandi geni che l’umanità abbia mai conosciuto. Ma l’interrogativo che tutti gli studiosi della figura del Grande di Eisenach si pongono è come abbia fatto, nella sua vita monotona e laboriosa, pressato ogni giorno della sua esistenza da pesanti obblighi professionali e familiari, modesto e tranquillo nella sua incessante fatica, ad assurgere a vette di tanta sublime ed immensa arte. E dopo studi e ricerche, dopo volumi e volumi dedicati a lui, dopo disquisizioni e conferenze, dopo saggi e monografie, la risposta di chi si è accostato all’opera del grande Maestro è pressoché unanime: l’arte di Bach è un dono divino.»
La musica sublime di Bach è una delle esemplificazioni più perfette di quali vette possa attingere l’arte, se l’artista sa spogliarsi del proprio io e lasciarsi interamente riempire dalla Grazia; e a quali vette di spiritualità possa accompagnare anche il pubblico, se questo è disposto a fare altrettanto…
Fonte dell'immagine in evidenza: sconosciuta, contattare gli amministratori per chiedere l'attribuzione