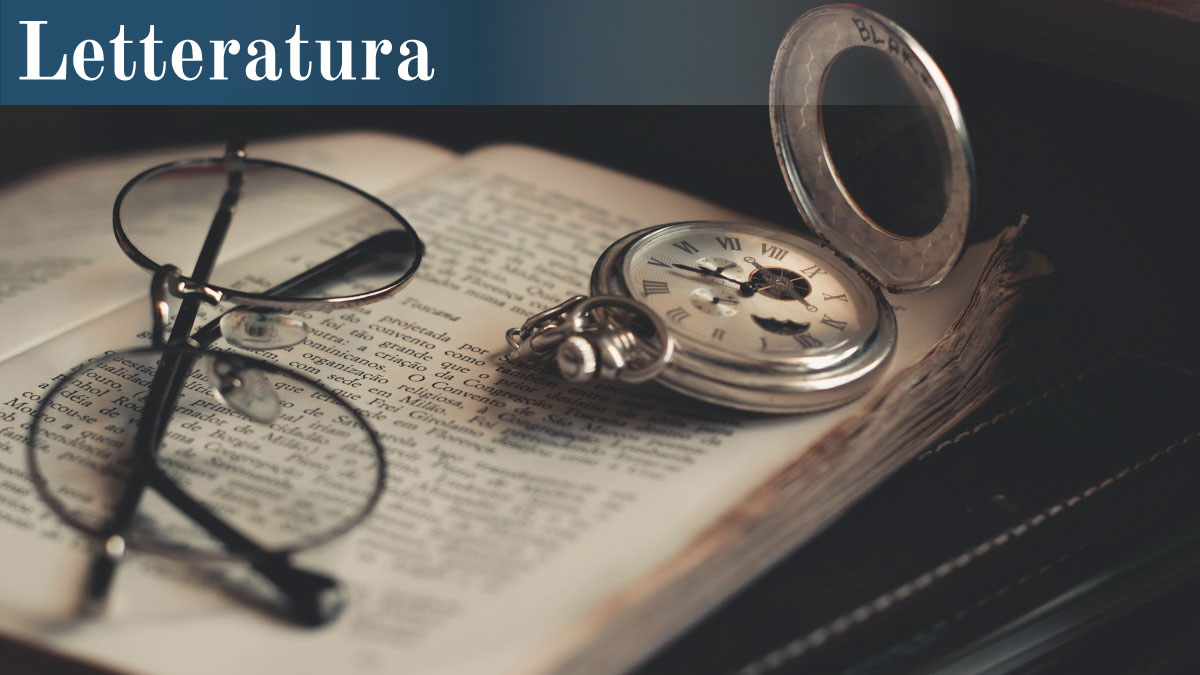Fogazzaro poeta della natura inquietante in chiave quasi espressionista
26 Agosto 2015
L’uomo è chiamato ad agire, la donna ad essere: così i due sessi si completano a vicenda
27 Agosto 2015Da sempre, in un modo o nell’altro, i critici e gli storici della letteratura hanno affrontato la questione della misoginia di August Strindberg, l’autore di opere come «La stanza rossa», «Gli abitanti di Hemsö» e «Inferno», dal punto di vista, sic et simpliciter, di una qualche forma di psicopatologia; e giù a chiedersi, freudianamente, quale trauma infantile, o magari anche in età adulta (una insufficiente dotazione virile?), possa avere spinto il grande romanziere e drammaturgo svedese verso posizioni così aberranti, così ingiuriose, verso il gentil sesso.
È, questa, la logica del più basso conformismo culturale e intellettuale, basato sul ricatto permanente del "politicamente corretto": lo stesso ricatto in base al quale, ad esempio (e sempre restando nell’ambito delle letterature scandinave) non sembra possibile parlare del "caso Knut Hamsun", senza lanciarsi in preventive filippiche contro il suo supposto nazismo (che poi non era affatto tale); e meno male che, ogni tanto, si leva qualche voce critica verso il paradigma dominante, come quella di Roberto Alonge, che ha avanzato, per la Nora di «Casa di bambola», una lettura in chiave non femminista, ma di segno opposto: vedendo nella sua ribellione una protesta contro la scarsa genitorialità della figura del marito, Torvald, reo di non essere stato sufficientemente protettivo verso di lei e, dunque, non abbastanza marito-padre.
Tanto per cominciare, si deve contestare l’equivalenza fra anti-femminismo e misoginia. Strindberg fu certamente, e dichiaratamente, un nemico della sedicente emancipazione femminile; ma ciò basta a fare di lui un misogino? Davvero non c’era neanche una donna, fra le ottantamila persone che sfilarono dietro il suo carro funebre, per rendere omaggio al grande scrittore in occasione del suo ultimo viaggio? È proprio vero che chiunque si opponga all’idea che uomo e donna devono avere gli stessi diritti e le stesse responsabilità, o chiunque vi si sia opposto, come Strindberg, più di un secolo fa, vada senz’altro etichettato come un nemico e uno spregiatore del sesso femminile? Non è questa, forse, una idea tipicamente femminista, una idea tipicamente moderna, che noi oggi diamo per scontata, ma che, a ben guardare, non è affatto tale?
Un buon esempio di lettura "politicamente corretta" di Strindberg è dato da questa pagina di Mario Moretti nella sua «Introduzione» a «La stanza rossa» (Roma, Newton Compton, 1993, pp. 11-13):
«Sulla misoginia di Strindberg è stato detto tutto e il contrario di tutto, e sarebbe difficile riassumere qui le tesi e le contro-tesi di volta in volta enunciate. Tra le svariate interpretazioni del fenomeno non è mancata neppure l’ipotesi fantasiosa di un brillante drammaturgo svedese contemporaneo, Per Olov Enquist, che in un dramma biografico ("La notte delle tribadi") arriva a sostenere che l’avversione di Strindberg per le donne derivava dalla impossibilità di soddisfarle a causa delle dimensioni ridotte del suo organo riproduttore… Ne "La stanza rossa" Strindberg lascia al disincantato Olle Montanus una professione di misoginia. Olle, che viene dalla campagna, ha avuto in passato un bambino da una cameriera e per questo è stato cacciato di casa. Ha dovuto trasferirsi in città, dove fa la fame. "Da allora", dice, "non ho avuto più a che fare con le donne". E ancora: "La donna è un maledetto enigma che nessuno sa sciogliere". Ma Olle non è il solo nemico delle donne, nel romanzo. Borg non è tenero con il gentil sesso: "La maggior parte delle femmine si sposano per passarsela bene senza lavorare, per essere "disponibili". E lo stesso Arvid scrive alla "sua" Beda (la ragazza è in realtà di tutti): "Prima della venuta della donna, cioè prima del paradiso, non c’era inferno sulla terra".E, sempre a proposito di Beda, Arvid dice al filosofo Ygberg: "L’ho amata tanto, quella donna, e lei mi tradiva spudoratamente. Quello che negava a me lo dava a un grosso rigattiere, e sai che cosa mi veniva a raccontare? Che si comportava così perché voleva provarmi con quanta purezza amava me… ". Ma nel 1878 Strindberg, che era sposato con Siri von Essen, la prima moglie, forse l’unica veramente amata, non era ancora quello strenuo avversario del genere femminile che diventerà in seguito. Inoltre, al momento della stesura del romanzo, Siri era incinta. Alla fine de "La stanza rossa" Arvid/Augusti disputa con il suo "doppio", l’ex aspirante attore Rehnhjelm, ora diventato amministratore presso una grande ditta, sulla infedeltà delle donne. Agnes/Beda, si ricorderà, aveva prima tradito Rehnhnjelm, poi Arvid. Rehnhjelm è del tutto negativo, giudica le donne irrecuperabili, mentre Arvid è più possibilista: "Fra dona e donna c’è grande differenza, come tra un angelo e un demonio".
Stando a quanto scrive Guy Vogelweith, il complesso di Edipo fu un problema centrale nella vita privata dello scrittore svedese ed all’origine dei suoi tre divorzi (da Siri von Essen, dalla giornalista austriaca Frida Uhl, dall’attrice svedese Harriet Bosse). Strindberg ama nella donna l’immagine della madre, ma la carne ha i suoi diritti e quando la relazione inizialmente platonica scende verso la soddisfazione del’appetito sessuale, è allora che scoppia la tragedia. In quel momento, Strindberg sa di aver commesso un vero incesto. Ecco quanto scrive August a Siri: "è un’anomalia dell’istinto? Nutro sentimenti perversi, dal momento che mi piace posseder mia madre? È questo l’incesto innocente del cuore?" ("Autodifesa d’un frolle!"). Nel dramma "Sulla strada di Damasco" (1887), il protagonista si mette addirittura al posto di Edipo, quando chiede alla Signora di interpretare il ruolo di Antigone: "Vorrei essere il vostro padre cieco: voi mi condurrete per mano…". E più tardi le dice: "La vostra voce somiglia a quella di mia madre, che è morta…". In un’altra "pièce", "L’Olandese", Strindberg dà alla fatalità dell’incesto un significato che sembra tratto pesantemente dall’ipotesi freudiana:
"MADRE Inchinati davanti all’inevitabile.
OLANDESE: Inevitabile? Siamo dunque ancora al tempo dei Greci, quando il bambino era, ancora prima della nascita, condannato ad uccidere il padre e a sposare la madre?"
Anche non volendo dare eccessiva importanza al perenne autobiografismo strindberghiano, non si tratta di fantasie letterarie. Il 3 ottobre Strindberg scrive alla seconda moglie [la terza], Harriet Bosse, dopo la nascita del loro figlio: "Mia adorata! Tu eri la mia bambina, mia figlia! Ora tu sei mia madre, io sono tuo figlio". E nel romanzo autobiografico del 1886, "Nella camera rossa" (da non confondersi con "la stanza rossa") ecco una perentoria dichiarazione di Jean, il protagonista:
"Jean cercava in lei l’essere incosciente con il quale poter rivivere ancora una volta l’età d’oro dell’infanzia. Voleva riannodare il legame tagliato tra lui e sua madre, poiché l’uomo non può vivere senza la donna…".
Jean Roudaut, in un saggio sull’"Eroccultismo" pubblicato nel ’76 sulla rivista francese "Obliques", scrive: "L’antifemminismo di Strindberg è legato al timore di essere divorato. L’incarico economico che la donna assume nel matrimonio è la pubblica manifestazione del possesso spirituale che esercita sull’uomo. Le relazioni tra uomini e donne si realizzano in termini economici, l’uomo Strindberg ha un puritano orrore dello spreco, dell’amore consumato senza il fine della procreazione. Una volta compiuto l’atto d’amore, la donna deve inserirsi nel meccanismo economico del reddito".
L’amore può essere solo un investimento sul futuro. Ma la donna rivela la sua natura doppia: da una parte la pura anima, dall’altra, una volta sposata, ecco che diventa un corpo divoratore di forze, l’essere demoniaco, la strega, la mangiatrice di sperma. La donna non aspira all’eternità, vive nell’effimero. È moralmente arida e la disciplina borghese del matrimonio consacra questa aridità. La moglie è una puttana sociale, né più né meno come la prostituta che si vende un tanto a notte. L’amore è un combattimento che ha per fine il possesso, ma la lotta è ineguale perché la donna è dotata dei poteri notturni del vampiro. La donna succhia il sangue dell’uomo, forse per risarcirsi di quello che la natura le fa perdere mensilmente.
Come si conciliavano, queste idee aberranti, con il credo progressista di Strindberg, con il suo socialismo più volte riaffermato? E quanto c’era, in esse, del pessimistico pietismo giovanile, e del puritanesimo ancestrale? E all’origine di una così marcata misoginia in che misura avevano influito le sue disastrose esperienze coniugali ed il suo innato, narcisistico bisogno di provocazione? Sarebbe riduttivo formulare interpretazioni definitive. Sta di fatto che Strindberg, nonostante l’ostracismo da parte delle femministe e delle donne colte di mezza Europa, nonostante l’ostilità e le polemiche suscitate da ogni suo intervento — arrivò perfino a pubblicare , ne "La revue blanche", q895 un articolo dal titolo eloquente: "L”infériorité de la femme" — non cessò mai di alimentare lo scandalo intorno alla sua inquieta esistenza.»
Domande, queste ultime sulla inconciliabilità dello Strindberg misogino e di quello progressista, decisamente banali, così come banale è il giudizio moralistico sulle idee «aberranti» di Strindberg; così come banale e meschina è la pretesa di ridurre la misoginia di Strindberg da profondo convincimento, rilevante per la comprensione del suo teatro e della sua narrativa, a semplice "problema" psicologico, o magari psichiatrico, scomodando, tanto per cambiare, il solito armamentario edipico di matrice freudiana: il figlio che non sa staccarsi dalla madre e che finisce per cercare in ogni donna il riflesso di lei, consumando un "colpevole" incesto di cui si punisce spingendo ogni nuova relazione sessuale verso il fallimento. È incredibile che questa cattiva maniera di interpretare i fatti letterari seguiti ad avere credito presso i critici e ad essere tollerata dal pubblico: la si dovrebbe fischiare sonoramente, una volta per tutte, se la nostra cultura non fosse ancora invischiata nella tela di ragno del pansessualismo freudiano. Vendetta postuma delle femministe contro colui che, aveva osato gettare loro il guanto della sfida, in tempi di "emancipazione" trionfante (almeno nei salotti buoni di Svezia e d’Europa) senza sottostare al benché minimo ricatto, né mostrare alcun complesso d’inferiorità.
Tanto vale tornare a giudicare il pessimismo di Leopardi come il diretto e inevitabile risultato dei suoi malanni fisici, o ripetere ancora, insulsamente, che Nietzsche sragionava del superuomo e della volontà di potenza per le conseguenze mentali di una infezione sessuale. A che servono simili "spiegazioni", posto che abbiano un certo qual fondamento di verità? Per uno scrittore o un pensatore, quel che serve sapere non è in qual misura le sue opere siano state condizionate dal dato biografico, fisiologico, sociale (Strindberg: il complessato, il ribelle, perché figlio della serva!), ma, proprio al contrario, in qual misura egli abbia saputo trascendere il dato contingente per innalzarsi al livello di una riflessione universale, che abbia qualcosa da dire a tutti gli uomini, di ogni tempo e a qualsiasi cultura essi appartengano.
E allora: perché non proviamo a mettere da parte il nostro pregiudizio femminista, il nostro riflesso condizionato progressista, e a tornare all’epoca era ancora in pieno svolgimento in cui la battaglia fra questi aspetti della cultura moderna — progressismo, femminismo — e le forze, invero eterogenee, che vi opponevano resistenza, e l’esito della lotta poteva ancora non apparire scontato? Perché non facciamo uno sforzo per mettere da parte quel che crediamo che il nostro sapere abbia acquisito una volta per tutte, per recuperare il senso dinamico della storia, e della storia delle idee in modo particolare, e ad assumere il punto di vista di un intellettuale individualista, controcorrente, insofferente di ogni pastoia, di ogni norma, di ogni moda: insomma di un anarchico viscerale, come era August Strindberg, allergico per costituzione e per temperamento al mondo moderno? Uno che si considerava l’ultimo degli alchimisti, che si sentiva totalmente allergico, totalmente refrattario alla maggior parte delle idee moderne, e che, tutto sommato, si sarebbe sentito più vicino, per moltissime ragioni, al «Manifesto medievalista» di padre Agostino Gemelli, che al «Manifesto futurista» di Filippo Tommaso Marinetti?
Eppure, si dirà, Strindberg era un socialista; e fu a causa del suo socialismo che il suo funerale fu seguito, a Stoccolma, da una fola di ben ottantamila persone! Ora, come mettere d’accordo quella dichiarata fede socialista con le sue idee anti-moderne, la più scandalosa delle quali era, indubbiamente, l’aggressivo, radicale anti-femminismo (che è, si faccia attenzione, cosa alquanto diversa da una pura e semplice "misoginia": sarebbe come definire anti-semita chiunque si azzardi a criticare, ad esempio, la politica dello Stato d’Israele; il che è precisamente quel che accade al giorno d’oggi). Ma Strindberg non era socialista: credeva di esserlo; così come lo credevano, ad esempio, uomini così diversi tra loro, come Jack London o Gabriele D’Annunzio. Il socialismo, ai primi del Novecento, era più di una ideologia: era la promessa di una palingenesi sociale, sentita, oltretutto, come imminente e inevitabile. E chi non avrebbe voluto trovarsi dalla parte giusta degli eventi; chi avrebbe voluto schierarsi a difesa di un ordine sociale — quello borghese, appunto- che appariva non solo inesorabilmente condannato dal progresso, ma profondamente malato e minato in se stesso, perché colpito dalla malattia del dubbio radicale fra i suoi stessi esponenti (si pensi ai Buddenbrook di Thomas Mann, o ai Forsyte di Galsworthy, o agli innumerevoli "inetti" di estrazione borghese di Svevo, Pirandello, Proust, Kafka, Musil).
Jack London, per esempio, si dichiarava socialista; e lo era, in un certo senso: ma solo in un certo senso. Si sentiva dalla parte degli operai sfruttati di Londra o di New York, questo sì; ma pensava, nello stesso tempo, e senza alcun imbarazzo o senso di contraddizione, che, per migliorare la loro condizione, l’uomo bianco avrebbe potuto largamente attingere alle risorse di spazio e di materie prime dell’Africa, dell’Asia o dell’Oceania. E, del resto, non era precisamente quel che pensava anche il "socialista" Giovanni Pascoli, e lo diceva nel teatro di Barga, inneggiando alla conquista italiana della Libia? E non era, in effetti, anche quel che pensava il socialista Antonio Labriola (questo, senza virgolette), convinto, lui pure, come non pochi suoi compagni di fede e di partito, che Ebruco Landolfi (nella sua ottima monografia «Rosso imperiale» definisce come un «imperialista-africanista-nazional-popolare»?
Quante cose crediamo di aver capito, solo perché le abbiamo semplificate, banalizzate, ridotte alla misura della nostra pigrizia intellettuale. In realtà, come un repubblicano statunitense non veeva contraddizione nel fatto di essere un propugnatore della democrazia e anche dei destini imperiali della propria nazione, ad esempio all’epoca della guerra contro la Spagna, così moltissimi socialisti non vedevano alcuna contraddizione tra il loro progressismo ed altri atteggiamenti, che noi, oggi, siamo soliti etichettare come «conservatori», o addirittura «reazionari», ma che, un secolo fa, tali non apparivano, o non apparivano a tutti: e l’avversione al femminismo era certamente uno di questi ultimi. Dunque, a guardare le cose nella giusta prospettiva storica, si scoprirà che non c’è proprio niente di strano nel fatto che Strindberg si sentisse un seguace del progresso, in senso positivista e naturalista, e, nel medesimo tempo, un fiero nemico dell’emancipazione femminile, così come anche di altri aspetti della società e della cultura moderne, compresi alcuni che, secondo la nostra logica, non si possono in alcun modo conciliare con la credenza nell’occulto o nell’alchimia, credenza che, per un uomo come Strindberg, era invece del tutto naturale.
Erano gli anni della teosofia, del resto; della teosofia e dell’antropologia: e occorre ricordare quale potente influenza abbia avuto quel movimento di pensiero anche sulla cultura e sulla poesia di casa nostra, ad esempio su Arturo Onofri, così compenetrato, nella sua ultima fase, dalle idee di Rudolf Steiner? Crediamo di aver capito tutto della modernità, e invece abbiamo compreso ben poco; crediamo di poter tracciare una linea netta per dividere ciò che è moderno da ciò che non lo è, e dimentichiamo che ci fu un periodo storico — dal quale, forse, neppure oggi siano interamente usciti — in cui quella linea divisoria non era affatto così agevolmente riconoscibile; e in cui, per esempio, era possibile, possibilissimo, essere amici del progresso e nemici della cosiddetta emancipazione femminile.
La realtà è più complessa e problematica di come amiamo rappresentarcela; e la storia delle idee del Novecento è molto più intricata e, se si vuole, contraddittoria, di quanto non siamo disposti ad ammettere. E ciò vale per ogni ambito del pensiero e dell’azione, ivi comprese le dottrine politiche e i sistemi di governo: ad esempio, per il fascismo e la sua più originale creazione nell’ambito economico, il corporativismo: come non vedere che si trattò di un fenomeno storico che aveva in sé, inestricabilmente mescolati, elementi di "destra" e di "sinistra", stante la sua duplice vocazione ideologica, anticomunista e anticapitalista? Ma questo è un altro discorso, che ci porterebbe troppo lontano dal nostro assunto iniziale, e che richiederebbe molto più spazio di quanto possiamo disporre in questa sede. Pertanto qui ci fermiamo, e facciamo ritorno al mondo poetico dell’autore di drammi come «La signorina Julie» o di romanzi come «La stanza rossa».
A noi basta aver suggerito una nuova chiave di lettura per affrontare il "problema", ammesso che sia tale, dell’anti-femminismo di Strindberg. E adesso, buona lettura a chi lo voglia riprende in mano: a cominciare da quella novella, «La casa delle bambole», da lui scritta in aperta polemica con la «Casa di bambola» di Henrik Ibsen, che (molto probabilmente a torto, ironia delle cose!), aveva entusiasmato ed elettrizzato le femministe di mezzo mondo, insieme ai loro simpatizzanti di sesso maschile e di convinzioni debitamente "progressiste".
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels