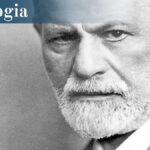
Franco Basaglia? Un grande psichiatra, un cattivo filosofo, un pessimo maestro
17 Agosto 2015
Ribellione di Chamula del 1869: come la scoperta di tre “pietre cadute dal cielo” scatenò l’ultima grande rivolta maya del Chiapas
18 Agosto 2015Le città, nel corso degli ultimi decenni — ma è un processo che parte da molto lontano: almeno dalla Rivoluzione industriale – sono diventate cupe, ostili, stanche, rassegnate, disumane; e intanto, parallelamente, sono cambiati anche i loro abitanti, al punto che si è verificata, in essi, una vera e propria mutazione antropologica. Non sentono, né pensano più allo stesso modo; non si comportano come un tempo; non compiono gli stessi gesti, non sperano o temono più le stesse cose: perfino il loro modo di camminare, di guardare, di sedersi, è diventato un altro.
Gli abitanti delle città sono divenuti straniti, guardinghi, preoccupati: diffidano di tutto, perché la città che era la loro madre, è diventata una matrigna: tetra, fredda, arcigna, incomprensibile; prima si fidavano di lei, ora non più; non si vedono più bambini da soli, e anche gli anziani si trascinano quasi di soppiatto. Le cronache ce ne spiegano la ragione: i vecchi sono diventati il bersaglio preferito di una microcriminalità dilagante, spietata: per rubare una collana, per strappare una borsa, non si esita a gettare una signora di settant’anni sull’asfalto.
D’estate, col calore infuocato, nemmeno di notte si tira un respiro: le finestre e i balconi sono ermeticamente sbarrati, gli inquilini boccheggiano nelle lenzuola sudate, ma non osano alzare la persiana neanche di pochi centimetri. I ladri penetrano dappertutto, negli appartamenti vuoti e in quelli abitati: e non soltanto rubano, ma sporcano, rompono, picchiano, stuprano. Dopo di che, i soliti sociologi progressisti li giustificano e i soliti giudici buonisti li rimettono in libertà entro ventiquattr’ore dall’arresto — nei rari casi in cui vengono presi -, affermando che hanno agito in condizioni di disagio e che non rappresentano un vero pericolo sociale.
Le città sono cambiate sia dal punto di vista architettonico, sia funzionale, sia culturale. Non sono più agglomerati organici di famiglie e di commercianti: sono diventate, tutt’al più, anonimi dormitori, ma spesso nemmeno quello, dato che la sera si svuotano e in centro restano solo quattro anziani: uffici e banche lavorano di giorno, poi spengono le luci e arrivederci a domani. Le città erano soprattutto luoghi di piccolo commercio: ma le botteghe hanno dovuto chiudere, una dopo l’altra, e così le edicole, le trattorie, i calzolai, le osterie di quartiere, le tipografie, le macellerie, persino le farmacie: le hanno uccise le mutate abitudini delle persone, la scomparsa della socialità, le tasse esorbitanti e la concorrenza dei centri commerciali, infine l’invasione dei supermercati cinesi. Le città erano anche dei luoghi di cultura: non solo quelle universitarie, anche le città piccole e medie; cultura nel senso più ampio del termine, compresa la valorizzazione delle tradizioni, del territorio, dell’arte, della storia locale. Vi era interesse intorno agli eventi che promuovevano questo tipo di sensibilità: ora non più. In compenso, professionisti della politica cercano di riempire questo vuoto, accaparrandosi voti in nome dell’identità e della tradizione: ma non si fa politica seria dove non c’è cultura; e non c’è cultura dove non c’è amore per le proprie radici.
Per dare il colpo di grazia alla progressiva disumanizzazione delle nostre città, abbandonate alla mercé di architetti presuntuosi e di amministratori insensibili, che hanno sventrato, demolito, ricostruito e cementificato a loro piacere, speculando su tutto, come un’orda di barbari, è arrivato il fenomeno quasi improvviso, diluviale, inarrestabile dell’invasione straniera, portando con sé un aumento spaventoso del degrado, della sporcizia sistematica, della rumorosità insopportabile, dello spaccio di droga, della prostituzione nelle sue forme più varie, della criminalità spicciola e di quella organizzata. Abbiamo detto "invasione" e non ce ne pentiamo, non è stata una svista o uno scatto di nervi: non esiste un altro termine per dirla. Quando arrivano, nell’arco di due o tre decenni, milioni e milioni di persone da non si sa dove, molte delle quali ben decise a non integrarsi, molte delle quali assolutamente irregolari, senza permessi, senza controlli sanitari, senza rispetto per il Paese che le accoglie, anzi, in certi casi, con lo scopo preciso di importarvi il terrorismo, quale altra espressione si dovrebbe adoperare? E nessuno ha chiesto il parere dei nostri cittadini; a nessuno è stato domandato se sia d’accordo. I governi e i prefetti hanno detto che è giusto così; la Chiesa, o una parte di essa, ha aggiunto, per soprammercato, che l’accoglienza è un "dovere" e che avanzare dubbi o perplessità è "razzismo", cioè un peccato grave.
Ci piace riportare le osservazioni fatte da Isabella Bossi Fedrigotti – relative a Milano, città-simbolo di questa trasformazione -, dall’articolo «La città madre di Sofonia è diventata matrigna» (in: «La Bibbia per la famiglia», a cura di G. Ravasi, Alba, Edizioni San Paolo, 1993, vol. 8, p. 320):
«Ho l’impressione che la città madre (quella cui allude, simbolicamente, Sofonia, in 3, 14-15): "Gioisci, figlia di Sion; rallegrati, Israele; gioisci ed esulta di tutti cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha cancellato i decreti della tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Il Signore, re d’Israele, è in mezzo a te, non avrai più da temere la sventura"), non ci sia più. Io almeno la sento così: non ho più una città in cui sentirmi figlia, protetta, al sicuro. È diventata troppo grande Milano, troppo brutta, troppo inselvatichita, troppo aggressiva per essere ancora madre di qualcuno dei suoi abitanti. Un tempo non era così. Mi dava l’idea, grazie ai venticinque anni che ci vivo, di essermi casa, anche più casa della mia vera che ho lasciato in campagna. Era calda — o mi immaginavo che lo fosse? -, era viva, generosa e, soprattutto, mi era nota di quella notorietà che dà sicurezza e piacere di rivedersi.
Scendevo dall’alto delle scale della stazione centrale e già andavo a precipizio, convinta di aver perso qualcosa durante l’assenza, felice di risentire le voci, di reincontrare la folla che mi sembrava più familiare dei miei pochi e via via più estranei compaesani di campagna. Adesso anche vado a precipizio, ma per non rischiare di essere presa di mira, borseggiata, e la stazione mi pare un antro, non più capolinea di una città, ma luogo di insidie evidenti e nascoste, luogo di degrado che annuncia in piccolo quello grande della città.
E poi la città è come se non avesse più case, con porte, finestre e portinaie, ma solo uffici, negozi, banche e bar. Come se nessuno più abitasse e vivesse, ma stessero tutti nascosti da qualche parte, che non si sa. Sparita l’anima, insomma, restano soltanto vetrine, chilometri di vetrine, sempre nuove, che trasformano le strade e le rendono irriconoscibili. Dove rifugiarsi allora se si dovesse stare male, se si dovesse essere inseguiti, disturbati, assaliti? Forse in un negozio, in un bar o in una banca? Restano le chiese, che sono tante, ma fanno ormai orari di ufficio, per cui sono sbarrate per gran parte del giorno. Nemmeno sulle panchine si può sostare, perché subito ti guardano come uno fuori posto, malato, disturbato o barbone. Dei giardini, non nemmeno parlare, a loro volta non più verdi, paterni, freschi e riposanti, ma secchi, maltenuti e mal visitati, mercato di droga rischioso come il bosco dei banditi. O almeno così mi sembra.
Ma che sia un sentimento diffuso lo prova il comportamento dei vecchi, o, meglio ancora, quello delle vecchie. Essendo tra tutti le più deboli e indifese — peggio di loro solo i bambini, ma nessuno li lascia uscire da soli — le vedo camminare guardinghe, raccolte in sé, la borsa stretta, come se volessero farsi notare il meno possibile. Se rivolgi loro la parola, vedi che pensano subito al peggio, – assalto, furto, offesa, inganno — e ti fissano con silenziosi occhi duri e spaventati. In altri tempi, invece che con i passettini cauti e misurati di oggi, mi pare di ricordare che camminassero per le strade più leggere, più spensierate, fermandosi a salutare, a chiacchierare e a guardarsi intorno.
Non sono più madri le città, ampie, calorose e accoglienti, ma matrigne che fanno stare eternamene sul chi vive i loro figli. Basta andare nei piccoli centri — si potrebbe pensare allora — per ritrovare il caldo abbraccio d’un tempo, ma non è vero, anche i piccoli centri delle province hanno ormai lo stesso cuore freddo e secco. Perché anche lì, forse soprattutto lì, le grandi superfici commerciali, gli ipermercati con annessa discoteca, la fila ininterrotta delle boutique e dei negozi di moda si sono bevuta l’anima delle città. E dunque anche gli abitanti figli finiscono per vagare spaventati tra portici e piazze, estranei, solitari, come chi non ha più né famiglia né casa.
Anche se oggi avrebbero un significato soltanto simbolico, si sarebbe a volte tentati di rimpiangere le grosse mura che un tempo circondavano le città. Non servirebbero, infatti, a chiudere fuori nessuno, né è questo che si vorrebbe, ma forse la loro forza, la loro rotondità come di potente abbraccio riuscirebbe a infondere un po’ di sicurezza. Con la loro grande ombra darebbero un senso di protezione, nascondendoci allo sguardo del nemico e a quello, ancora più acuto, della morte. Come una madre insomma che cerca di consolare i figli anche a costo di ingannarli un poco.»
Si tratta di osservazioni risalenti a più di vent’anni fa, quando il fenomeno della invasione straniera stava incominciando appena a manifestarsi e pochissimi fra noi, crediamo, immaginavano che sarebbe andato crescendo in progressione geometrica, all’infinito, alterando radicalmente la stessa composizione etnica e l’anima delle nostre città e dei nostri paesi.
Qualcuno potrebbe pensare che è esagerato paragonare la città a una madre, per poi trarre un giudizio negativo sulla evoluzione delle città negli ultimi decenni. Noi non lo crediamo, e per una ragione molto semplice: abbiamo visto e vissuto quell’epoca, non poi così remota, in cui le nostre città erano, effettivamente, simili a delle madri, per i loro abitanti. Non che tutto fosse rose e fiori: ma è fuori di dubbio che esisteva un tenero legame di affetto, un senso di fiducia, un diffuso star bene delle persone con i luoghi, con le case, con le botteghe, con le osterie, con le parrocchie. Pur nella fatica del lavoro, andare al lavoro era piacevole, perché ci si sentiva avvolti da una atmosfera amica; e ancora più gradito era uscire dal lavoro e incontrare gli amici, chiacchierare davanti a un calice di vino e sotto un pergolato di vite selvatica, godersi il fresco sfogliando il giornale o concedendosi la spensieratezza di una partita a carte.
Non stiamo parlando in un tempo favoloso, come quello delle fiabe: stiamo parlando di un tempo reale, storicamente esistito e cronologicamente non molto lontano. Un tempo felice che, forse, non abbiamo saputo apprezzare abbastanza: se lo avessimo apprezzato, lo avremmo difeso con le unghie e con i denti. Non avremmo ceduto così repentinamente alle sirene del consumismo; non avremmo tradito la bottega di quartiere per il supermercato cinese. Avremmo saputo che le cose hanno un valore che va oltre quello meramente economico; e che le relazioni sociali, quando possono esplicarsi in una maniera veramente umana, non hanno prezzo. Ingozzarsi con un hamburger e una Coca-Cola al tavolo di McDonald’s, e poi tornare di corsa in ufficio, non è da esseri umani, ma da bestie: abbiamo preferito una vita bestiale ad una vita a misura d’uomo. Abbiamo fatto dei calcoli meschini, e ora ne paghiamo le salatissime conseguenze. Peggio per noi.
Certo, non è stata solo colpa nostra. La nostra colpa è stata l’ignoranza, la mancanza di consapevolezza; altri hanno colpe assai più gravi, perché sapevano e capivano. Il mostruoso potere finanziario che sta dietro a tutti questi fenomeni, a queste mutazioni, porta le responsabilità maggiori; e poi, a cascata, gli economisti, i politici, gli amministratori pubblici. Degli uomini di cultura, meglio non parlare; e poi, ce ne sono ancora? Probabilmente è una specie in via di estinzione. In compenso, siamo pieni di "intellettuali": volonterosi tamburini del potere di turno, sempre pronti a intonare il peana per il vincitore del momento.
A questo punto, una semplice domanda: c’è ancora qualche speranza? Contrariamente a quel che dicono, in coro, i professionisti della sventura, noi pensiamo di sì; e aggiungiamo subito: anche se sarà maledettamente difficile. Tornare indietro in cerca della via giusta, quando ci si accorge di avere imboccato un sentiero sbagliato, teoricamente è sempre possibile. Solo che richiede molta umiltà; per non parlare degli interessi economici che favoriscono l’errore e scoraggiano la verità. Ma come potrebbe essere altrimenti? Le cose giuste e vere, richiedono sempre sacrificio; sono le menzogne che camminano con passo agile e leggero. E non diamo sempre la colpa ai poteri occulti (benché essi, certamente, esistano); non giustifichiamo in anticipo la nostra inerzia e la nostra viltà con la solita storia che noi, singolarmente presi, possiamo fare ben poco. È solo una mezza verità: dunque, una menzogna. Certo, nessuno di noi potrà invertire una tendenza sbagliata e distruttiva: ma la società è fatta di tante persone. E anche i buoni esempi, non solo i cattivi, possono diffondersi veloci come il vento. Quando una bella idea afferra l’anima, nessuno ostacolo riesce più a fermarla. Bastano un po’ di coraggio, e la capacità di vivere ad occhi aperti, senza ripetere formule precotte…
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Mike Chai from Pexels
