
Ettore Luccini e il debito culturale dei comunisti verso il fascismo di sinistra
29 Luglio 2015
La legge naturale è inscritta nella coscienza perché possa distinguere il bene dal male
29 Luglio 2015J. V. Jensen esalta lo spirito dell’uomo nordico, ma si contraddice esaltando anche la modernità
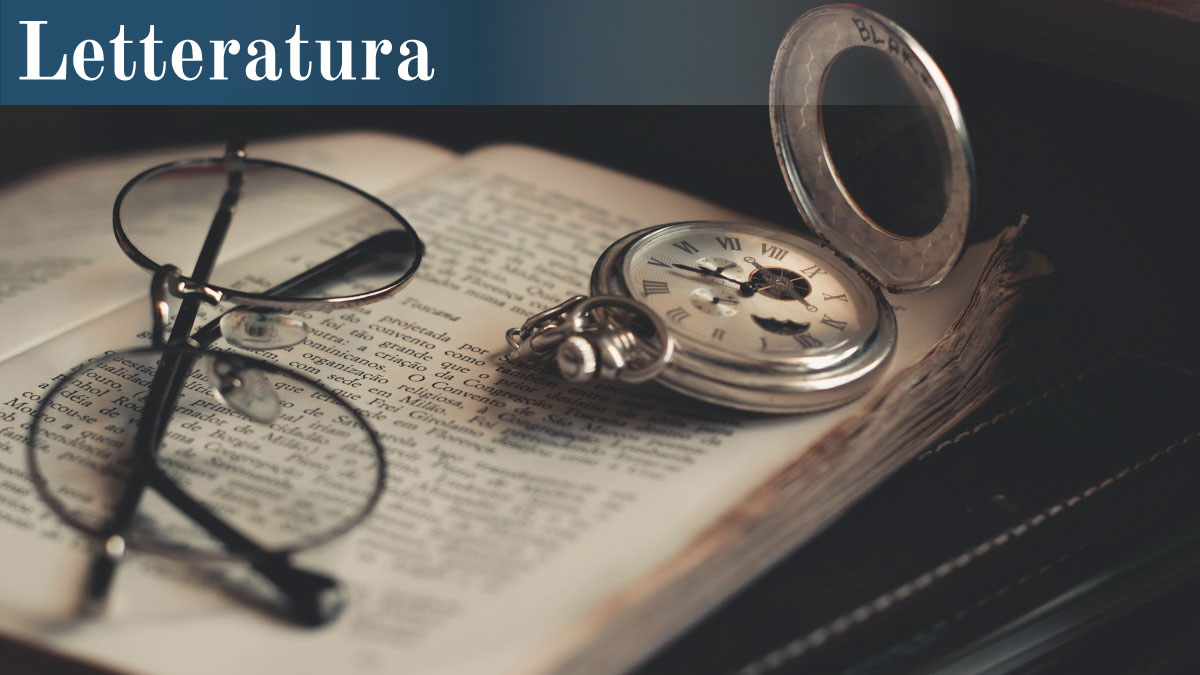
Nel percorso letterario e speculativo di Johannes Vilhelm Jensen (Farso, 1873-Copenaghen, 1950) si compendia buona parte della stagione culturale e spirituale attraversata dalle società dell’Europa settentrionale nella prima metà del Novecento, sotto il segno prevalente del Decadentismo e delle correnti e dei movimenti che a questo si accompagnano, si contrappongono, s’intersecano, non senza richiami naturalistici e perfino suggestioni misticheggianti che provengono, più che dal luteranesimo, dalle radici pre-cristiane di quel mondo nordico, pagane, intrecciate, a loro volta, invero assai curiosamente, con il nuovo Verbo darwiniano e con le teorie biologiche sulla razza, che tanta parte hanno avuto — e così discutibile — nello sviluppo di talune ideologie politiche, oltre che nel delineare il panorama culturale complessivo di quegli anni.
Jensen è un danese della parte settentrionale dello Jutland, lo Himmerland: una terra dura, sabbiosa, dal clima aspro, flagellata dalle burrasche del Mare del Nord e gravata dalle nebbie; una terra che sembra protendersi verso la fine del mondo, e che è stata, anticamente, la culla di popoli intrepidi e vigorosi: i Cimbri che osarono perfino invadere i territori di Roma, finendo massacrati dalla spada di Caio Mario; gli Iuti che, insieme agli Angli e ai Sassoni, invasero le Isole Britanniche dopo la partenza delle legioni e riuscirono a stabilire in quell’isola la famosa Eptarchia, l’insieme dei sette regni germanici che sopravvissero per circa quattro secoli, dalla metà del V alla metà del IX secolo; infine i Vichinghi, che invasero a loro volta l’Inghilterra, ne dominarono una parte, e si slanciarono alla conquista di vaste zone d’Europa, da un capo all’altro del continente, spingendosi, con le loro ardite navigazioni, fino all’Islanda, alla Groenlandia, al Nord America.
Jensen (che non va assolutamente confuso con lo scrittore tedesco, nativo dello Holstein e appartenente alla generazione precedente, 1837-1911, dal nome quasi uguale: Wilhelm Jensen, il cui romanzo più conosciuto, «Gradiva», apparso nel 1903, suscitò tanto interesse in Sigmund Freud, da suggerirgliene una minuziosa interpretazione psico-analitica) era figlio di un chirurgo veterinario e, da bambino, era stato abituato ad accompagnare il padre nelle sue visite alle fattorie sparse ed isolate, contraendo quell’amore intenso per la natura, per gli animali, per le piante, ma anche per la scienza — aveva intrapreso gli studi di medicina, a Copenaghen, prima di interromperli e dedicarsi interamente alla letteratura -, che tanto sarà presente nella sua opera di scrittore e che non lo avrebbe mai più abbandonato.
Il premio Nobel, conferitogli (forse, ma non è stato certo l’unico caso, anche per ragioni estranee alla letteratura, nel 1944, in uno dei momenti più oscuri della storia danese moderna, cioè durante l’occupazione nazista, ponendolo implicitamente in contrapposizione al norvegese Knut Hamsun, che lo aveva ricevuto nel 1920 e che adesso aveva scelto di aderire alla causa hitleriana) ha rivelato al pubblico internazionale questo scrittore danese finora poco conosciuto fuori della sua patria – e con ragione, viste certe sue posizioni non solo nazionaliste e scioviniste, ma francamente razziste, basate sull’idea di una superiorità intrinseca, biologica, dei popoli nordici e sul fatto che essi soltanto avrebbero dato un reale contributo al progresso tecnico e materiale dell’Europa e del mondo -, che possiede, insieme, il vigore d’un Verga e la sensibilità visionaria d’un Segantini.
Ha scritto Giovanni Bach nella premessa della sua tradizione dei racconti dello scrittore danese (da: Johannes Vilhelm Jensen, «Racconti», Milano, Fratelli Fabbri Editori, 1968, pp. 8-11):
«Durante la guerra coloniale del 1898 inizia la sua prima esperienza giornalistica, quale inviato speciale in Spagna di un giornale della capitale; successivamente lavora per altri giornali in Francia, Inghilterra e Norvegia. Sono questi, anni di intenso noviziato per il grande pensatore, che nel libro "Il Rinascimento gotico" (1901) raccoglie le sue esperienze giornalistiche orientandole tutte verso una interpretazione etnico-sociologica della realtà contemporanea. Egli infatti addita l’inferiorità dei popoli neolatini o meridionali e la funzione di guida nel mondo occidentale, delle stirpi "gotiche", discendenti dal ceppo iuto-anglosassone (Danesi, Scandinavi, Inglesi, Tedeschi e Nord-Americani). I successivi viaggi in India, Cina e America ampliano ulteriormente questa visione storica dell’eterna rinascenza gotica, dato che Jensen esalta nel moderno sviluppo tecnologico americano il più recente stadio della superiorità nordica.
L’ideologia si approfondisce negli anni di meditazione, successivi alla sua definitiva dimora a Copenaghen (1904), ed ispira un’altra opera programmatica ("Il nuobo mondo", 1907) e i romanzi "Madame d’Ora" (1904) e "La ruota" (1905). Dall’esperienza nei paesi lontani nascono pure i libri "Intermezzo" (1899), "I boschi" (1904), "Racconti esotici" (1909) e "Novelle di Singapore" (1907). Ma nel vigoroso romanzo, "La caduta del re" (1901), ritorna il tema primordiale della natura, caro agli anni giovanili dell’autore. Jensen vede, nella caduta del re Cristiano II, avvenuta all’epoca della Riforma, anche il tramonto della nazione danese, nei secoli successivi soggetta a lento declino.
La teoria della superiorità gotica, ridimensionata, sotto l’influsso di Darwin, a livello della storia bio-sociale di tutta l’umanità, ispira il vasto ciclo narrativo dal titolo "Il lungo viaggio" (1908-22), comprendente sei romanzi: "Il ghiacciaio" (1908), "La nave" (10912), "La terra perduta" (1919), "L’ospite di Norne" (1919), "Cristoforo Colombo" (1922), "La spedizione cimbrica" (1922). È una vasta epopea nordica architettata su presunte certezze scientifiche e non priva di incongruenze; tuttavia affascina per quei vasti orizzonti sui quali si agita, dalle origine preistoriche alle soglie della civiltà occidentale, l’uomo nordico che insegue sempre nuovi ideali di conquista, proprio come Cristoforo Colombo alla conquista dell’America, tanto più che l’autore lo ritiene discendente da quei Cimbri che occuparono l’Italia prima di Cristo. Il ciclo mistico-storico, nonostante il dubbio valore artistico, ottiene dubbi consensi e le teorie darwiniane ispirano sia i saggi a carattere speculativo ("Cronaca", "Evoluzione e morale", "La trasformazione degli animali", "Stadi spirituali", "Direttive del tempo"), sia gli ultimi romanzi ("Le tentazioni del dottor Renault", 1935 e "Gudrun, una ragazza danese", 1936). […]
Quando, nel 1944, ossia pochi anni prima della morte (1950), viene conferito a Jensen il Premio Nobel per la Letteratura, il mondo vede in lui consacrato il cantore della sua terra gloriosa proprio negli anni dell’eroica resistenza. È questo, per così dire, il simbolo della rinascenza umana e spirituale di quel popolo da lui tanto amato e di quella terra che ha attinto nei secoli lontani la sua nuova forza. Ma né le opere programmatiche, né i romanzi a tesi hanno valso a Jensen il massimo premio mondiale, bensì la raccolta di "Racconti dello Himmerland" ("Storie della Cimbria"), pubblicati in tre volumi nel 1898, 1904, 1010 e idealmente suggellati dal racconto "Jorgine" (1926).
Nella serie di racconti, sciolti da vincoli strutturali, Jensen rivive le esperienze interiori più profonde, in ideale simbiosi con la terra natale e con gli abitanti dello Jütland. Là egli ritrova la sua anima vera, la sua connaturata e sobria grandezza di uomo che ricerca il senso dell’esistenza in una sacra religione della natura e dell’umanità che, se è priva di orizzonti soprannaturali, si arricchisce però di eredità storiche legate al culto della terra natale. I racconti sono il frutto di un costante, anche se intermittente, ascolto delle voci del subcosciente, lungo l’arco di quasi tutta l’esistenza. Voci nate nella lontana infanzia, che riecheggiano di quando in quando durante gli anni della fatica ideologica, e giungono a materiarsi con creazioni quasi liriche in squarci di vita vera, di cui è protagonista il rude uomo iuto, col suo retaggio di dolore, di silenzio e di amore, sullo sfondo di una terra millenaria, eternata dal flusso e riflusso della vita e della morte.
I "Racconti" non sono mai quadretti di genere o di folclore, ma rappresentazioni immediate, descrizioni essenziali di vita e di caratteri, attraverso una prosa scarna e rapida, che non indulge mai a compiacimenti narrativi o dialettali. Sono storie di uomini e di villaggi che consumano i giorni nell’operosità vivificatrice, nella consapevolezza di una atavica solidarietà fra gli uomini e la terra, in una nobiltà di sentimenti e di azioni che consacra l’arcadica purezza delle stirpi che vivono sotto il pallido sole del Nord. Per l’autore il racconto è un approdo sicuro all’essenza più autentica del proprio "io", una catarsi spirituale che lo libera dalle sovrastrutture ideologiche, una rinascita dei sensi che la civiltà senza volto ha ottenebrato. Nella successione dei racconti il tacito rapporto dell’uomo con la sua terra si fa a volte esasperante e teso, ma la voce del sangue giunge sempre a comporre ogni dissidio ("Notte d’ottobre"; "Cecilia")…»
Oppure si prenda «L’ultimo viaggio di Cristina» (dai «Nuovi racconti dello Himmerland»), nel quale il nipote Christen Sorensen, in mezzo ad un’epica bufera di neve che dura più e più giorni, rendendo pressoché impraticabili le strade e coprendo con quasi dieci metri di neve le case del villaggio, riesce, sfidando l’impossibile, a riportare sopra un carro la bara con il corpo della zia Cristina Smed, affinché la donna, dopo una vita di lavoro e di amore, possa trovare l’eterno riposo nel camposanto del borgo natio, dove tutti coloro che l’hanno conosciuta non hanno potuto fare a meno di volerle bene e di apprezzare la sua generosità e il suo altruismo senza limiti.
Il fatto è che Jensen, anche se scrive pagine commosse sul sentimento religioso, di fatto non lo vive mai dall’interno, perché il soprannaturale gli è estraneo, così come gli è estraneo il cristianesimo, con i suoi concetti di peccato, caduta, grazia e redenzione: egli ha sognato una sorta di resurrezione del paganesimo, come parte di una generale rinascita della cultura nordica e di un radicale ritorno alla terra, al mito, alla tradizione degli avi. Non erano posizioni particolarmente isolate, giacché, in quegli anni, specialmente nell’area germanica e scandinava, non erano affatto pochi gli intellettuali che carezzavano simili fantasticherie e sogni ad occhi aperti; si può anzi affermare che lo stesso neopaganesimo nazista non è stato altro che una di queste forme di revival neopagani, la più vistosa e la più fortunata (in senso politico), perché giunta al potere di una grande nazione moderna; ma qui era fatale che venisse al pettine la contraddizione insita in tali correnti, quella fra tradizione e modernità. Come appunto si verifica in Jensen.
Specialmente dopo il suo soggiorno negli Stati Uniti, Jensen, che ha maturato una sconfinata ammirazione nei confronti di quel popolo e del suo sviluppo, e che ha seguito con simpatia e partecipazione la breve guerra ispano-americana del 1898, vedendovi la conferma delle sue teorie razziste, giunge alla conclusione che solo i popoli anglosassoni e scandinavi sono portatori di vero progresso; ma non si accorge, a quanto pare, che quel progresso, di cui egli stesso esalta la dimensione materiale e tecnologica, è inesorabilmente in contrasto con i valori spirituali, ideali, romantici del suo legame affettivo con la patria danese, con la tradizione vichinga, con il suo paganesimo che, pur essendo decisamente anti-cristiano (nelle sue «Feste dell’anno», 1925, propone addirittura di sostituire i propri canti pagani a quelli cristiani), non è affatto una forma di materialismo, anzi, ne è proprio la recisa negazione.
Ed ecco la doppia contraddizione: quella di esaltare, da un lato, la piccola patria danese, col suo specifico patrimonio identitario, e, dall’altro, la superpotenza americana, cosmopolita, quasi priva di radici, solo debolmente legata al Vecchio Mondo (come se i 3 milioni di Danesi potessero star di fronte ai 100 milioni di Americani senza essere destinati a scomparire, assorbiti nell’abraccio del mondo moderno); e quella fra l’amore per il passato, per il Medioevo, per la natura selvaggia e grandiosa, da una parte, e la fede positivista in un mondo dominato dalla scienza e della tecnica, dai fattori materiali e quantitativi: fino al punto di sostenere che il progresso dei popoli non ha bisogno della cultura e si svolge benissimo al di fuori di essa.
Quest’ultima tesi è sostenuta da Jensen, senza batter ciglio, in saggi ove ritorna alla sua giovanile passione per la biologia e la medicina, e soprattutto al darwinismo, come «Estetica ed evoluzione», del 1923, o come «Evoluzione e morale», del 1925: dimenticando che non si dà alcun progresso fuori dello spirito, ma solo brutale sviluppo, senza scopo e senza ragioni; e ponendosi in conflitto con la sua stessa fede in un mondo fatto non solo di forza e di macchine, ma anche di bellezza, di natura, di ideali. Ed è sconcertante vedere come questo grande scrittore si sia spinto oltre le più estreme forme di primitivismo, fino a una vera e propria esaltazione della "barbarie tecnologica", sposando, in maniera decisamente acritica, la tesi d’un progresso materiale che è fine a se stesso, certo influenzato anche dalle teorie di Oswald Spengler, il quale, negli stessi anni, sosteneva che la civiltà occidentale moderna, stretta nella morsa della declino, ha bisogno più di capitani d’industria che di poeti, e più di acciaio e di cannoni che di arte e filosofia (contraddicendo, peraltro, se stesso, in quanto filosofo della storia).
Come se tutto ciò non bastasse, Jensen, che ha avuto la cattiva idea di farsi saggista e filosofo, tradendo la sua autentica vena di narratore, per far quadrare ad ogni costo il cerchio delle sue strampalate teorie razziali, e per aggiustare quegli elementi storici che discordano da esse e sembrano dar loro torto, non esita a fare ciò che un uomo di cultura, e specialmente un uomo intelligente, non dovrebbe fare ma, assolutamentei: modificare i dati che non gli garbano e stravolgerli a suo piacere. Tanto per fare un esempio: lo scopritore della sua amata America è stato Cristoforo Colombo; ma Colombo, come tutti, o quasi tutti, sanno, è un Italiano, dunque appartiene a una delle disprezzate stirpi dell’Europa meridionale, dalle quali, come egli pensa, non è mai venuto nulla di buono: come fare, dunque? Nessun problema: basta affermare, con la massima serietà, che Colombo non è Italiano, ma "nordico": in base a quale stravagante albero genealogico, non è del tutto chiaro; ma che importa, dopotutto? In fin dei conti, per "pensatori" improvvisati come Jensen, sono le teorie che decidono i fatti, e non viceversa: per cui, se la teoria dell’uomo nordico sostiene che solo dalle razze dell’Europa settentrionale è venuto qualcosa di buono, allora bisognerà ammettere senz’altro che Cristoforo Colombo non poteva essere un latino, ma doveva essere un nordico, per forza. A dimostrarlo, ci si penserà in un secondo tempo — ammesso che sia proprio necessario occuparsi di questo fastidioso e trascurabile dettaglio.
Peccato che un uomo di cultura, il quale voleva fare da guida ai suoi connazionali, si rivelasse poi così miope, così poco coerente e lungimirante, in questioni di così vitale importanza; che un uomo dai vasti studi e dalle vaste letture, come Jensen, non sia riuscito a porsi almeno un poco al di sopra della confusione, del disorientamento, della ridda delle ideologie fallaci, crudeli e ingannevoli che tanto hanno contribuito a fare del "secolo breve" anche il secolo terribile della storia mondiale. È un problema gravissimo, quando i pastori cadono anch’essi in preda ad una qualche forma di accecamento, e conducono il gregge verso luoghi pericolosi, di cui loro, per primi, non hanno la minima idea, pur con tutto il loro sapere e la loro intelligenza. È accaduto a Jensen, ma è accaduto anche a moltissimi altri intellettuali europei di quegli anni.
Forse, la causa di ciò sta proprio nella loro mancanza di umiltà in senso teologico e in senso metafisico; nella loro prometeica, faustiana propensione a vedere nell’essere umano qualche cosa di più d’una creatura, ma anche qualcosa di meno d’un essere morale, che non può vivere degnamente senza conoscere e praticare la distinzione tra il bene e il male.
Forse, la causa di tutto, o di molta parte del traviamento di cui è stato vittima il Novecento, parte da qui: dall’allontanamento della creatura umana dal suo Creatore…
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels