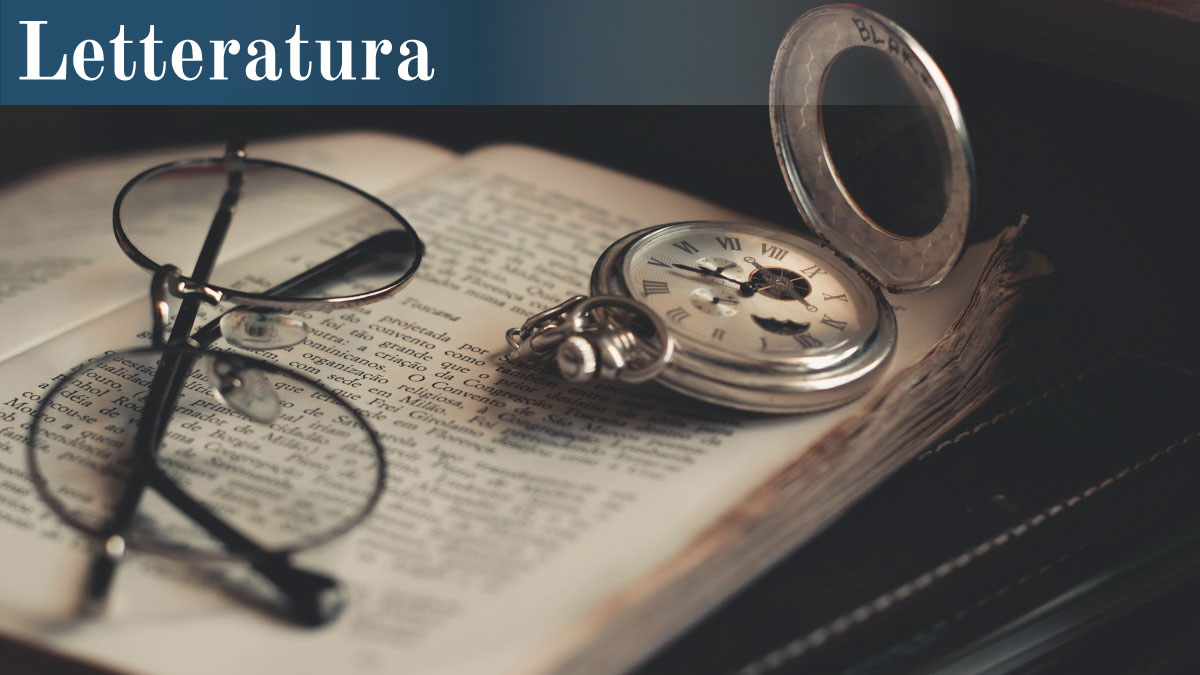Se esiste un mondo spirituale, allora il nostro non è assurdo, ma soltanto enigmatico
28 Luglio 2015
La cacciata dal Paradiso terrestre
28 Luglio 2015Peccato.
Tex Willer è un grande, e nessun lettore intelligente e di buon gusto potrebbe metterlo in dubbio: la sua lunga storia sulle strisce a fumetti scandisce una vera e propria storia del costume nel contesto della storia d’Italia, che da oltre mezzo secolo accompagna milioni di persone nei loro momenti di svago, di divertimento e, perché no, di educazione ai valori della giustizia, della lealtà, dell’amicizia, dell’onore.
Tex è stato un marito esemplare (non si è mai risposato dopo la morte della sua giovane moglie indiana), è un padre esemplare (con suo figlio Kit), un amico esemplare (con Kit Carson e con Tiger Jack), un agente indiano sollecito e incorruttibile, un capo Navajo saggio e valoroso, un tutore della legge astuto e intrepido, un combattente sempre leale e, quando possibile, clemente con i nemici (dà sempre, o quasi, una possibilità di riscatto, o almeno di salvare la pelle, a coloro che si accinge a catturare o a impiombare); e si potrebbe andare avanti ancora a lungo con le sue magnifiche virtù personali e sociali.
È un uomo pratico e quasi prosaico, ma rispetta la religione (altrui) e ha il senso del mistero; è inesorabile e talvolta spietato, quando combatte il male, ma non si disumanizza, non diventa mai del tutto uguale ai suoi feroci avversari; quando gli capita, aiuta le vedove e gli orfani, protegge le minoranze perseguitate, impartisce delle solenni, ma anche pedagogiche lezioni agli sbruffoni e ai prepotenti, però senza infierire: spesso, dopo aver messo al tappeto, in qualche saloon sovraffollato, un piantagrane più grosso di lui, ma più lento e meno sveglio, gli offre la mano per rialzarsi e paga da bere a tutti quanti, assicurando l’oste che il mobilio distrutto verrà prontamente risarcito, o dalla sua vittima, oppure da lui stesso, pagamento in contanti, e via.
In fatto di vedute sociali è un progressista e un democratico, ma senza retorica e senza eccessive semplificazioni ideologiche: sa che tutti gli uomini hanno la stessa dignità, ma sa anche, per esperienza diretta e per spirito d’osservazione, che non in tutti il buon Dio ha distribuito la stessa intelligenza, la stessa prudenza, la stessa propensione all’onestà. Non s’illude che tutti siano naturalmente buoni, e si farebbe una grossa risata se qualcuno gli parlasse di Rousseau e del Buon Selvaggio: lui, che ama gli Indiani, sa che talvolta essi sono ubriaconi, bugiardi, crudeli; lui, che non esita a scazzottarsi per difendere un negro maltrattato, o un cinese picchiato ingiustamente, non si perita, quand’è arrabbiato, di chiamare il primo "muso di carbone" o, espressione ancor peggiore (perché irridente) "palla di neve", e il secondo "sporco muso giallo". Insomma non è razzista, ma poco ci manca.
Politicamente si batte sempre per le cause "giuste": però ha il buon senso di non giudicare in fretta, di non credere a tutto quel che dicono i giornali, per i quali nutre anzi una sana diffidenza, e meno ancora a quel che affermano i politici, verso i quali non nasconde quasi mai un larvato o anche aperto disprezzo; e, quanto agli sceriffi, e più in generale, ai tutori dell’ordine, li rispetta e dà loro credito solo dopo averli vagliati di persona, uno per uno, caso per caso, senza cedere agli stereotipi, e dopo averli chiaramente identificati, senza tanti complimenti e senza alcuna sfumatura, nelle due opposte e inconciliabili categorie dei galantuomini e dei cialtroni.
Quando, nei primissimi numeri («L’eroe del Messico», si trova coinvolto nelle vicende politiche interne messicane e fa amicizia col bandito Montales, che diventa ben presto un patriota, esita a schierarsi apertamente in faccende che, come cittadino americano, non lo riguarderebbero personalmente; e, dopo aver ucciso alcuni soldati messicani per far evadere il suo amico, che era stato fatto prigioniero, promette solennemente che non verserà mai più il sangue di ragazzi in uniforme, ma darà ai suoi amici insorti contro il governo solamente un aiuto indiretto.
Allo stesso modo, sempre nei primi albi, quando scoppia la guerra civile fra gli Stati americani del Nord e quelli del Sud, egli decide, insieme a Carson e ai suoi pards, di rimanere fuori dalla strage spaventosa e si limita a dare la caccia al bandito sudista Quantrill, non in quanto sudista, ma in quanto delinquente comune, e della peggiore specie, il quale, nascondendosi dietro l’uniforme, compie crimini indiscriminati ed è ricercato dalle stesse autorità della Confederazione (vedi l’albo intitolato «L’enigma del feticcio»).
Questa prudenza, questo senso della misura, questo orrore di spargere il sangue di esseri umani che non gli hanno fatto niente di male, e che, magari, agiscono solo per rispetto degli ordini ricevuti, scompaiono in alcuni albi successivi, più "politicamente corretti", nei quali è giocoforza presentare i Sudisti come una massa di bruti amanti della schiavitù (e dimenticando che moltissimi coltivatori sudisti non erano affatto proprietari di schiavi, ma combattevano al solo scopo di difendere la loro terra) e i Nordisti come i vessilliferi della civiltà contro la barbarie, dato che l’abolizionismo è senz’altro la causa della civiltà e in esso non rientrano affatto, come è noto, calcoli di natura economica e finanziaria da parte degli industriali e dei banchieri dell’Unione, ma soltanto e unicamente la preoccupazione umanitaria verso il povero Zio Tom.
Così, nell’albo «Tra due bandiere», Tex abbandona ogni prudenza e si getta apertamente nella mischia dalla parte dei Nordisti, non esita a uccidere i soldati sudisti e, quel che è peggio, lo sceneggiatore non indietreggia davanti ai più vieti stereotipi avversi ai Confederati: fino al punto di abbassarsi a mostrare una inerme famigliola, composta di sole donne e bambini, in balia della soldataglia sudista, o di presentare gli ufficiali confederati come degli autentici bruti. Logico, del resto: come insegnava il buon Carl Schmitt, nel momento in cui ci si appresta a uccidere, bisogna rimuovere il senso di colpa e ogni altro freno inibitore, presentando il nemico come incivile, disumano, mostruoso: sino a farne una caricatura umana, una controfigura del Male. Solo così si potrà spargerne il sangue — sangue di un fratello, nel caso d’una guerra civile, magari nel senso letterale del termine — e non provare vergogna, né rimorso, ma continuare a sentirsi i depositari della causa buona e nobile contro quella cattiva e inescusabile.
Però il culmine del politicamente corretto, s’intende nel senso retorico e conformista del termine, operando una semplificazione manichea tra il regno del Bene e quello del Male, si raggiunge, a nostro avviso, con l’albo «I ribelli di Cuba», su soggetto di Guido Nolitta, sceneggiato da Mauro Boselli e disegnato (molto bene) dall’artista cubano Orestes Suarez. La cornice è quella della Guerra dei dieci anni fra gli insorti cubani e l’esercito spagnolo (combattuta dal 1868 al 1878) e, al suo interno, la lotta per l’emancipazione degli schiavi, sostenuta da una parte — ma non dalla totalità — dei proprietari terrieri che hanno scelto di prendere le armi contro la madrepatria spagnola. Sicché i guerriglieri indigeni appaiono come una anticipazione dei "barbudos" di Fidel Castro e di Ernesto "Che" Guevara; e in tutta la storia si respira un clima quasi sessantottino di entusiasmo e di idealismo, fra ingenuo e soteriologico, come se la cacciata della Spagna dovesse coincidere, per il popolo cubano, con il ritorno allo stato di perfetta pace e innocenza che solo Adamo ed Eva conobbero, prima del Peccato originale, nel Giardino dell’Eden.
In realtà, il cinema statunitense si era già impadronito di questo argomento, presentando gli avventurieri e contrabbandieri nordamericani come i "buoni", che s’immischiano nella guerra cubana non solo per realizzare grossi affari, vendendo fucili e munizioni agli insorti, ma anche per solidarietà istintiva verso un popolo che lotta coraggiosamente per conquistare la propria libertà, contro il malgoverno d’una vecchia ed ottusa potenza coloniale europea, simbolo di tutti i vizi e di tutte le iniquità possibili e immaginabili (del resto, non era stato il buon Manzoni in persona ad avvalorare il cliché del malgoverno spagnolo; per non parlare di Emilio Salgari?).
Fa comunque un certo effetto vedere un fumetto italiano (e un fumetto così glorioso) cercar di rivitalizzare il clima del ’68, esaltando la lotta dei Cubani nel XIX secolo come una anticipazione di quella di Castro un secolo dopo: specie considerando fino a che punto l’esperimento del socialismo cubano sia disastrosamente fallito, anche alla luce della caduta dell’idolo marxista e alla rivelazione di che lacrime e di che sangue esso abbia grondato, ovunque qualcuno lo abbia innalzato sugli altari del potere statale, dall’Unione Sovietica alla Cambogia.
Vada, insomma, se lo sceneggiato televisivo «La freccia nera», apparso sul piccolo schermo proprio nel fatale 1968, trasudava sacri furori libertari e rappresentava i ribelli della foresta inglese come tanti studenti del Quartiere Latino, impegnati ad inseguire «la beauté dans la rue» (come recitava il notissimo slogan allora in voga) a colpi di sanpietrini, e il perfido e ingiusto Sir Daniel Brackley come un precursore dell’odiato sfruttatore borghese, capitalista e imperialista, del tardo XX secolo, degno soltanto d’essere spazzato via dal vento della Storia (con tutto il dovuto rispetto per il regista Anton Giulio Majano, che è stato, in ogni caso, un grande uomo di spettacolo); ma che gli sceneggiatori di Tex facciano un analogo scivolone, ai nostri giorni, quando ormai il Re marxista è palesemente nudo (e persino un po’ defunto), oltretutto tradendo la proverbiale riluttanza del mitico Ranger a prendere le armi nei conflitti che non lo riguardano e che non conosce, ebbene, questa è una cosa ben diversa e, ci sembra, quasi incomprensibile.
Lasciamo perdere che, nella storia «I ribelli di Cuba», gli Spagnoli interpretano il ruolo dei Cattivi senza alcuna attenuante o sfumatura, mentre nulla si dice, delle simpatie nordamericane per la causa indipendentista, circa il fatto che esse furono orchestrate da una campagna di stampa spregiudicata e senza precedenti, il cui vero scopo era quello di eliminare la fastidiosissima concorrenza dello zucchero cubano, sottraendo l’isola al controllo di una potenza straniera, per metterla sotto l’ala dello Zio Sam (come avverrà puntualmente nel 1898, con un intervento militare preceduto dal classico e perfetto pretesto, stile Pearl Harbor: l’esplosione della corazzata «Maine» nel porto dell’Avana). Del resto, Tex e Montales, nell’isola dei Tropici, ci arrivano in una maniera che è veramente tirata per i capelli: devono liberare il figlio di un amico yankee di Montales, niente meno che un ministro di Washington, rapito dai seguaci del Vodù presso New Orleans, e trasportato, chi lo sa il perché, appunto a Cuba, presso l’esercito privato d’uno stregone pazzo della Santeria.
Il fatto è che dispiace vedere Tex affondare il coltello nel petto di un soldato spagnolo, nel buio, a tradimento, come un volgare assassino, lui che non ha alcun titolo per combattere in una guerra cui gli Stati Uniti (per il momento) sono estranei, e ucciderne diversi altri, insieme ai suoi uomini, senza che gli sfugga una sola parola di rammarico o un solo gesto di disagio. Egli si comporta, in tutto e per tutto, come un terrorista islamico entrato con regolare passaporto in un Paese europeo, che mal ripaga l’ospitalità ricevuta, mettendosi a combattere, in maniera sleale (perché occulta), contro un governo legittimo, e che non dubita nemmeno per un istante che ingannare le autorità costituite, prendere le armi senza indossare alcuna uniforme e uccidere dei soldati di una nazione con la quale il proprio Paese non è in guerra, oltretutto non in una battaglia a viso aperto, ma di notte e a tradimento, come i briganti senza onore, non sia precisamente qualcosa di cui si possa andare fieri, né che la si possa giustificare moralmente o giuridicamente. Insomma, è il trionfo più banale del politicamente corretto: progressista, democratico, rappresentante del Bene contro il Male (infatti il generale Valeriano Weyler, che realmente ottenne notevoli successi nella guerra contro gli insorti cubani, fu rappresentato dalla stampa del gruppo Hearst, un industriale fin troppo interessato a un intervento militare statunitense, come l’incarnazione stessa del Male).
Andando avanti di questo passo, che altro ci dobbiamo aspettare in fatto di politicamente corretto, tale, cioè, da poter essere apprezzato dall’opinione pubblica prevalente, cioè pluralista, illuminata, tollerante, nemica di ogni pregiudizio borghese? Forse un Kit Willer omosessuale (pardon, gay) o, magari, un Tiger Jack transessuale? Non avrà fine la discesa verso il basso, verso i gorghi stagnanti e maleolenti del conformismo culturale progressista? Che cosa dovremo ancora mandar giù; che altro saremo costretti a sorbirci, in luogo del caro, vecchio Tex d’una volta, che metteva le sue infallibili "colt" al servizio della giustizia, disprezzando i cavilli burocratici e avendo ben chiara nella testa, e sia pure in maniera, se vogliamo, elementare, la distinzione fra il giusto e l’ingiusto, fra il vero e il falso, in breve: fra ciò che è bene e ciò che è male?
No, lasciamo perdere; è meglio, molto meglio, non cercare d’immaginarselo neppure….
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels