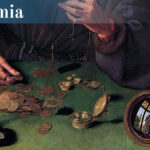
F. W. Raiffeisen e L. Wollemborg, nascita delle Casse di credito sociale
28 Luglio 2015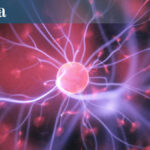
Come il paradigma dell’attualismo ha spinto la geologia verso un vicolo cieco
28 Luglio 2015Quel che il protestantesimo non può accettare, perché non lo può capire, è il senso ultimo della devozione mariana, che, dal suo punto di vista, è idolatria o poco meno: senso ultimo che consiste nella perfetta rispondenza del «sì» di Maria, nel mistero dell’Annunciazione, al «fiat» divino nel mistero della Creazione.
E non lo può capire perché parte da una premessa totalmente diversa dal cattolicesimo e incompatibile con essa: che le opere dell’uomo non contino nulla, in ordine alla salvezza; che l’uomo sia nulla davanti a Dio; che solo la grazia di Dio, totalmente gratuita e imperscrutabile, possa colmare l’abisso che separa le creature dal Creatore. Maria, al contrario, rappresenta la creatura "perfetta", che risponde pienamente, con tutto il cuore, alla chiamata di Dio e che collabora attivamente al Suo piano di salvezza, accogliendo il tremendo privilegio della maternità divina: e accogliendolo non in virtù di un orgoglio umano, ma, all’opposto, nella piena consapevolezza della umana piccolezza. Piccolezza, non nullità: per il protestantesimo rigoroso, specialmente calvinista, l’uomo è niente di fronte a Dio; per il cattolicesimo l’uomo è una creatura fatta a immagine del suo Creatore ed è chiamata a interagire con Lui, a svolgere un ruolo attivo e consapevole nel suo progetto provvidenziale.
Il punto di vista protestante parte dalla negazione del libero arbitrio; il punto di vista cattolico presuppone la piena affermazione di esso. È stato uno dei primi punti che Lutero volle mettere in chiaro, e nel modo più esplicito, polemizzando con Erasmo da Rotterdam, che ne era un difensore: il trattato del grande umanista olandese, «De libero arbitrio», viene pubblicato nel settembre 1524; la "risposta" del monaco agostiniano tedesco, il «De servo arbitrio», appare nel dicembre 1525. Nel cattolicesimo, e solo nel cattolicesimo, l’uomo conserva la propria dignità di soggetto ed è responsabile delle sue azioni, nel pieno senso della parola: di conseguenza, può scegliere di rispondere «sì», oppure «no», all’invito divino.
L’assenza di questo elemento è, e rimane, la differenza fondamentale tra cattolicesimo e protestantesimo; e certi sostenitori della riunificazione a tutti i costi – forse bene intenzionati, ma, si direbbe, incapaci di cogliere l’abisso teologico che separa le due dottrine – dovrebbero tenerlo bene a mente: non il primato di Pietro, né il numero dei sacramenti, e neppure la dottrina del sacerdozio universale dei credenti, sono degli ostacoli realmente insuperabili; mentre l’opposta valutazione del libero arbitrio è un macigno enorme, che differenzia così tanto il protestantesimo dal cattolicesimo, da farne quasi due religioni diverse e non semplicemente due confessioni, ovvero due interpretazioni, della medesima dottrina.
Il rifiuto del culto dei santi e della venerazione a Maria è la logica e diretta conseguenza della posizione protestante riguardo alla questione centrale e fondamentale del libero arbitrio. Per il luterano, e per tutti gli altri protestanti, la salvezza avviene mediante la sola fede e nonostante qualsiasi ricaduta nel peccato («Pecca fortemente, ma ancor più fortemente confida e godi in cristo», afferma Lutero, tirando per i capelli una frase simile, ma non identica, di Agostino («Pecca fortiter, sed fortius fide»); per il cattolico, la salvezza avviene mediante la fede, ma anche mediante le opere, sicché richiede un impegno attivo e laborioso da parte dell’uomo; e, quanto la peccato, non basta la fede a "rimetterlo", ma è necessario un apposito sacramento di riconciliazione (che Lutero, invece, ha abolito).
Per dare ragione della strana dottrina secondo cui le opere non contano nulla, Lutero è costretto a ricorrere alla tesi del "doppio uomo": l’uomo interiore, che vive nella dimensione della fede, e l’uomo esteriore, che vive nella dimensione del mondo. Quel che conta, per la salvezza dell’anima, è solo e unicamente quel che fa l’uomo interiore: le opere dell’uomo esteriore non giovano a nulla, perché, ad esempio, un uomo può fare le opere buone per delle ragioni sbagliate (come la brama dell’ammirazione altrui o la paura di andare all’Inferno), il che ne rende automaticamente nullo il valore agli occhi di Dio. Laddove si vede che Lutero ha una robustissima tempra di polemista, ma una assai debole tempra filosofica: come non vedere che la conclusione del suo ragionamento è assai maggiore della premessa e, quindi, sul piano strettamente logico, ancor prima di quello filosofico, teologico e morale, tutt’altro che convincente?
La premessa di Lutero è che gli uomini possono fare il bene (possono farlo, non è detto che lo facciano) per motivi sbagliati; la conclusione è che qualsiasi cosa essi facciano non ha mai il benché minimo valore davanti a Dio. Qui ci sono ben due errori nella struttura logica del suo discorso: il primo è che rimane indimostrato che tutti gli uomini facciano sempre il bene per delle ragioni cattive; il secondo, che un’azione buona perda automaticamente e necessariamente qualsiasi valore di fronte a Dio: il che egli non tenta nemmeno di dimostrare.
Poiché si tratta di due errori essenziali per la retta impostazione della dottrina della salvezza, ci soffermeremo brevemente sull’uno e sull’altro. Il primo: sarebbe come se Lutero dicesse: poiché si vedono alcuni triangoli di colore azzurro, non esistono triangoli di altro colore; e se, per caso, ci imbatteremo in un triangolo di colore rosa, bisognerà concludere che la nostra vista soffre di daltonismo, e che anch’esso è, in effetti, azzurro. Il secondo: è verissimo che l’intenzione qualifica moralmente una determinata azione; ma questo non autorizza a concludere che tutte le azioni che nascono da una motivazione non buona, siamo di per sé cattive. Prima di tutto, esiste una vasta gamma di possibilità intermedie fra un’azione assolutamente, radicalmente buona ed un’azione assolutamente, radicalmente cattiva. L’uomo stesso è un impasto di bene e di male, e separare nettamente la sua parte buona da quella cattiva (che, essendo in lotta fra loro, sono caratterizzate da una continua mobilità) risulta spesso assai problematico: e, se è vero che nulla è impossibile a Dio, ciò non significa che Dio non possa o non voglia tener conto delle debite sfumature dell’agire umano. Secondariamente, è contrario sia alla logica, sia all’etica, qualificare come cattiva una azione originata da una intenzione non perfettamente buona. Facciamo l’esempio di un uomo che offra una cospicua donazione ad un ente assistenziale, per acquisire meriti davanti alla comunità: certo la sua intenzione non è pura; ma chi oserebbe definire "cattiva" la sua azione, la quale, effettivamente, ha fornito sollievo a tante persone bisognose?
Lutero sembra dimenticarsi che Dio sa scrivere diritto anche sulle righe storte: le righe storte siamo noi uomini; ma la Provvidenza divina, che scaturisce da una infinita sapienza e da una infinita amorevolezza, riesce a trarre il bene perfino dal male; figuriamoci se non riesce a trarlo da ciò che, pur non essendo interamente buono, non è, tuttavia, neanche interamente cattivo. Tutto si può pensare di Dio, ma non che Egli sia un vignaiolo così duro e spietato, da gettare nel fuoco tutti i tralci e tutti i grappoli d’uva che non siano assolutamente perfetti: se così fosse, chi mai si salverebbe? E tale è, appunto, la logica conclusione di Lutero: nessuno, assolutamente nessuno, è degno di salvezza; se qualcuno evita le fiamme dell’Inferno, è solo e unicamente per la misericordia di Dio, non certo per i suoi meriti umani. Gli uomini, in quanto uomini, non meritano che disprezzo e dannazione: sono una massa spregevole e dannata.
A Lutero, qui, sfuggono le due cose più importanti riguardo a Dio e riguardo all’uomo: riguardo a Dio, il fatto che la sua qualifica centrale è l’amore, e, di conseguenza, la misericordia, e che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare gli uomini, come i Vangeli affermano esplicitamente, e non già per condannarli; riguardo all’uomo, che questi non è una creatura disgraziata e infelice, ma la più bella fra quante create da Dio, quella a Lui somigliante, e che tale somiglianza consiste appunto nell’intelligenza unita alla libertà del volere. E a che scopo gli sarebbe stato dato un simile privilegio, se, di fatto, non solo non servisse a nulla, ma, anzi, servisse a ribadire le ragioni della sua dannazione: vale a dire, la sua assoluta e radicale incapacità di fare un buon uso della propria ragione e della propria volontà?
E tuttavia – incredibile a dirsi – c’è ancora qualche storico delle religioni che arriva ad affermare che Lutero è il vero continuatore del pensiero rinascimentale; e non mancano i teologi "cattolici" che lo ammirano, segretamente o anche esplicitamente, proprio per ciò che di più falso e sbagliato vi è nel suo pensiero teologico e nella funzione storica da lui svolta nella storia della Chiesa ed in quella del pensiero cristiano: il disprezzo per la natura umana, la negazione del libero arbitrio e la radicale svalutazione del valore delle buone opere, e perfino della loro possibilità. Lutero ha ripristinato quell’abisso incolmabile, tra la maestà e perfezione di Dio e la finitezza e la miseria dell’uomo, che Gesù Cristo è venuto a colmare; e ha riportato indietro le lancette del cristianesimo al tempo dell’Antico Testamento, svalutando, di fatto, il senso dell’Incarnazione, passione morte di Cristo e quello della Redenzione.
Ora disponiamo del necessario quadro di riferimento per comprendere la bellezza del culto mariano, così brutalmente negata da Lutero e da tutti i protestanti, di tutte le chiese e di tutte le tendenze: la madre di Gesù, infatti, con il semplice fatto della sua esistenza, con il suo semplice, eroico, sublime: "sì" alla misteriosa volontà di Dio, smentisce in maniera radicale il disperato pessimismo luterano e calvinista e rivaluta il senso dell’agire umano e della disponibilità umana a collaborare con il disegno divino. Maria è l’esempio sublime della massima umiltà e della massima disponibilità e confidenza in Dio: «Eccomi, sono la serva del Signore. Dio faccia di me come tu hai detto», risponde all’angelo Gabriele (Luca, 1, 38).
Nel culto di Maria, dunque, non vi è "idolatria", perché non vi è attribuzione a lei di uno statuto ontologico che non le compete: è una donna, soltanto una donna; ma una dona che rappresenta l’esempio perfetto di sottomissione e di rispondenza coraggiosa al piano di Dio; è il modello al quale tutti i credenti possono aspirare, una sorta di ponte gettato fra la condizione umana e quella divina. Intermediaria presso suo Figlio, certo: ma non nel senso che Cristo abbia bisogno di intermediari; Cristo è tutto, è l’alfa e l’omega della creazione; e la fede in Cristo è completa in se stessa, perché introduce direttamente nel mistero della Trinità e da essa scaturisce il soffio dello Spirito Santo. È intermediaria nel senso che, come creatura, compendia in se stessa il paradigma della condizione umana, ma con una apertura totale, radicale, verso Dio, cioè verso il superamento di tale condizione. È un anticipo dell’umanità trasfigurata dalla grazia e interamente rinnovata nello spirito, di una umanità che ha vinto le pastoie della propria fragilità e della propria finitezza, proprio in virtù di un atto di pieno abbandono all’Amore divino. È una prefigurazione dell’umanità futura, liberata e trasfigurata dal ritorno definitivo di Cristo: una umanità gloriosa, fatta di corpi gloriosi, incorruttibili, luminosi, come li ha raffigurati Dante nel suo immortale poema, al termine del quale ha sciolto la più nella e commovente preghiera che mai sia stata scritta in onore della Vergine di Nazareth.
Questi concetti sono stati esposti con chiarezza dal teologo Raimondo Spiazzi in una delle sue numerose pubblicazioni di argomento mariologico, «Maria e la Chiesa dopo il Concilio», Roma, Biblioteca Fides, 1970, pp. 433-35):
«Accanto a Cristo, primizia dei risuscitati e dei glorificati, vi è Maria, prima fra tutti i partecipi al rinnovellamento e alla rigenerazione umana che hanno in Cristo il principio e il prototipo. Unica fra tutte le creature umane, Maria ha già raggiunto la sua piena glorificazione, la sua "statura perfetta" (Ef., 4, 13) in Cristo. Per lei nella realtà universale, anche in quella non unita ipostaticamente al Verbo, è già cominciato il rinnovellamento, effettuato nella parte più eccelsa e più rappresentativa fra tutte; il mondo è dunque già nel processo di trasformazione che culminerà nella sua glorificazione eterna (Rom., 8, 21): per la solidarietà che lega tutte le cose, spirito e materia, all’anima e al corpo di Maria, il mondo già partecipa in qualche modo di quella gloria. È un orizzonte sconfinato, che il mondo già tocca con una parte di sé circonfusa di luce eterna e trasumanata nella gloria, anche se nella parte già soggetta alle vicende del tempo, esso conosce ancora le tenebre, i dolori, i peccati, le mutazioni, i pericoli di precipitare in perdizione. Ma per chi è fedele e "vince", come dice l’Apocalisse (21,9), la via è già aperta, il processo trasformativo ha già avuto inizio; si tratta di non venire meno, di non deviare, di permanere invece sulla linea di questa continuità vitale che già lega Cristo, Maria, la Chiesa, l’universo, per partecipare al dinamismo evolutivo verso la gloria.
Il fatto dell’assunzione ha questo significato cosmico, che ci fa capire meglio la grandezza di Maria e il significato della sua predestinazione, e insieme ci riempie di gioia e di speranza.
La grande vittoria sul divenire, la caducità, il dolore, la morte, che è sempre stata al termine dell’anelito e del sogno, della speranza e dello sforzo umani, ha una radice interiore in Maria. Gli uomini hanno spesso compiuto il tentativo di vincere il tempo e la morte dall’esterno, sul piano della fisicità storica e con i mezzi fornito dalla scienza, dalla tecnica, dalla medicina, dall’igiene ecc. tentativi a volte grandiosi ma inutili, spesso risolti in scacchi e fallimenti. Anche chi supera i limiti del tempo con la forza del genio, nell’arte, nella poesia, nelle opere di carità, nelle grandi imprese ("monumentum aere perennius…"), se può riuscire a fissare un ricordo — almeno un nome, come cantava il poeta azteco, il cui lamento si legge nel museo di Città del Messico — nella storia e, quel che è più, se può per generazioni e generazioni offrire un nutrimento per gli intelletti e le coscienze umane che a quei grandi insegnamenti od esempi si ispirano per vivere; non giunge però a vincere, da solo, la vera e definitiva battaglia: quella della persona contro la morte, come non ouò salvarsi, lungo la vita terrena, dalla caducità e dal dolore. Dove sarà dunque la radice della conservazione o del rinnovellamento? Dove trovare la sicurezza che nulla è perduto, tutto è raccolto e conservato, tutto è destinato a eternarsi, a fiorire in una sempre nuova giovinezza?
Unica persona umana che già abbia raggiunto (ormai da duemila anni!) la sua perfetta reintegrazione; partecipe fin d’ora della regalità universale e della gloria immortale di Cristo, l’Assunta è come una dimostrazione vivente di ciò che la teologia insegna intorno alla futura reintegrazione. Quei raggi di luce che la teologia raccoglie dalla rivelazione, in un mare di tenebra, per scandagliare nella profondità e intuire o presentire, più che capire, il senso della storia quale si rivelerà nel giorno della parusia, sembrano concentrarsi nell’Assunta, esprimersi in lei in pienezza di luce, e in quella concreta attuazione delle promesse divine, testimoniare la fedeltà di Dio e svelare meglio il senso del mistero.»
Il protestantesimo, che non possiede tanta luce di bellezza, e che non è in alcun modo addolcito da questi orizzonti di speranza, dischiusi appunto da una creatura che, in virtù della propria umiltà e fedeltà a Dio, ebbe l’inconcepibile privilegio di diventare fisicamente la madre del Figlio, la seconda persona della Trinità divina, rimane fondamentalmente una dottrina cupa, tetra, perfino lugubre, tutta chiusa nel sentimento angoscioso della umana miseria e insufficienza, schiacciata perennemente sotto il peso del peccato di Adamo, quasi priva di speranza nei confronti del proprio destino ultraterreno.
Maria, l’umile ragazza che ha scelto di collaborare efficacemente al progetto di salvezza universale, rappresenta, teologicamente e anche poeticamente, come ben videro Dante e tanti altri scrittori e artisti, il punto più alto, umanamente concepibile — concepibile, si fa per dire: siamo davvero sulle soglie del Mistero infinito — che la creatura possa raggiungere, finché si trova nella dimensione terrena, verso il suo Creatore.
Maria è, per il cristiano, non solo il mantello misericordioso, sotto il quale rifugiarsi; non solo la benevola interlocutrice fra l’uomo e Dio («Donna, se’ tanto grande e tanto vali, / che qual vuol grazia e a te non ricorre / sua disianza vuol volar sanz’ali», dice Dante, esprimendo il sentimento comune): è anche la primizia della umanità rinnovata dalla Grazia, la visione meravigliosa e infinitamente rasserenante di quel che sarà la natura umana, quando le ultime conseguenze del Peccato originale saranno state vinte e distrutte per sempre dall’Amore divino.
Così, come tutta la creazione ha avuto inizio da un "sì" di Dio nei confronti delle creature, traendole dal non essere all’essere, allo stesso modo la Redenzione umana presuppone il "sì" del Figlio al Padre, ma anche il "sì" della creatura al suo Creatore.
Pensiero abissale, sconvolgente: tutto è appeso all’esile "fiat" d’una ragazza umile e sconosciuta…
Fonte dell'immagine in evidenza: Wikipedia - Pubblico dominio
