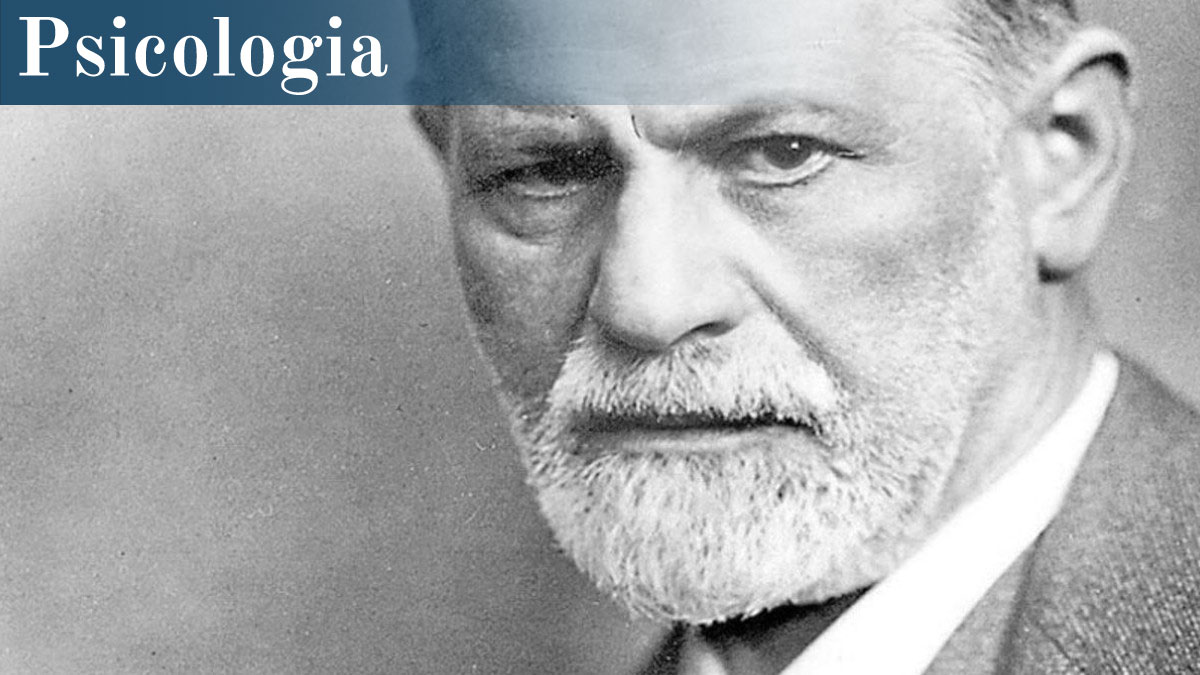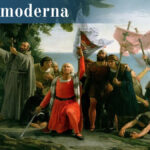
Il tarantismo, una sfida imbarazzante ai pregiudizi della «scienza positiva»
16 Giugno 2011
L’incontro sessuale fugace non allevia, ma inasprisce il vuoto esistenziale
18 Giugno 2011Che cos’è la Georafia?
Fin dai banchi di scuola ci è stato insegnato che la parola «geografia» significa, letteralmente, «scrittura della Terra» e che, quindi, il suo significato è, più o meno, quello di «descrizione della Terra».
Dunque, la geografia descrive la Terra; e questa descrizione si è concretizzata dapprima con i viaggi di scoperta, terrestri e marittimi, che permettevano di costruire mappe e carte geografiche; poi, con l’avvento della moderna cartografia matematica, con il ricorso alle proiezioni cartografiche: tutte scorrette, come sappiamo, stante l’impossibilità di riprodurre una superficie sferica, come è quella terrestre, su di una piana, come la pagina di un atlante); e tuttavia, grazie all’osservazione aerea e spaziale nonché all’ausilio delle banche dati informatizzate, sempre più precise, aggiornate,"reali" e "oggettive".
Per esempio, mentre, su una carta geografica tradizionale, una città è rappresentata da un cerchietto, in una riproduzione fotografica satellitare la città apparirà per come realmente appare, se vfista dal finestrino di un aereo ad alta quota: una macchia disordinata di colori, di fumi, di linee che si dipartono da essa; o, nel caso della fotografia notturna, un insieme di tante piccolissime luci che delineano un incerto perimetro rispetto al territorio buio circostante.
Ma siamo sicuri che la descrizione del paesaggio terrestre fatta dalla scienza geografica sia pi così obiettiva, così efficace, così incontrovertibile come ci è stato sempre insegnato e come, forse, ci piacerebbe credere, visto che, da Bacone in poi, «sapere è potere» e quindi, per dominare l’ambiente terrestre, dobbiamo essere ben certi di sapercelo rappresentare esattamente, nel modo più fedele possibile?
Così riflette Barry Lopez, scrittore e giornalista americano, nel suo bel libro «Artico. L’ultimo paradiso» (titolo originale: «Arctic Dreams», 1986; traduzione italiana di Roberta Rambelli, Milano, Mondadori, 1986, pp. 288-91):
«Quando i primi esploratori artici riferirono nei commenti ufficiali ciò che avevano visto, esitarono a muovere appunti allo scibile dei loro temi, alle apprezzatissime mappe. Tendevano piuttosto ad abbellire la realtà, per rendersi più credibili. A volte erano addirittura convinti di aver percepito qualcosa dove non c’era nulla perché sembrava predestinato che accadesse… l’occhio non aveva intravisto vagamente una costa prima che la nebbia si chiudesse? l’orecchio non aveva captato il suono lontano della risacca prima che l’oscurità e il vento contrario congiurassero? la terra, pensavano, doveva corroborare e non contraddire ciò che gli uomini avevano appreso sulla forma del mondo da fonti come Tolomeo. I resoconti di questi esploratori venivano letti e tramandati; i desideri confusi e le osservazioni degli autori, con le interpretazioni fantasiose di cartografi ansiosi di proteggere la propria reputazione, perpetuavano una geografia di isole e di stretti sperati ad ovest dell’Europa che n on poteva non trovare conferma, una geografia che apparteneva soltanto alla mente.
L’influenza di queste immagini era considerevole. Una geografia mentale del genere diviene la geografia cui si adatta la società, e può risultare più influente della geografia della realtà. L’immagine popolare di una regione sconosciuta, scrive J. Wreford Watson, "è composta da ciò che gli uomini sperano di trovare, ciò che cercano, il modo in cui le scoperte vengono inquadrate nella preesistente cornice del pensiero e il modo in cui le scoperte stesse vengono poi espresse". Questo, dice Watson, è ciò che si "trova" veramente in una terra nuova.
Un altro geografo, John G. Allen, riflettendo sul modo in cui ci avviamo verso un paesaggio nuovo, scrive: "Quando l’esplorazione è vista come un processo anziché come una serie di eventi distinti, le sue componenti principali sono chiaramente relate all’immaginazione: nessuna avventura esplorativa incomincia senza obiettivi basati sulla natura e sul contenuto immaginari delle terre da esplorare". Quindi il corso della scoperta è guidato da nozioni preconcette. Le osservazioni sul campo, scrive Allen, "sono distorte da queste immagini. I risultati delle esplorazioni sono modificati dai rapporti scritti e interpretati alla luce di illusioni persistenti e dai tentativi di includere le informazioni nuove in sistemi e strutture parzialmente erronei del modo d’intendere la geografia".
Nell’ultimo ventennio, l’attenzione della geografia accademica si è un po’ distolta dalla descrizione della terra così com’è, puntando invece sui paesaggi che esistono nella mente umana. La portata e la complessità di queste immagini geografiche, chiamate mappe mentali, sono meravigliose. Un residente urbano, per esempio, si vede situato nello sazi cittadino con riferimenti specifici a certi negozi, parcheggi e fermate dei trasporti pubblici. Assegna ad una strada o a un edificio più importanza che ad altri quale luogo per incontri casuali con gli amici. Sa che certi percorsi da un punto all’altro sono iù sicuri, e sa come raggiungere un certo ristorante anche se non conosce il nome delle strade che deve percorrere per arrivarci. La mappa mentale di un eschimese potrebbe essere una veduta complessiva della regione dove va abitualmente a caccia… dov’è più probabile che in primavera appaiano i caribù, dove si trovano le bacche, dove si ha un passo consistente di certi pesci, dove il suolo è troppo paludoso per transitarvi in giugno, dove si trova in abbondanza la steatite oppure il legname gettato a terra dal mare.
Le mappe mentali dell’abitante urbano e dell’eschimese possono corrispondere assai poco, in termini spaziali, alle mappe delle stesse aree preparate con rilevamenti e strumenti cartografici. Ma sono comunque guide precise e attendibili del paesaggio. Sono concezioni vive, create idiosincraticamente, spogliate del superfluo e adattabili all’istante. La loro validità non è suscettibile di contraddizione.
La nostra percezione culturale complessiva di una regione richiede un altro termine. Le mappe mentali sono troppo personali; e i termine esprime a sufficienza la ricchezza del paesaggio invisibile, quella componente di un’immagine regionale su cui i gruppi aborigeni insistono non meno che sulle componenti fisiografiche di una regione. Il termine della Jahner, "paesaggio spirituale", si riferisce più specificamente alle relazioni insite nel paesaggio fisico che ci rendono consci della presenza delle forze e delle relazioni di cui è infuso il nostro pensiero religioso. Se si può intendere la frase "un paese della mente" nel senso che si richiama al paesaggio evidente ai sensi, così com’è conservato nella memoria umana e come emerge dalla tradizione orale di un popolo, quale repertorio della storia mitologica e di quella "a tempo reale", allora forse questa espressione è sufficiente.
Amos Rapoport, un architetto australiano incuriosito come Tuan e Carpenter dal significato di "luogo", effettuò uno studio tra Kruna, Arunda, Walbiri e altri aborigeni australiani. Disegnò le mappe dei loro paesaggi mitologici. Comprese che le storie della mitologia d’una tribù, la loro origine, il loro significati e il loro scopo nell’universo, sono realtà "non osservabili" che trovano espressione nei fenomeni osservabili". In altre parole, la terra rende reale il mito. E rende reale la gente
Le storie che si svolgono sullo sfondo del paesaggio locale e che danno espressione alle relazioni durature della vita, diceva Rapoport, sono importanti per gli aborigeni quanto il cibo e l’acqua. Il paesaggio mitico non è i paesaggio naturale, tuttavia quello mitico e quello naturale si sovrappongono in certi punti visibili della terra. E i limiti del paesaggio locale, faceva notare, non possono essere negoziati politicamente: sono fissati nella mitologia. Non sono suscettibili di adattamento. Lo studio di Rapoport chiariva, secondo lui, che gli europei possono "fraintendere completamente la natura del paesaggio a causa del loro punto di vista". […]
In tutto il mondo l’aspirazione dei popoli aborigeni è sempre stata di raggiungere una relazione congruente con la terra e inserirsi in questa; conseguire ogni tanto uno stato di somma armonia, di riverberanza. Il sogno di questa trascendente congruenza includeva l’evoluzione di un rapporto di caccia e di un rapporto con la tera nel quale era inteso che prevalesse un riguardo reciproco; ma significava anche una conservazione delle storie che lega la gente di quella terra.»
Fonte dell'immagine in evidenza: sconosciuta, contattare gli amministratori per chiedere l'attribuzione