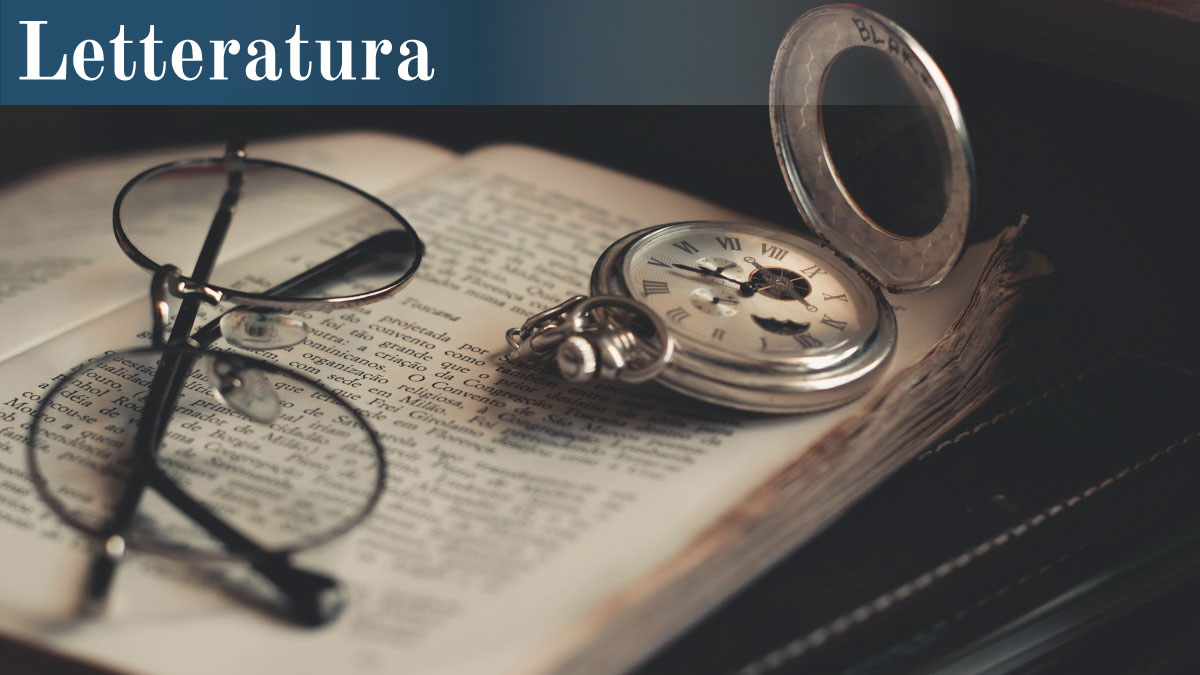È stata una scelta saggia e felice quella di Roma capitale?
26 Agosto 2010
Tutto quello che importa sul caso Sarrazin è giudicare se pone sul tappeto problemi reali o no
30 Agosto 2010La letteratura italiana del XIX secolo vanta almeno tre capolavori popolari nel miglior senso del termine; tre libri, cioè, che, molto amati da un pubblico semplice, conservano quasi tutta la loro freschezza e della loro fragranza anche alla lettura puntigliosa di un critico esigente e culturalmente sofisticato, purché la sua mente non sia avvelenata da preconcetti ideologici o da una qualche irrimediabile forma di snobismo intellettuale.
Questi tre capolavori, a torto definiti "minori" dalla cultura di matrice accademica e ufficiale, sono: «Le mie prigioni» di Silvio Pellico, Saluzzo, 1789 – Torino, 1854), pubblicato nel 1832; «Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino» di Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini (Firenze, 1826 – 1890), apparso su «Il giornale dei bambini» nel 1880 e in volume nel 1883; e «Cuore» di Edmondo De Amicis (Oneglia, 1846 – Bordighera, 1908), del 1886.
Conosciutissimi e amati anche all’estero (è noto il commento del cancelliere Metternich alla pubblicazione de «Le mie prigioni»: «Questo libro è costerà all’Austria più di una battaglia perduta»), dove sono stati tradotti in numerose lingue, si sino imposti come i rappresentanti genuini della nostra letteratura ottocentesca, insieme a «I promessi sposi» di Alessandro Manzoni (del quale «Le avventure di Pinocchio», specialmente, ha sfiorato il record delle traduzioni e della diffusione ed emulato la celebrità).
A questo proposito, una riflessione pertinente e, crediamo, condivisibilissima, è stata fatta dallo scrittore Paolo Arcari (1879-1955), un altro degno esponente della nostra letteratura sul quale è da tempo calata, ingiustamente, la cortina del silenzio (mentre si parla fin troppo di scribacchini commerciali che hanno l’unico punto di forza di godere del sostegno massiccio di possenti gruppi editoriali.
Paolo Arcari (nato nel 1879 e morto nel 1955, nel silenzio più assordante dei menestrelli nazionali della cultura) fu docente di letteratura italiana presso diverse università della Svizzera, ricoprendo anche l’incarico di Rettore e preside di facoltà in quella di Friburgo. Politicamente egli fu un accesi interventista nel primo conflitto mondiale e un esponente del nazionalismo italiano, collocandosi nella sua tendenza democratica e liberale (mentre i nostri storici attuali sono così ignoranti o così prevenuti da fare di tutta l’erba un fascio e da non essere disposti ad ammettere che, nel nostro movimento nazionalista, vi fossero altro che energumeni con poco cervello, esagitati e guerrafondai a oltranza).
Nel suo libro «La letteratura italiana e i disfattisti suoi» (Milano, Vincenzo Colonnello Editore, 1937, pp. 20-29, Arcari parla giustamente di «sacro orrore» della critica blasonata nei confronti dei nostri scrittori, specialmente se di successo (magari internazionale più che nostrano); e osserva, con sapida irriverenza:
«Un altro disfattismo èp prodotto dalle permalosità di salotto, di accademia, di conventicola, , dalla mentalità ermetica di iniziati, dall’orrore sacro di quanto abbia la jattura d’essere capito e gustato all’aria aperta, dal prossimo più numeroso.
In Corso Garibaldi a Milano, parlavo un giorno, con uno scrittore del gran mondo, di un nostro romanziere realista, Gerolamo Rovetta. Corso Garibaldi è, davvero, per buona parte ancora, una strada di metropoli ottocentesca, di alveari cittadini. E quello mi ribatté, con una smorfia di ripugnanza.
"Ecco, il tuo Rovetta non lo posso leggere; mi par fatto e tagliato per la gente che abita in queste case".
"Bada .- gli risposi – che i tre quarti dei nostri contemporanei non possono alloggiare che in queste case, con quattro vani, con cucina e contatore del gas. I tuoi inglesi scrivono per i tre quarti degli inglesi!".
Niente mi valse.
E non c’è niente da fare! Se un libro rischia di tornare accetto ai tre quarti dei nostri connazionali,, addio, che non se ne parli più. È finita per chi l’ha scritto e per chi perde il tempo a leggerlo!
Così, libri conosciuti in larga sfera ce ne sarebbero anche in Italia, se i baccalari ne volessero dare il permesso. Ma ci sono individualisti di una razza tanto arrabbiata che se non possono ammirare da soli, a porte chiuse, o almeno in comitato segreto, fanno la più solenne rinunzia ad ammirare. I libri buoni per tutti non li considerano medici dell’animo, ma appena appena veterninari"!
Nell’ultimo secolo nacquero tre opere che, per diffusione in Europa, arrivarono a raggiungere lem opere delle lingue padrone, se non furono vicine a superarle: stampate, ristampate, tradotte, illustrate, imitate, forse anche invidiate…
Di un piemontese l’una; di un ligure-piemontese l’altra, di un toscano la terza.
L’una da circostanze di dolore, anzi di martirio, di severità, anzi di crudeltà, suscita per ingenuo prodigio un mondo di anime nobili, di simpatie costanti, di comprensioni sincere e pudiche, di affetti delicati, di aspirazioni gentili; sulla monotonia dei giorni, dalla pedanteria metodica delle quotidiane privazioni svolge, per inventiva gratitudine, una varietà impensata, inaudita di casi dove si avvicendano vecchi e bambini, giovinette in isboccio ed avventurieri al tramonto, di casi che riconducono il sorriso perduto, che palpitano di un interesse sempre nuovo, che portano con sé gli odori della terra felice e gli echi della più vasta vita; materia di tragedia, ne conserva tutta la dignità ma on ne prende mai il cipiglio; la spoglia d’ogni paludamento, la fa più intensa ad un tempo più vera e più affabile aprendo sui tetti della sventura l’ampiezza serena di un cielo benedetto. L’una è la storia di Pietro e di Schiller, della gamba e del ragno, della Zanze e del cameriere di Brescia, del mutolino e di Luigi XVII, dei bambini di Venezia, dei Piombi, ella salma di Oroboni e dell’avvicinarsi dell’imperatore nei giardini di Schönbrunn: "Le mie prigioni".
L’altra, ha l’espansione nel titolo, la giocondità nell’argomento, l’innocenza nei personaggi e supera tutto quanto promette perché l’espansione della natura forte e diritta si rinnova incessantemente come polla sorgiva, perché l’argomento si amplia nel ritmo delle settimane e delle stagioni a contenere la vita di una famiglia, di una città, di una nazione. Leggendola, ritorniamo tutti fra i banchi della scuola, siamo tutti Enrico, ci sussulta un po’ il cuore a tutti, anche senza vedere, a trovar subito la forma, il corsivo delle lettere del papà, della mamma, della sorella. Nella infanzia di Enrico c’è la nostra, c’è l’odore dell’ieri dileguato e c’è il profumo delle teste dei nostri figliuoli; c’è l’ostinazione pia di essere un po’ più buoni, un po’ più coraggiosi, un po’ più ilari e nuovi in queste ore del nostro pomeriggio umano.
È la storia di cento storie e di tanti bei racconti mensili; è la classe dove entra il piccolo calabrese, dove il leoncello piange perché gli è morta la mamma, dove il muratorino, Votini, Derossi…
Siamo nel mondo dove Umberto significa Villafranca e il Quadrato, dove si regalano i giocattoli, anche costosi, dove la casa dei signori, l’ospedale, la prigione, il circo, la baracca, sono visti dalla scuola, colla baldanza della scuola che vorrebbe imbiancare a nuovo la vita per un domani più festante. È il "Cuore".
Nella terza l’invenzione è di una ricchezza sfondo lata, di una insolenza leggiadra, fluida, trasparente ma succosa con la saggezza di molti inverni sulle foglioline luccicanti della sua primavera.
Come nello stomachino del protagonista c’è sempre dell’altro appetuito, così nell’autore, quando par che ce ne abbia mezzo intontiti c’è sempre – scrive felicemente Paolo Harzard – dell’altro ingegno in dispensa. La terza è la storia elastica e rimbalzante dove corono per le strade, con portiere di meringhe, cocchi di panna montata da leccarsi le dita, dove quattro coniglietti delle pompe funebri portano feretri su misura, dove dal Campo dei Miracoli al Paese dei Balocchi siamo ingoiati da meraviglie voraci come il ventre della balena, dentro la quale però, una candeletta è accesa per vederci giusto.
La terza è "Pinocchio", piallato dal legno ma nato con la camicia, perché quel mariolo di suo padre Geppetto-Collodi ebbe la malizia di dire: "scrivo per i più piccoli. Sicché per criticarlo i grandi dovessero confessare di averlo letto.
Rispetto, dunque, a "Pinocchio".
Ma non si è avuto pace, in Italia, finché non si fossero vilipesi "Le mie prigioni" e "Cuore"; c’era metà Italia verde che l’altra metà non diventasse rossa dalla vergogna di così scipite letture. E in quanti ci si sono messi, contro queste candide rinomanze Ci ha sudato anche quel buontempone di Olindo Guerrini, benemerito precursore del ciclismo, celebratore imparziale delle sogliole fritte, dei tordi, del vino di Conegliano e della freschissima e tedeschissima birra. Hanno relegato Pellico in seminario col pericolo che vi andasse a finire in soffitta e, quanto a Edmondo De Amicis, coloro che non capivano Carducci si servirono di lui e delle sue frecciate ai "languori del capitan cortese"!
Aveva il De Amicis diritti sacrosanti a essere considerato un precursore – a suo modo – del patriottismo sociale, della riconciliazione fra patria e proletariato, lui l’uomo delle frontiere e dei transatlantici stivati di emigranti, lui ufficiale e scrittore, lui che aveva il senso della scuola e dell’officina, ma la superstizione della parola "lacrimogeno" a momenti a momenti lo privava dei suoi diritti civili verso l’Italia del Littorio.
Lasciate pure che piangano gli uomini! Di sudori, di sangue e di pianto è fatta la più autentica virilità degli onesti.
Ma che maledizione è questa che abbiamo addosso?
Ogni volta che ce lo domandiamo ci si dà una nuova risposta. Nell’insopportazione cronica della fama effettiva e vivente che morbo di annida e si rivela?
Si annida il sordo malanimo che prende i lettori dei giornali davanti alle colonne sul vincitore della lotteria? Avete visto per il premio Nobel!… Quando lo diedero al Carducci, pazienza!: glielo dovettero portare a casa come l’olio santo; era così conciato, malandato; non stava in piedi e non riusciva a dire due parole. La cronaca di quella solennità aveva tutta l’aria di un bollettino medico se non proprio di un mortorio e, in grazia dell’aria di mortorio, la somma del premio Nobel non ingelosiva.
Ma quando, benti anni dopo, si trattò della Deledda1 Che musi, che enti stretti, che felicitazioni acetose!
Che sia municipalismo, una gretta scontrosità, una zotica paura che il rande scrittore metta in piazza gli affari privati dei suoi coinquilini, dei terrazzani? Guardate i siciliani come li mandano giù male, li Verga, il Pirandello, il Mignosi!
Che in questa insofferenza italiana del successo, anche del successo di gente che non si porterà più candidata, che non brigherà per nessun seggio, ci sia il giacobinismo teoretico, il settarismo ideologico? Che ci sia la volontà di bruciare tutto come il pascià maomettano bruciò tutta la biblioteca di Alessandria, per lasciare sussistere una dottrina sola, un sistema solo, un Hegel solo?»
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels