
Tutto progredisce, anche il male: è la metastasi dello sviluppismo
9 Gennaio 2008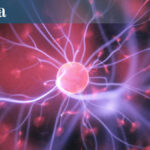
Scoprire per caso, all’ultimo minuto: sindrome da bugia o messaggio del profondo
11 Gennaio 2008Le reazioni indignate e inviperite dei fans di Lucio Battisti al nostro articolo Dalla sofferta poesia di Tenco ai lazzi furbeschi di Battisti-Mogol (del resto, largamente previste), ci suggeriscono una breve e, se possibile, pacata riflessione non tanto sulle canzoni di Battisti, sulle quali abbiamo già detto quel che avevamo da dire, quanto sulla difficoltà di ragionare obiettivamente sulla musica leggera, e di distinguere il piano della musica d’autore da quella commerciale.
Viviamo immersi in un generale relativismo filosofico, storico, etico, religioso, per cui non esiste nulla di più "normale" del relativismo estetico. In base ad esso, ciascuno pensa che la propria verità valga quanto qualsiasi altra. Dal momento che si nega l’esistenza di una verità e, in omaggio a un malinteso sentimento pluralista e democratico, si pensa che il solo fatto di postulare l’esistenza della verità, al singolare, sia un atto di inqualificabile autoritarismo, se non addirittura di nazifascismo, qualsiasi somaro si mette a ragliare più forte che può e, dal momento che non si interessa di quel che stanno ragliando gli altri somari suoi pari, si meraviglia altamente se qualcuno gli fa notare che i suoi versi non sono propriamente melodiosi e gradevoli. «Ma come – si arrabbia l’asino – io ho la mia verità, voi la vostra; e se io non metto il naso in quel che fate voi, voi lasciatemi ragliare quanto mi pare e piace. Possibile che nessuno vi abbia spiegato che questa è la libertà, e che la democrazia funziona così?».
In effetti, nel precedente articolo noi abbiamo argomentato per quali ragioni riteniamo che Tenco sia stato un vero poeta, e la coppia Battisti-Mogol una semplice ditta commerciale. Abbiamo confrontato testi, ragionato sui contenuti, contestualizzato i rispettivi paradigmi culturali: quello dei cantautori, che volevano innalzare la musica leggera al livello dell’opera d’arte e, al tempo stesso, farne uno strumento di critica sociale; e quello dei cantanti da cassetta, che volevano abbassarla al livello di pura merce di consumo, di mezzo d’evasione e di scadente surrogato di una mai realizzata liberazione personale.
Ovviamente, si può non essere d’accordo con le nostre tesi, perché questa è la caratteristica della democrazia: il dissenso dalle opinioni altrui, civile e, possibilmente, motivato.
Persone che hanno sempre amato la musica di Battisti e che, inizialmente, non condividevano le nostre idee, si sono ricredute e si son dette persuase, dopo aver seguito i ragionamenti da noi sviluppati e, soprattutto, dopo aver operato un confronto testuale, critico e spassionato, dei singoli brani musicali. Hanno convenuto che nei testi di Tenco ci sono idee, sentimenti, passione, il tutto formulato in maniera non banale; mentre in quelli di Battisti-Mogol c’è una verniciatura superficiale e alquanto furbetta di pseudoemozioni, per giunta involgarite da una presunzione intellettualistica a un tanto il chilo, e null’altro.
Aria fritta, sia come parole che come musica.
Per le parole, basta prendere un testo a caso; quanto alla musica, qualunque principiante di chitarra degli anni Settanta conosce il motivetto battistiano Le tue scarpette rosse ecc., perché è la musica più elementare e meno originale che si possa comporre con le sette note; un po’ come i deliranti colloqui del signor Martin e della signora Martin ne La cantatrice calva di Ionesco, fatti di frasi come: «Questa è una camera da letto»; «Tu sei nella camera da letto»;«Noi siamo nella camera da letto»; ma, ovviamente, senza l’ironia e il surrealismo di Ionesco.
Altri ammiratori di Battisti, invece, hanno preferito passare direttamente agli insulti più banali. I più gentili sono stati quelli di "disinformazione" da parte nostra, e sapete perché? Perché nel nostro articolo si leggeva "Gianni Bergna" invece che "Gianni Borgna". Pare che a quel signore non sia venuto in mente che, forse, si trattava semplicemente di un banalissimo refuso. Ma, a parte questo, nessuna discussione sul contenuto delle nostre affermazioni; nessuna argomentazione; niente di niente.
Un altro se l’è presa con quello "sconosciuto" che aveva osato criticare la musica di Battisti. Eh già, se non sei famoso, come ti permetti di parlare? Ma anche in ciò, nessuna particolare meraviglia. In una società come l’attuale, dove la pedagogia è fatta da programmi televisivi quali Il Grande fratello e L’isola dei famosi, non desta stupore il fatto che si riconosca il diritto di interloquire solo agli squallidi vip del piccolo schermo; e che le idee non contino assolutamente nulla, ma solo il nome di chi grida più forte.
Se ci soffermiamo su questi malinconici particolari non è certo perché il livello della discussione ne valga la pena, ma solo e unicamente per evidenziare, ancora una volta, come sia difficile, per non dire impossibile, discutere di musica leggera (e di musica in genere, e di arte in genere), nel clima dominante di relativismo assoluto, dove tutto è uguale a tutto e una torta alle mele vale quanto una ciambella fumante di bovino.
La musica leggera, in particolare, coinvolge emozioni, sensibilità, ricordi in misura tale – e specialmente per certe categorie di persone – che diviene semplicemente impossibile poterne fare una analisi lucida e razionale. A quelle persone non interessa capirla, ad esse è più che sufficiente sentirla: con la pancia, con i visceri. E con i visceri non c’è niente da fare, è come quando si tratta della squadra del cuore: a parlarne male, si rischia come minimo una coltellata.
E questa è la prima riflessione.
La seconda riflessione è che, sentendo la musica con i visceri, cade qualunque possibilità di operare un minimo di distinzione fra musica d’autore, artistica, impegnata, e musica puramente commerciale. Con simili premesse, la musica piace o non piace, e basta; e, se piace, la si difende in toto. Di più: non si difende la musica, ma il cantante che c’è dietro ad essa: anche se non l’ha composta lui, ma solo eseguita; anche se non ha scritto i testi, perché non ne sa scrivere o perché preferiva puntare comunque sul prodotto di sicuro successo.
Eppure, saper fare quella distinzione dovrebbe essere un fatto di pura e semplice onestà intellettuale. Uno, cioè, può anche dire: «Sì, è vero, è musica commerciale: con tutti i trucchi del caso, con il motivetto orecchiabile e perfino con la rima nel testo; però a me piace, che volete farci: mi rilassa». Questo sarebbe un discorso onesto.
Invece no.
Innamorati con i visceri di quelle canzoni e di quel personaggio, si nega l’evidenza e si pretende che si tratti di musica d’arte, per giunta intelligente quanto lo si potrebbe desiderare. Insomma si applaude il re in mutande, come nella fiaba di Andersen; e poi, lo fanno tutti. Se tutti applaudono, qualche motivo ci dovrà pur essere. Il numero fa il valore delle cose. Così pensa chi non ha capito niente della democrazia o chi l’ha capita anche troppo bene: cioè come la dittatura della maggioranza.
Ahimé, la maggioranza, nella società di massa – proprio per quei meccanismi psicologici e sociali che sono già stati analizzati mille volte – non è mai intelligente. È intelligente bruciare i cassonetti e assaltare con le bombe i vigili del fuoco nell’hinterland napoletano, mentre 100.000 tonnellate di rifiuti dannosissimi per la salute invadono le strade e ammorbano l’aria? Però lo fanno in molti; dunque, qualche cosa di giusto ci sarà.
Ora, tornando a Battisti, noi non vogliamo negare che egli avesse delle conoscenze, delle capacità e delle possibilità tali da consentirgli di comporre della buona musica, della musica valida e intelligente. Anzi, pensiamo che le avesse. Solo che non gli interessava di seguire la strada stretta e malagevole del compositore di qualità; o, almeno, non gli interessava di sacrificare la sua carriera ai sacrifici e alle scarse soddisfazioni materiali connesse con una scelta di quel tipo.
No, lui preferiva il successo a colpo sicuro: e, per ottenerlo, ha svenduto il suo talento per sfornare – in coppia col paroliere Mogol – una lunga serie di prodotti musicali astuti e dolciastri, dove tutto, anche le famose "emozioni" (per fare il verso a un suo pezzo tra i più celebrati), è artificiale e costruito con furbizia e con cinismo, al solo e unico scopo di vendere la maggior quantità possibile di dischi.
Tutto qui.
È molto semplice; e, se si vuole, anche assai banale.
In fondo, il discorso sulla musica leggera – così come qualunque altro discorso sull’arte – riconduce alla distinzione antropologica fondamentale: quella fra i "puri" e i "venduti". Con brutale sincerità affermiamo che tertium non datur: e mai lo si è visto con più chiarezza come alla svolta cruciale fra gli anni Sessanta, generosi ed utopistici, e i Settanta, narcisisti e pragmatici.
Ci sono due categorie di artisti, così come ci sono due categorie di intellettuali e, in generale, di esseri umani: i puri e i venduti. Quelli che hanno qualcosa da dire, e che per dirla sono disposti ad affrontare solitudine, amarezze e incomprensione; e quelli che non hanno nulla da dire, ma desiderano il denaro e il successo, e son disposti a vendersi sul grande, inesauribile mercato del consumismo.
Luigi Tenco era un puro e Lucio Battisti, un venduto.
Semplice, chiaro.
Per questo motivo non abbiamo mai potuto comprendere coloro che dicono – e sono tanti -: «Sì, mi piace Tenco, era un grande; ma anche Battisti mi piace, anche lui era un grande». Grande l’uno e grande l’altro; e contenti tutti.
Torniamo sempre lì, a quel relativismo assoluto di cui parlavamo prima: io ho la mia verità; tu hai la tua; lui ha la sua; e sono tutte verità, tutte possono andare a braccetto appassionatamente, senza conflitti e senza drammi.
No, amici, così non va.
Lo ripetiamo: una torta di mele è una torta di mele, e un escremento di mucca è un’altra cosa.
Non c’è nulla di male nel preferire gli escrementi alle torte di mele, o nel trovare buoni entrambi: le mosche, per esempio, lo fanno. In omaggio alla democrazia, si posano con equanimità sulle torte e sulle cacche, succhiano tutto, son soddisfatte di tutto.
Appunto, le mosche.
Gli esseri umani, però, dovrebbero avere un po’ di onestà intellettuale. Dovrebbero dire, per esempio: «Sì, questa è musica commerciale; non è un gran che; però mi diverte, la ascolto volentieri; lasciate che me la goda».
E sapete perché questo tipo di onestà intellettuale dovrebbe essere doverosa?
Perché ci sono migliaia di artisti veri, di musicisti veri, che compongono musica di altissima qualità, ma non riescono e non riusciranno mai a farsi conoscere, a fare alla società il dono della loro bravura e della loro arte: poiché il mercato della musica leggera è drogato dalle star che si vendono, senza pudore, imbarbarendo il gusto e chiudendo ogni spazio ai giovani talenti.
Una faccenda che, specialmente in Italia, si ripete anche in altri campi: dalla poesia alla pittura, dalla filosofia alla politica, ovunque è lo stesso spettacolo. I furbetti, i venduti, che impediscono di emergere a coloro che hanno idee e qualcosa da dire.
Che hanno una spina dorsale.
E questa selezione alla rovescia, questa progressiva involuzione, questo progressivo imbarbarimento non è affatto opera del caso e non è neanche dovuto a un avverso, imperscrutabile destino.
Ha una causa molto precisa e molto semplice: la pigrizia morale e la disonestà intellettuale del pubblico che non ragiona, ma che sente con le viscere, e basta.
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Ylanite Koppens from Pexels
