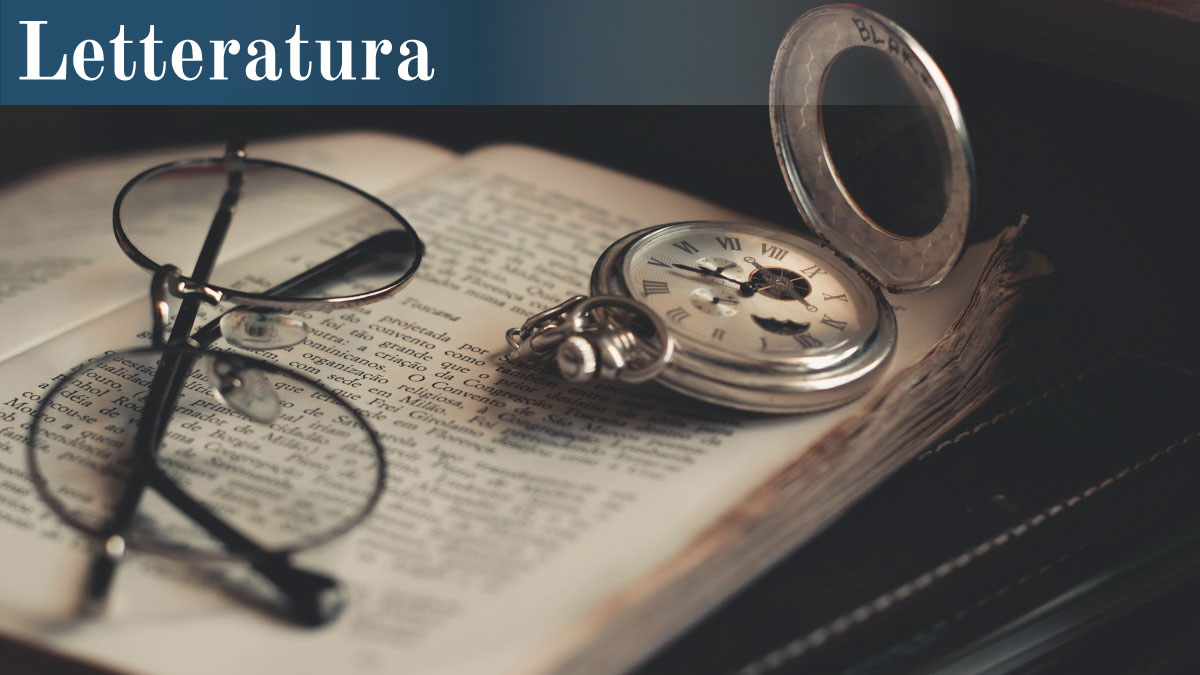Ricordo di Guido Boggiani, pittore-esploratore
26 Luglio 2006
Osceola (1800?-1838) e la lotta dei Seminole
29 Luglio 2006UNA PENNA PER L’ANARCHIA**
Lo scrittore Pa-Kin (anagramma di Bakunin e Kropotkin) è poco conosciuto in Occidente, come lo è, in genere, tutta la letteratura cinese (ma anche la storia e la filosofia di quel Paese).
Riportiamo dalla "Enciclopedia Garzanti di Letteratura", Milano, 2003 (2 voll.), vol. 2, p. 763:
"PA CHIN (BA Jin), pseud. di Li Yao-tang (Cheng-tu, Szechwan, 1904), scrittore cinese, noto anche come Li Fei han. Educato in una famglia di proprietari terrieri fedeli alla radizione confuciana, maturò precocemente idee anarchiche, abbandonò lo studio dei testi classici cinesi e intraprese, invece, quello delle lingue straniere. Nel 1927 sii trasferì a Parigi e si dedicò a studi di economia. In Francia scrisse il suo primo romanzo, Mieh-Wang" ("Distruzione"), pubblicato nel 1929 sulla rivista "Hsiao-shuo yüeh pao" (Mensile di narrativa) e approfondì la conoscenza del pensiero anarchico traducendo Kropotkin. Adottò in questa fase lo pseudonimo di Pa Chin, desunto rispettivamente dalla sillaba iniziale e da quella finale dei due pensatori anarchici Bakunin e Kropotkin. Nel 1929 rientrò in patria, dove pubblicò saggi, traduzioni, specie dal russo, novelle e trilogie di romanzi familiari, dove si notano influssi della narrativa occidentale (e soprattutto slava). Fra le trilogie si ricordano: "La trilogia dell’amore", pubblicata nel 1936, e comprendente i romanzi: "Nebbia (1932), "Pioggia", (1933), "Lampo" (1935), in cui si descrive il destino dei giovani cinesi durante la rivoluzione; la "Trilogia del torrente", in cui figurano i romanzi: "Famiglia" (1933), "Primavera" (1938) e "Autunno" (1940). "Famiglia", forse l’opera più nota di P. C., esamina la decadenza delle strutture familiari tradizionali, rette da norme patriarcali e gravate da pesanti formalismi. Ultima è la "Trilogia del Fuoco" (1940-45), sulla partecipazione che i giovani di Shanghai diedero alla resistenza contro l’invasione giapponese.
"Oggetto di critiche nel 1958 e di attacchi durante la rivoluzione cultrale, P. C. ha continuato a esprimersi felicemente divenendo uno degli autori più popolari nel suo paese (grazie anche alle sceneggiature cinematografiche e alle riduzioni teatrali tratte dalle sue opere) e uno dei più noti all’estero. Della sua abbondante opera sono stati pubblicati in italiano "Gelide notti" (1980) e "Il giardino del riposo" (trad. 1980)."
L’articolo che segue è stato pubblicato la prima volta sul giornale anarchico "Umanità Nova" (fondato da Errco Malatesta) il 18 giugno 1989, anno 69, pag. 6.
Un retaggio della cultura eurocentrica borghese nel movimento anarchico è la scarsa conoscenza, che poi è frutto di scarso interese e d’inconscio sentimento di superiorità, di quanto l’ideale anarchico ha prodotto all’altra estremità del mondo. Cina, Corea e Giappone, paesi di antichissima civiltà e di grandi tradizioni filosofiche e scientifiche, a partire dal XIX secolo hanno sviluppato dei movimenti anarchici che sono, per noi, di estremo interesse per la maniera in cui hanno tentato di sintetizzare gli apporti di Bakunin, Thoreau, Kropotkin, con le proprie specifiche realtà sociali ed economiche.
Colpito dalle durissime repressioni governative, in Estremo Oriente l’anarchismo non è riuscito a diventare movimento di massa; tuttavia, a partire dal 1880 ha esercitato un grande fascino su intere generazioni di intellettuali e di uomini politici, passati poi, per lo più, al comunismo marxista. Sappiamo che lo stesso Mao Ze Dong, per esempio, durante il suo primo soggiorno a Pechino, nel 1918 (a differenza di Pa Kin e molti altri giovani cinesi, egli non è mai stato in Europa, anzi, non è mai stato fuori della Cina), "si occupava molto di anarchia e discuteva con gli amici la possibilità di importarla in Cina" (cfr. A, Bozzo, La vita di Mao Tze Tung, ed Peruzzo, p. 41), com’ebbe poi a dichiarare egli stesso, senza imbarazzo, al giornalista E. Snow.
In Cina, in particolare, l’anarchismo non appariva puramente e semplicemente una ideologia d’importazione europea (che, in quanto tale, sarebbe stata comunque accolta con diffidenza), ma un filone di pensiero capace d’innestarsi su un antichissimo ceppo libertario, i cui antesignani possono riconoscersi nei grandi filosofi Lao Tze, Chuang Tzu e soprattutto Mo Ti. In essi sono già presenti i temi del pacifismo, della nonviolenza, la critica serrata alle istituzioni in nome della libertà e della coscienza individuale, che poi l’affermarsi del confuciansimo avrebbe finito per imbrigilare; così come nel sistema di coltivazione detto "del pozzo" si può rinvenire, fin dall’antichità, una pratica agraria inconfondibilmente solidaristica e comunista fra i contadini cinesi.
Dicevamo che gli stessi anarchici occidentali poco o nulla sanno – in genere – dei loro compagni dell’Asia orientale. Per la Cina possediamo la bella monografia di Robert A. Scalapino e George T. Yu, L’anarchismo in Cina, ed. Galzerano, 1982; per il Giappone c’è il classico Museihushugi. Breve storia del movimento anarchico giapponese, della collana V. Vallera, 1976. Sono due ottimi testi, chiari nell’esposizione, documentati, scritti con stile semplice e di facile compresione, che offrono a tutti i compagni (a un prezzo veramente modesto) l’opportunità di documentarsi sui prooblemi dell’anarchismo in quei Paesi. Il libro della Vallera è scritto da quel Marco Polo dell’anarchismo che è stato Victor Garcìa, autore – nel 1953-58 – di un viaggio intorno al mondo, per mettersi in contatto diretto con tutti i movimenti libertari del Pianeta, e il cui stile e la cui passione geografica lo accostano al grande Elisée Reclus.
Fra la generazione di intellettuali cinesi detta "del 4 maggio" e influenzata, direttamente o indirettamente, dalla cultura socialista rivoluzionaria europea – generazione cui appartengono Mao Ze Dong, Li Dha Zao, Lin Yutang – c’è un grande scrittore che scelse di mettere la sua penna al servizio indefesso della causa anarchica: Pa Kin.
Attraverso i suoi romanzi e, più ancora, attraverso la sua biografia, abbiamo uno spaccato eloquente della parabola compiuta dall’anarchismo in Cina attraverso gl’immensi sconvolgimenti sociali e politici di questo secolo. Sconvolgimenti che hanno portato un popolo di un miliardo di persone, aggiogato da secoli a una pesante schiavitù feudale (si pensi che la sola repressione della rivolta dei T’ai ping, nell’800, causò qualcosa come 30 milioni di morti), a sperimentare la Repubblica di Sun Yat Sen, la selvaggia reazione militarista di Chiang Kai Shek, e la doppia rivoluzione marxista del 1945-49 e del 1966-68.
Anzitutto, il nome Pa Kin è la più comune trascrizione occidentale dello pseudonimo di Li Feikan ed è formata dalla prima sillaba della pronuncia cinese di "Bakunin" e dall’ultima sillaba di "Kropotkin". Un nome che è come una bandiera, e al quale Li Feikan resterà fedele tutta la vita, attraverso difficoltà e persecuzioni continue.
Nasce nel 1904 a Chengdun, nella regione del Sichuan, da una famiglia di alti funzionari. Rimane presto orfano e cresce in un ambiente familiare oppressivo, che rende penosa e solitaria la sua infanzia. Ma l’esperienza del dolore è per lui fondamentale: attraverso di essa, Pa Kin perviene a una visione umanitaria e solidaristica dell’esistenza, premessa alla posteriore "scoperta" dell’anarchismo. Dopo studi irregoalri, s’imbarca per l’Europa.
Sono anni travagliati perla Cina: la delusione per la conferenza di Versailles ed i trattati di pace, che abbandonano la Cina alle brame imperialiste nipponiche, solleva ondate di rabbia e provoca scioperi fra gli studenti e i lavoratori. Partito con l’animo acceso da quesi fermenti rivoluzionari, Pa Kin approda nel 1927 a Parigi, per studiare economia. Ma ben presto abbandona definitivamente l’università. La sua antica famiglia è caduta in rovina e non può più mantenerlo. Egli vive poveramente in una casa del centro della capitale, e i rintocchi delle campane di Notre-Dame, come dirà in seguito, non fanno che sottolineare la sua tormentosa solitudine.
È allora che Pa Kin fa la grande, doppia scoperta della sua vita: la letteratura e l’anarchia. Spinto da quella solitudine e da quei rintocchi, carichi di ricordi della patria lontana, e sofferente, comincia a scrivere i suoi primi romanzi. Contempraneamente viene a contatto con i circoli anarchici francesi e ne è subito conquistato. S’immerge nella lettura di Bakunin, Kropotkin, Emma Goldman, è "abbagliato dalla bellezza dell’anarchismo" (sono parole sue).
L’impegno artistico e quello di militante di Pa Kin procedono a pari passo, con una mirabile unità e coerenza di vita. Il suo primo omanzo, Distruzione, apparso in Cina nel 1929, viene scritto nel Quartiere Latino, sotto la fortissima impressione della condanna di Sacco e Vanzetti. Intanto si prodiga anche nella redazione di articoli per la stampa del movimento libertario; conosce i capi storici del movimento; compie dei viaggi.
Il ritorno in Asia avviene nel segno di uno sforzo febbrile per aiutare il suo popolo, vittima della barbarica aggressione giapponese (alla presa di Nanchino, l’armata del Sol Levante si abbandona ad atrocità quali non s’erano più viste dai lontani tempi di Gengis Khan e Tamerlano). È ormai uno scrittore famoso, tra i maggiori della Cina contemporanea. Ha già pubblicato le trilogie Amore (1936), Corrente (1931-38), che comprende i romanzi Famiglia, Autunno, Primavera; e Fuoco, oltre a numerosi racconti . Nel 1944 nasce il romanzo il giardino del riposo (traduz. italiana di V. Costantini, Editori Riuniti, 1980) in cui si ritrovano un po’ tutti quei motivi autobiografici, sociali e umani caratteristici del suo credo. Ciononostante, è oggetto di violenti attacchi da parte di alcuni elementi imbevuti di un marxismo fanatico e intollerante.
Pa Kin ha aderito al Fronte unito degli intellettuali cinesi contro il Giappone, e tali attacchi rientrano in una strategia di criminalizzazione di tutte le componenti rivoluzionarie non marxiste. Lo stesso Lu Hsün, il decano degli scrittori cinesi del Novecento, forse il più grande di tutti, scende allora in campo a difesa di Pa Kin. Gli fa delle pubbliche scuse, lo invita a non raccogliere le provocazioni, gli rinnova stima e amicizia e insinua che i veri controrivoluzionari sono proprio quei "rivoluzionari" esaltati e faziosi che fanno il gioco dell’invasore giapponese., dividendo le forze della Resistenza.
Cacciati i Giapponesi nel 1945, sconfitto il "Kuomintang", nel 1949 nasce la Repubblica Popolare Cinese, mentre Chiang Kai-Shek fugge a Formosa (Taiwan) sotto la protezione americana, e gli U.S.A. si accingono a tentare l’intervento militare diretto mediante la guerra di Corea, che costerà alla Cina (e questo sono in molti, in Occidente, a non saperlo) un altro milione di morti, dopo i diversi milioni causati dall’invasione giapponese.
Nel clima della "guerra fredda" e, poi, della clamorosa rottura fra Mao e l’Unione Sovietica, Pa Kin cade in disgrazia presso il nuovo governo rosso. La sua attività di giornalista anarchico, di traduttore infaticabile di Kropotkin, Goldman, Bakunin, Berkman, Reclus; le sue campagne, nel 1936-37, a sostegno della Repubblica spagnola e degli anarchici di Barcellona, costituiscono altrettanti capi d’accusa. Di nuovi ne possono fornire i temi dei suoi romanzi, che l’interpretazione estremistica delle Guardie Rosse giudica intimistici, borghesi, rivolti al passato (tutte cose plausibili solo a una lettura estremamente superficiale, e che ricorda i toni della campagna denigratoria dei "censori" comunisti in Unione Sovietica, nei confronti della straordinaria opera letteraria di un altro grande solitario: Borìs Pasternak, l’autore del Dottor Živago).
"Anche se non mi hanno mai picchiato – dirà poi – ho subìto vere torture morali. Mi hanno obbligato a confessare quelli che chiamavano i miei crimini e rinnegare me stesso… per due anni e mezzo fui mandato in campagna a coltivare ortaggi. Per fortuna a quei tempi la mia salute era migliore di quella di oggi. Ma fu la mia compagna a rimanere vittima di queste persecuzioni e morì per non aver potuto avere le cure mediche necessarie, e tutto questo per mia colpa, perché avevo sulla schiena l’etichetta di controrivoluzionario." (intervista a Le Monde del 18 maggio 1979).
Allo stadio di Shanghai è vittima di un episodio penoso: circondato da una folla scalmanata di giovani studenti, che lo costringono a inginocchiarsi e gli frantumano gli occhiali sotto le suole delle scarpe, viene costretto a "confessare i suoi errori". Destino analogo, sia detto per inciso, tocca anche all’altro grande scrittore cinese contemporaneo, Lao She.
Forse gli capiterebbe ancora di peggio, se la morte di Mao , nel 1976, e gli eventi successivi non lo togliessero dai guai. Pa Kin è riabilitato, onorato, lasciato libero di viaggiare a scopo culturale. All’estero, in Occidente, si traducono e si leggono le sue opere; si fa il suo nome per il Nobel.
Passano i regimi autoritari, bianchi e rossi, in Asia non meno che in Europa. Ma l’ideale anarchico, pur in mezzo a terribili tempeste, grazie a uomini come Pa Kin continua coraggiosamente a sventolare, per la speranza delle generazioni di domani.
N. B. Altre notizie biografiche su Pa Kin si possono trovare, oltre che nella nota introduttiva a Il giardino del riposo ed. cit., e nella presentazione di Gelide notti, ed. Rizzoli, 1980, anche in un articolo di Victor Garcia intitolato Il suicidio letterario dell’anarchico cinese Pa Kin ( in Volontà, gennaio 1969, pp. 31-40).
Fonte dell'immagine in evidenza: Photo by Wallace Chuck from Pexels