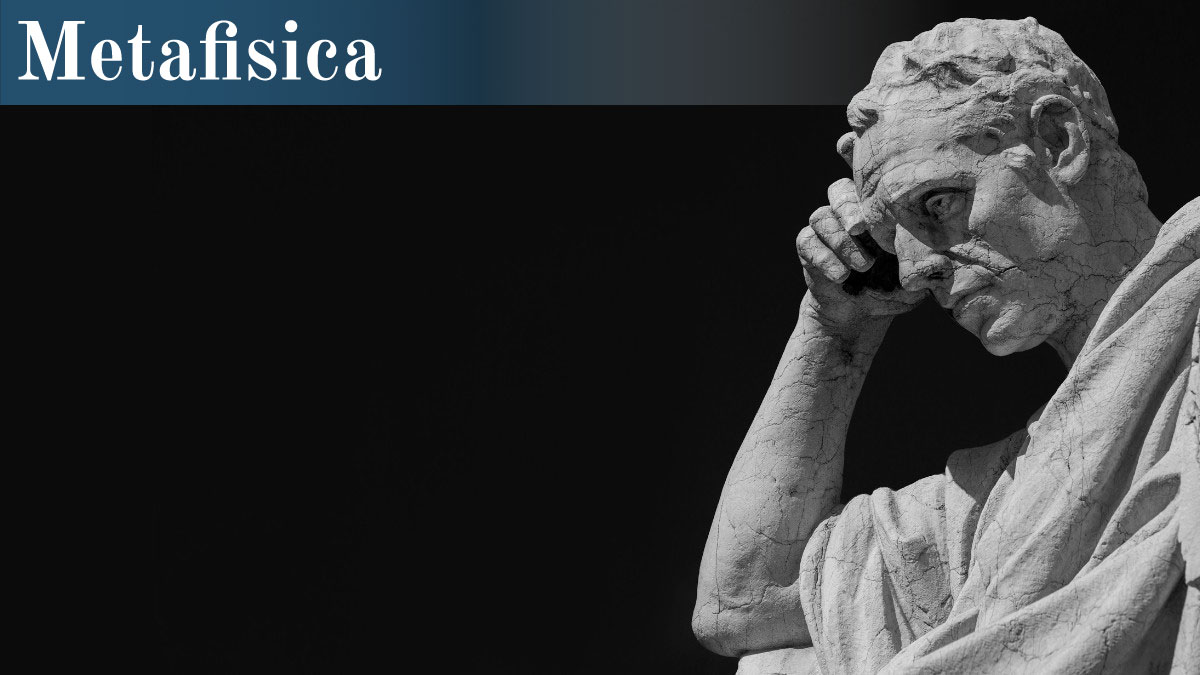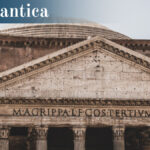
La fine della dinastia di Teodosio in Occidente (454-55)
1 Luglio 2006
Conversazioni filosofiche – Seconda parte: ordine e disordine
10 Luglio 2006(Questo articolo è stato pubblicato sui "Quaderni" dell’Associazione Filosofica Trevigiana, ora Associazione Eco-Filosofica: la prima parte sul n. 4 del 2003, anno XXIV, pp. 21-40; la seconda parte è uscita (in due puntate) sul quaderno n.5 dello stesso anno, pp. 29-38, col titolo "Ordine e disordine", e sul numero 7, pp. 6-17, col titolo "Tempo e irreversibilità"; la terza, col titolo "La matematica e la natura", sarà pubblicata in uno dei prossimi numeri).
SOMMARIO CONVERSAZIONI FILOSOFICHE :
Parte prima: Primo giorno: Caso e destino;
Secondo giorno: Necessità e libertà.
Parte seconda: Terzo giorno: Ordine e disordine;
Quarto giorno: Tempo e irreversibilità.
Parte Terza: Appendice: la matematica e la natura.
PRIMO GIORNO: CASO E DESTINO
Era bello, nell’aria fresca del mattino, passeggiare lungo i viali ombrosi del giardino, respirare il profumo dei fiori e delle piante aromatiche, ascoltare il chioccolìo dell’acqua presso le fontane tappezzate di muschio.
L’estate spargeva la sua dolce fragranza sulle cose, disseminava cirri leggeri nel cielo altissimo d’un blu cobalto, fasciava di luce dorata la tenue peluria dei frutti maturi sui rami. E ovunque si diffondeva il canto melodioso degli uccelli, fresco e argentino, come nel primo giorno della creazione del mondo.
– Caso, destino: che importa? – chiedeva Sandra, guardandomi da sotto le lunghe ciglie nere, con quel suo sguardo azzurro tra enigmatico e divertito, forse lievemente ironico.
– Già, che importa? -, risposi meditabondo.
Per un po’, restammo in silenzio. Non si udiva che il chioccolìo della fontana,sempre eguale eppure mai monotono. Da qualche parte, in lontananza, un gallo cantò tre volte, ma il suono quasi si perse nel tremolìo indistinto dell’aria.
SANDRA: -Vedo che non sei convinto – riprese poi, giocherellando fra i sassolini con la punta del sandalo. – Per te fa differenza, vero?
GIULIANO: – Ma sì, non posso negarlo. È questo il mio problema.
SANDRA: – E posto che si riuscisse a risolverlo, pensi che sarebbe diverso qualcosa?
GIULIANO: – Forse.
SANDRA: – Va bene, allora. Ricominciamo tutto daccapo. Alcuni sostengono che la vita è dominata al caso, altri che è guidata dal destino. Giusto?
GIULIANO: – Giusto. Ma prima, propongo di esaminare bene questi due termini.
SANDRA: – Ti darò una definizione di caso: ciò che avviene in modo imprevedibile, senza alcuna logica apparente.
GIULIANO: – Imprevedibile per chi?
SANDRA: – Per gli esseri umani, si capisce.
GIULISANO: – Sarò duro di comprendonio, però vorrei capire meglio. Vuoi farmi un esempio?
SANDRA: – Ecco: ora mi alzo da questa comoda panchina in stile liberty, e mi avvio verso il roseto. Prendo, cioè, a sinistra. Ma avrei potuto anche prendere a destra. La mia decisione di andare a sinistra era imprevedibile, perché casuale.
GIULIANO: – Imprevedibile per me?
SANDRA: – Anche per me.
GIULIANO: – Ne siamo sicuri?
SANDRA: – Spiegati meglio.
GIULIANO: – Secondo me, se hai deciso di prendere a sinistra, c’erano un milione di ragioni che ti spingevano ad agire così.
SANDRA: – Ma ero libera; potevo benissimo andare a destra. È stata la mia volontà…
GIULIANO: – Casuale anche quella?
SANDRA: – Forse no, devo ammetterlo. Ora capisco cosa vuoi dire.
GIULIANO: – Che il caso non esiste, né più né meno. Quello che a noi sembra imprevedibile, lo etichettiamo "caso", e non ci pensiamo più. Ma il fatto che noi non disponiamo di tutti gli strumenti per spiegare un fenomeno, non significa che esso sia casuale. Non più di quanto significhi che è soprannaturale.
SANDRA: – Infatti, avevo detto "senza logica apparente". Ma una logica, forse, c’è sempre. Cioè, una concatenazione causale, più o meno aggrovigliata. Però, mi viene alla mente un’obiezione. Quando getto in aria una moneta, quale logica causale decide in favore della "testa" o della"croce"?
GIULIANO: – Il calcolo probabilistico, suppongo.
SANDRA: – Che non dà certezze. Altrimenti, avremmo scoperto il metodo sicuro per sbancare le case da gioco.
GIULIANO: – E tuttavia, il fatto che non si possa predire un evento non significa che esso sia privo di necessità, che sia casuale. Certo vi sono delle ragioni se cade "testa" piuttosto che "croce": il movimento impresso alla moneta, suppongo. Ne convieni?
SANDRA: – Sì, mi hai convinta. È solo la nostra ignoranza a farci parlare di "caso". Caso è il nome che diamo a ciò che non sappiamo spiegare, né prevedere.
GIULIANO: – Bene. Abbiamo visto che il caso non esiste. Ora passiamo all’altro corno del dilemma: il destino. Vuoi suggerirmi una definizione?
SANDRA: – In senso stretto, una cieca forza che guida inesorabilmente le vicende umane.
GIULIANO: – Già, come in Omero: una forza perfino superiore al volere degli dèi.
SANDRA: – Ricordo, infatti, che alla morte di Sarpedonte lo stesso Zeus non riesce a trattenere il pianto. (1)
GIULIANO: – E in senso lato?
SANDRA: – La necessità.
GIULIANO: – Scusa, vuoi darmi una definizione anche di questa?
SANDRA: – Vediamo, devo pensrci un poco. Be’, ritengo che la necessità si possa definire come lo svolgimento logico delle leggi naturali.
GIULIANO: – Per cui, quando si dice che nessuno può sfuggire al proprio destino, s’intende semplicemente…
SANDRA: – Che nessuno può eludere le leggi della natura. Però, detto così, suona piuttosto banale, non trovi?
GIULIANO: – Diciamo spogliato di quell’aura tremenda e misteriosa di cui gli antichi, appunto, lo avevano avvolto.
SANDRA: – Via la poesia della Moira, dunque. Che cosa resta, caro il mio volterriano?
GIULIANO: – Lasciamo perdere Voltaire, che del resto non mi è troppo simpatico. Resta la ovvia constatazione che le cose accadono come accadono, perché non possono accadere altrimenti.
SANDRA: – E non è questo un misero senno del poi, solo paludato in vesti un po’ più sontuose?
GIULIANO: – A noi fa questo effetto, per il solito motivo: che non abbiamo la capacità di prevedere né, a volte, quella di spiegare.
SANDRA: – E ciò non equivale a dire che anche la visione del destino come necessità naturale non è altro che una forma di fede?
GIULIANO: – Vuoi dire una credenza come un’altra? Accordato. Ma ciò, a ben guardare, vale per ogni aspetto della conoscenza umana… Se potessimo conoscere in altro modo, ossia con un assoluto grado di certezza, vorrebbe dire che saremmo noi stessi gli autori della realtà. Solo Dio può avere conoscenze certe, avendo lui creato il mondo.
SANDRA: – E siccome tu non credi in Dio…
GIULIANO: – … il che, ovviamente, è una forma di credenza come un’altra…
SANDRA: – Questo significa che qualunque credenza vale come qualsiasi altra?
GIULIANO: – Bella domanda. D’istinto vorrei poter rispondere: no, naturalmente. Sai, mi danno particolarmente fastidio certe superstizioni religiose, quelle che il popolo vive come un forma evidente di alienazione. Vorrei, quindi, poterti dire che la credenza nell’ebollizione del sangue di san Gennaro non ha lo stesso valore della conoscenza delle leggi fisiche e chimiche, secondo le quali simili cose non possono mai accadere…
SANDRA: – …ma?…
GIULIANO: – Ma bisogna essere coerenti. Se ogni forma di conoscenza umana è parziale e provvisoria, bisogna avere l’onestà intellettuale di abbracciare il più coerente anarchismo gnoseologico. La pratica dello sciamano vale quanto gli studi di medicina nelle migliori universià occidentali, senza contare che…
SANDRA: – Senza contare che…?
GIULIANO: – Gli sciamani, spesso, guariscono i loro pazienti. La qual cosa non si può sempre dire dei nostri luminari della medicina occidentale. Per non parlare della psichiatria…
SANDRA: – E io che ti ho chiamato un volterriano…
GIULIANO: – Bene, propongo di tornare al nostro assunto iniziale. Abbiamo visto che "caso" e "destino", a dispetto della loro, diciamo coosì, nomèa, indicano tutt’altro che due realtà opposte e inconciliabili.
SANDRA: – Infatti, secondo te, le leggi naturali sono l’unico arbitro della nostra vita. Dico bene?
GIULIANO: – Sì. L’unico.
SANDRA: – Sbaglio, o c’è qualcosa in te che si ribella a siffatte conclusioni?
GIULIANO: – Hai la vista acuta, Sandra. Non che si ribella, comunque. Qualcosa che non resta pienamente appagata e soddisfatta: lo ammetto.
SANDRA: – Che cosa, esattamente?
GIULIANO: – Quella parte di me che vorrebbe credere da un lato nel libero arbitrio, cioè nel fatto che possiamo sottrarci a un meccanismo naturalistico assoluto; dall’altro in uno scopo, in una causa finale del fenomeno "vita".
SANDRA: – Però pensi che si tratti di residui irrazionali, vero?
GIULIANO: – Già. Più o meno.
SANDRA: – E se tu decidessi di dare pienamente voce e libertà a questa parte di te, che non vuole rassegnarsi?
GIULIANO: – Sarebbe come barare con le proprie debolezze. Non c’è nulla di male ad avere delle debolezze: è umano. Il male è eludere il problema, costruendo delle mitologie rassicuranti per esorcizzare le paure che da quelle debolezze nascono.
SANDRA: – Per esempio?
GIULIANO: – Tutti abbiamo paura del nulla. Allora c’inventiamo gli dèi, che vegliano amorevolmente su di noi e danno un ordine, un senso all’Universo. Rifletti che "kosmos", in greco antico, significa prima di tutto "ordine" e solo in ultima accezione "Universo"; mentre nelle lingue moderne "cosmo" è senz’altro sinonimo di "Universo". Questa esigenza di ordine, di razionalità, che per gli antichi era una componente della loro "Weltanschauung", per noi è diventata una certezza rassicurante e preconfezionata, un prodotto già bello e pronto per il consumo intellettuale…
SANDRA: – E… tornando al caso e al destino?
GIULIANO: – Noi vediamo che la realtà è disordine: disordine crescente. Aumento di entropia, per dirla col linguaggio della fisica. Allora sorge in noi il bisogno di ordine. Nulla di male, in questo. Qualunque sistema, per poter semplicemente esistere, richiede una diminuzione locale dell’entropia. Ma a noi non basta. Vogliamo certezze, certezze per tutta la vita e perfino oltre: vogliamo Paradisi ove saremo felici in eterno. Perciò, invece di condurre la nostra onesta battaglia locale contro l’aumento di entropia, sapendo che comunque perderemo la guerra, neghiamo addirittura che il disordine esista. Affermiamo che questo bisogno di ordine, che è in noi, testimonia l’esistenza di un ordine più alto, che è per così dire occultato nell’esperienza quotidiana, ma che bisogna saper vedere al di là della contingenza. Il caso ci appare come una manifstazione di disordine, dunque tendiamo a negarlo; e quanto al destino, ci sembra una forma di "ordine" un po’ troppo autoritaria , e allora neghiamo anche quello. Resta la libertà della coscienza, naturalmente: cioè, almeno così, di primo acchito, quella che pare una forma di ordine. Questo sì che ci soddisfa, e noi non vogliamo la verità, ma quelle pseudo-verità che blandiscono e accarezzano le nostre umane debolezze…
SANDRA: – Mi sembra di capire che sei irrimediabilmente in lotta con te stesso…
GIULIANO: – Spiegati meglio.
SANDRA: – Anche tu vorresti poter credere che la realtà è ordine; che la vita ha uno scopo; che la volontà e la razionalità sono in grado di guidarci attraverso il caos dell’esistenza. Ma vuoi negare a te stesso questa speranza, ti senti in dovere di respingerla come una forma di "debolezza".
GIULIANO: – No, ti ripeto: non mi vergogno di questa debolezza, ma mi vergognerei moltissimo se, per non avere il coraggio di riconoscerla come tale, m’inventassi realtà che non esistono…
SANDRA: – Poco fa, però, abbiamo convenuto che ogni forma di conoscenza è una semplice credenza. Come fa, allora, ad essere tanto sicuro che certe cose non esistono?
GIULIANO: – Toccato.
SANDRA : – Abbiamo sostenuto, infatti, che ogni credenza è relativa, che tutte hanno diritto di cittadinanza. La filosofia, poi, non fa altro che fornire un’appropriata impalcatura "logica" alle nostre credenze.
GIULIANO : – È vero. Consentimi però di abbracciare quelle credenze che a me paiono avere un maggior grado di probabilità… o, se preferisci, che mi appaiono meno improbabili.
SANDRA: – Va bene. Ma vuoi dirmi perché l’idea di un mondo ordinato ti appare tanto improbabile?
GIULIANO: – Semplicemente per ragioni empiriche. Questo è quello che a me sembra di vedere. Se altri vedono le cose diversamente, vorrà dire che usano occhiali con le lenti diversamente colorate…
SANDRA: – E, oltre che disordinata, suppongo che la realtà ti appaia anche assurda…
GIULIANO: – Sì, assurda.
SANDRA: – Cioè, priva di senso e priva di scopo.
GIULIANO: – Esatto. Naturalmente, sta a noi tentare di darglielo.
SANDRA: – Però…?
GIULIANO: – Però è estremamente difficile. Dare un senso all’assurdo, non è cosa tanto semplice. È ben vero che noi dobbiammo tentare: fa parte del nostro dovere.
SANDRA: – Perché parli di dovere? Dovere verso chi o verso cosa?
GIULIANO: – Verso noi stessi, e anche verso gli altri.
SANDRA: – Ma se tutto è assurdo, da dove hanno origine tali doveri?
GIULIANO: – Da una di quelle esigenze profonde che sono dentro di noi, perché fanno parte della nostra natura. Proprio come l’esigenza di libertà e l’esigenza di ordine.
SANDRA: – Che, però, avevi definito "debolezze"…
GIULIANO: – Quando non vengano riconosciute come nostri bisogni, ma poste come leggi della realtà
SANDRA: – E, così come l’esigenza dell’ordine non implica affatto l’esistenza dell’ordine, o quella della libertà l’esistenza della libertà, non potremmo pensare che l’esigenza del "dovere" sia un semplice abbaglio?
GIULIANO: – Certo, potremmo pensarlo. In realtà, io non sono in grado di motivarti razionalmente codesta esigenza etica. "Sento" che dobbiamo lottare contro l’assurdo e contro il disordine che caratterizzano la condizione umana, anzi, la condizione universale. Ma se mi chiedi perché dobbiamo farlo, posso dirti soltanto: per cercare di star bene con noi stessi, e per non aggiungere sofferenze agli altri. Di più non so, né pretendo di sapere.
SANDRA: – Capisco.
GIULIANO: – A che cosa stai pensando, così assorta?
SANDRA: – A quello che ti ho detto poco fa: che penso che tu sia continuamente in lotta con te stesso.
GIULIANO: – Può darsi. Ma la contraddizione, più che un fatto mio privato, credo sia parte di una condizione universale. Noi non chiediamo di venire al mondo, ma qualcuno lo decide per noi. Non vorremmo soffrire né far soffrire, invece provochiamo l’una cosa e l’altra. Molto di quel che riusciamo a realizzare, lo strappiamo letteralmente agli altri. Alla fine, dopo vane speranze e vani timori, veniamo precipitati nel nulla donde uscimmo: e anche questo non lo vorremmo, anzi, è la cosa che temiamo di più. Al punto da esserci inventati dèi e dèmoni, inferni e paradisi, per esorcizzare una paura così grande. Stando così le cose, ci arrabattiamo come meglio possiamo. E se cadiamo in contraddizione, credo sia un segno della nostra generosità: sarebbe più semplice lasciare che le cose vadano come devono andare, seguire la corrente dell’assurdo anziché opporvisi.
SANDRA:- Consentimi un’altra obiezione, e non sul piano morale ma su quello logico. Opporsi all’assurdità del reale presuppone un libero esercizio della volontà. Ma, poco fa, non lo avevi negato, in nome della inesorabile necessità delle leggi naturali? Non avevi detto che, se io ora mi alzo da questa panchina e mi avvio da una parte anziché dall’altra, la mia apparente decisione è stata in realtà il prodotto di milioni di ragioni, interne ed esterne…
GIULIANO: – Va bene, d’accordo. Ho detto proprio così.
SANDRA: – E allora?
GIULIANO: – Niente. È una contraddizione anche questa, e fa parte anch’essa della contraddittorietà della condizione umana. Usando il linguaggio comune, dico che noi dobbiamo cercar di estrarre un minimo di ordine dal caos, un minimo di senso dall’assurdo. Ma so bene che, se siamo in grado d’immaginare una tale operazione, è perché le leggi naturali – il patrimonio genetico, le esperienze infantili, l’ambiente sociale e tutto il resto – ci spingono a farlo. In definitiva, bisognerebbe domandarlo alla natura, perché "sentiamo" in maniera così contraddittoria: è uno dei regali ch’essa ci ha fatto, mettendoci al mondo.
SANDRA: – Ma in realtà, siamo tutti determinati in maniera necessaria?
GIULIANO: – Sì.
SANDRA: – O magari influenzati, ma non interamente determinati?
GIULIANO: – Anche qui, siamo nel campo delle semplici credenze.
SANDRA: – E la tua credenza, qual è?
GIULIANO: – Credo che ci resti un minimo di libertà: ma non sempre e non a tutti. Solo a pochi fortunati…
SANDRA: – Fortunati o coraggiosi?
GIULIANO: – Quei pochi che hanno la fortuna di essere dei coraggiosi.
SANDRA: – Va bene, non insisto. Ho capito che, per te, siamo zimbelli di una natura incomprensibile, come gli eroi di Omero sono zimbelli del Fato…
SANDRA: – Più o meno, penso si possa dire così. E tu, invece, che cosa credi?
SANDRA: – Riguardo alla libertà dell’uomo? Non lo so…
GIULIANO: – Dài, non cercare di schermirti. Bùttati.
SANDRA: – E sia. La mia credenza, e sottolineo credenza, è che forse qualcosa c’è.
GIULIANO: – Qualcosa… in che senso?
SANDRA: – Qualcosa.
GIULIANO: – Dài, non fare la misteriosa.
SANDRA: – Ordime, senso, scopo, dio: chiamalo come ti pare. Qualcosa capace di ricomporre il non-senso dell’esistenza, e che non è solo nella coscienza di pochi individui fortunati. Ma neppure io saprei dartene una spiegazione convincente. In realtà, non sono affatto sicura. È una sensazione, più che un ragionamento. E, naturalmente, una speranza,
GIULIANO: – Alle donne si addice la speranza. Lo dico seriamente, senza alcuna ironia.
SANDRA: – E perché?
GIULIANO: – Perché trasmettono la vita. Come potrebbero continuare a farlo, se fossero del tutto prive di speranza?
A questo punto cadde il silenzio. Entrambi eravamo immersi in profonde riflessioni.
Un usignolo scese dalle fronde e si posò sull’orlo della fontana, per bere.
Restammo un po’ a guardarlo, poi lo seguimmo quando volò via e andò a posarsi in cima a un sambuco.
– Andiamo – disse Sandra, alzandosi, alla fine. – Ripenseremo a quel che abbiamo detto, con la calma, e forse ne ricaveremo qualcosa.
Mi avviai al suo fianco.
Era quasi mezzogiorno. Il vialetto, ormai inondato di sole, risuonava tutto del frinire delle cicale.
SECONDO GIORNO: NECESSITA’ E LIBERTA’
GIULIANO: – Allora, Sandra, hai dormito bene?
SANDRA: – Sì, di notte incomincia a rinfrescare, non c’è più quel caldo afoso dei giorni scorsi. Ma non ho potuto fare a meno di rivolgere nella mente mille pensieri…
GIULIANO: A proposito di cosa?
SANDRA: – Delle cose di cui abbiamo parlato ieri. Molte, in verità; forse troppe. Su un punto, comunque, ho continuato a interrogarmi… ti va di parlarne?
GIULIANO: – Ma certo.
SANDRA: – È il problema della libertà. Per me, costituisce un punto fondamentale. Anche se sono d’accordo che noi non possiamo andare molto oltre la semplice credenza, mi pare questione troppo importante stabilire se noi siamo semplici strumenti delle leggi naturali, semplici burattini, insomma, di una regìa sconosciuta; o se abbiamo in pugno il nostro destino (uso la parola "destino" nel significato più generico e tradizionale), e sia pure solo in parte…
GIULIANO: – Non ti piace l’idea di essere un burattino?
SANDRA: – No, per niente. E credo non piaccia neppure a te.
GIULIANO: – Oh, quanto a questo, hai indovinato.
SANDRA: – Però ritieni che si debba essere onesti con sé stessi; non abbellire o attenuare la verità, ma guardarla dritto in faccia…, vero?
GIULIANO: – Infatti.
SANDRA: – Be’, se non ti dispiace, vorrei riesaminare daccapo questo punto.
GIULIANO: – Per me va bene. Anzi, guarda, se tu riuscissi non dico a convincermi, ma a instillarmi solo anche un ragionevole dubbio che noi siamo liberi di sentire, pensare, agire; che noi siamo liberi di essere: te ne sarei immensamente grato. Non chiedo altro che di poterci credere, ma non sulla base di semplici emozioni o speranze o desideri.
SANDRA: – Vediamo. Si potrebbe partire dal principio, per esempio. Tu affermi che unico principio regolatore della realtà è la forza meccanica della natura, i cui scopi (ammesso che ve ne siano), sono peraltro a noi totalmente incomprensibili. Giusto?
GIULIANO: – Sì, è così.
SANDRA: – E la natura, di che sostanza è fatta?
GIULIANO: – Di materiaed energia. Forse soltanto di energia. Non lo so esattamente, pare che neanche gli scienziati lo sappiano, per il momento.
SANDRA: – E questa energia, da dove ha avuto origine?
GIULIANO: – Vedo dove vuoi arrivare. Ma non sperare che ti risponda: "dal Big Bang". Tu mi domanderesti allora: e prima?; e io dovrei rispondere: da un altro Big Bang; e così via.
SANDRA: – e come vuoi rispondermi, allora?
GIULIANO: – Senti, secondo me nessuno ha posto questo problema con la chiarezza di Anassimandro, uno dei primi filosofi greci, duemilacinquecento anni fa. All’origine di tutte le cose vi è una sostanza unica, un principio (arché) infinito e indeterminato (ápeiron), da cui esse provengono e in cui si dissolvono. Dopo di lui, la filosofia occidentale non ha fatto alcun passo avanti in tale direzione. Se l’ápeiron è infinito, è perfettamente inutile chiedersi da dove ha avuto origine e che cosa c’era prima di esso. Capisci?
SANDRA: – E questa spiegazione ti soddisfa?
GIULIANO: – Onestamente no, ma non ne conosco una migliore.
SANDRA: – È come rinunciare a porre la domada.
GIULIANO: – Ne convengo. Ma vi sono domande che presuppongono possibili risposte, altre che sono del tutto al di fuori della nostra portata. Bisogna avere l’umiltà di riconoscere la nostra piccolezza.
SANDRA: – Non sarebbe più umile, tuttavia, lasciare aperta la porta alla possibilità di un principio che trascenda, e non solo cronologicamente, la materia?
GIULIANO: – Questione di punti di vista.
SANDRA: – A te sembrerebbe una fuga nell’irrazionale, vero?
GIULIANO: – Peggio: nella metafisica. Dove è possibile tutto e il contrario di tutto.
SANDRA: – Va bene; lasciamo perdere la questione dell’origine del tutto. Proviamo ad affrontare il problema della libertà da un altro lato. Tu sostieni che ogni azione della volontà è illusoria, perché determinata anch’essa dalle leggi naturali. Se così fosse, noi non avremmo alcun merito del bene, né alcuna responsabilità per il male che facciamo.
GIULIANO: – Non credo che l’aspetto etico del problema ci aiuterà più di quello gnoseologico. Comunque, tentiamo. E cominciamo al fatto che "bene" e "male" sono termini relativi, sempre in relazione a colui che li pone e, quindi, privi di universalità e necessità.
SANDRA: – Non c’è una legge etica assoluta?
GIULIANO: – Non c’è.
SANDRA: – Bene, di questo parleremo un’altra volta. Suppongo sia di per sé un argomento fin troppo impegnativo.
GIULIANO: – Resta l’altro aspetto della questione: se siamo responsabili delle nostre azioni. Io penso di no.
SANDRA: – Mi meravigli. Non parlavi, proprio ieri, di doveri che abbiamo verso noi stessi e verso gli altri?
GOIULIANO: – Sì, certo.
SANDRA: -E questi doveri da dove provengono, se non esistono né il bene, né il male; se non esiste una libera scelta da parte nostra?
GIULIANO: – Dalla nostra coscienza. Ma essa non è il regno della libertà, non più di quanto lo sia la natura fuori di noi.
SANDRA: – Spiegati meglio.
GIULIANO: – Alcuni di noi "sentono", in determinate circostanze, di dover agire in un determinato modo; anche, lo ammetto, contro la loro convenienza e la loro comodità. Non dico contro il loro interesse, perché il nostro interesse, inteso come principio-guida della conservazione, è alla base di tutte le leggi naturali…
SANDRA: – Sicché, non esistono azioni disinteressate?
GIULIANO: – No, non esistono.
SANDRA: – E… l’amore?
GIULIANO: – L’amore è la meno disinteressata di tutte.
SANDRA: – Anche l’amore verso l’umanità del profeta, del martire, del missionario, del santo?
GIULIANO: – L’amore è sempre, in primo luogo, amore di sé stessi, dunque il travestimento preferito di quel principio di autoconservazione che è la molla di ogni azione; e non solo umana, ma di qualsiasi essere vivente.
SANDRA: – Be’, ammetterai che c’è di che restar pensierosi. Devo rifletterci. Anche su questo argomento, credo mi piacerebbe ritornare con più calma, una volta o l’altra. Ma ritorniamo al punto…
GIULIANO: – Il punto è, dicevo, che alcuni di noi sentono, a volte, di dover agire in un certo modo: e questo è tutto. Non significa che siamo veramente liberi di agire, non significa che potremmo agire in un altro modo. Quando scegliamo, crediamo che sia così: ma è solo un’illusione. Non si sceglie niente, in realtà.
SANDRA: – Questo è peggio di un’ironia: è un incubo. Se fosse come tu dici… Niente, mi vengono i brividi solo a pensarci.
GIULIANO: – Vuoi provare tu ad offrirmi qualcosa di meglio? Per me, non chiederei altro che di essere convinto del contrario. Ho esaminato e riesaminato questo punto mille volte dentro di me, credimi.
SANDRA: – D’accordo, voglio provare a individuare un altro possibile punto di vista. Non sarà facile, ma voglio provarci. Intanto, però, passeggiamo lungo i vialetti: penso meglio quando sono in movimento, anziché stando seduta. Bello questo giardino, vero?
GIULIANO: – Paradisiaco. A proposito, in greco "paràdeisos" significa appunto giardin, e viene dall’antico persiano "pairi-daeza", "luogo recintato".
SANDRA: – Ecco perché il libro della Genesi parla del Paradiso Terrestre come di un giardino…
GIULIANO: – Già. Infatti, quel libro venne composto nella regione di Babilonia,durante l’esilio del popolo ebreo: e la Persia è ai confini della Mesopotamia.
SANDRA: – Ti ringrazio di queste dotte spiegazioni. In effetti, all’ombra di queste piante si sta bene come in un autentico paradiso. E immagino che per i popoli del Medio Oriente, da sempre alle prese con la scarsità d’acqua e con la progressiva desertificazione (2), "paradiso" fosse sinonimo di luogo ricco di acque correnti, quindi ricco di piante e animali…
GIULIANO: – E quando un italiano o un tedesco o un americano piantano un verde giardino attorno alla propria abitazione, senza saperlo inseguono quel mito antichissimo, quella nostalgia di paradiso che è entro di noi.
SANDRA: – Già. Ma i Greci e i Romani, secondo me, se ne intendevano molto più dell’uomo moderno; non attorno alla casa, ma al centro della casa costruivano il loro giardino-paradiso, con le stanze più interne affacciate tutt’intorno…
GIULIANO: – Come i monaci dei conventi medioevali, coi loro chiostri.
SANDRA: – Passando attraverso il giardino dell’architettura araba tardo-antica… Bene, questa digressione è stata piacevole. Ricordo, da studentessa, la descrizione del giardino di Alcinoo, nell’isola dei Feaci: una delle pagine più suggestive, per me, dell’intera Odissea. (3) Ma torniamo a noi. Comincerò dicendoti che io non condivido il tuo pessimismo né il tuo fatalismo, condivido però il rifiuto di qualsiasi ideologia consolatoria. Quindi, sono a favore di un’idea della libertà della coscienza, non perché non sopporto l’idea che siamo dei miseri burattini di un fato ineluttabile, ma perché "sento" che il nostro senso etico deve aver origine da qualcosa di positivo. Certo, non posso dimostrartelo in un modo che vada oltre la mera "credenza", tuttavia cercherò di spiegarti meglio questa mia persuasione. Ricordi quel periodo in cui stavo male, due anni fa? Mi pareva di essere in fondo a un pozzo nero e profondissimo…
GIULIANO: – Sì, ma perché rievocare un passato tanto spiacevole?
SANDRA: – Perché in quei giorni orribili ho avuto la consolazione di trovarmi accanto un amico leale e discreto, che mi ha aiutata per puro altruismo.
GIULIANO: – E chi sarebbe questo buon Samaritano?
SANDRA: – Tu, naturalmente.
GIULIANO: – Eh, via!
SANDRA: – No, dico sul serio. Ebbene: se riuscirò a dimostarti che l’azione disinteressata esiste; che non tutto soggiace alla legge inseorabile dell’autoconservazione: alla fine, forse, avremo aperto una breccia nel muro della necessità naturale. Così, forse potremo concludere che la libertà morale esiste, dopotutto; che non è soltanto inganno e illusione.
GIULIANO: – Spiacente di deluderti, ma l’azione totalmente dsinteressata, cioè totalmente sciolta dal principio di autoconservazione, non esiste. Tutti abiamo un tornaconto, magari inconscio; nessuno è "puro".
SANDRA: – E il tuo qual era, in tal caso?
GIULIANO: – Non scendiamo troppo nel personale. Propongo di mantenere la conversazione entro binari più generali.
SANDRA: – Sembrerebbe quasi una fuga: non è da te. Allora, qual era il tuo tornaconto?
GIULIANO: – Che ne so? Dovrei psicanalizzarmi. Ma c’era, stanne sicura.
SANDRA: – E va bene. C’era. Ma chi può dire che ci sia sempre e comunque? Chi può farne una legge? Come fai a sostenere che il dottor Schweitzer non ha meriti, né Hitler ha colpe?
GIULIANO: – Non dico che costruire lebbrosari o gasare milioni di pesone sia indifferente. Dico che noi non siamo liberi nel nostro agire, che siamo condizionati e imprigionati da milioni di fattori.
SANDRA: – Condizionati al cento per cento?
GIULIANO: – Al cento per cento. Siamo quello che siamo, perché non potremmo essere altrimenti.
SANDRA: – Questo non rischia di essere un mero "senno del poi"? Poiché le cose sono andate in un certo modo, si afferma che non avrebbero potuto andare diversamente…
GIULIANO: – Ascolta. Se metto una bilia sul vertice di un cono, da che parte cadrà?
SANDRA: – Non lo so. Ma dopo che è caduta da un lato, dirai che non poteva fare diversamente…
GIULIANO: – Ed è così, infatti. La direzione del vento, per esempio…
SANDRA: – Ma in una stanza chiusa?
GIULIANO: – Il modo, necessariamente imperfetto, in cui l’abbiamo posta sulla punta del cono…
SANDRA: – E sia. Ma le azioni umane, le scelte etiche, sono proprio la stessa cosa?
GIULIANO: – E perché no?
SANDRA: – Perché noi non siamo palline di vetro!
GIULIANO: – Oh bella. E che cosa siamo? Atomi, cioè palline; siamo milioni di palline in equilibrio più o meno statico…
SANDRA: – Vada per i nostri corpi. Ma l’anima?
GIULIANO: – Che cos’è l’anima?
SANDRA: – L’anima, la psiche, la coscienza, il soffio vitale: chiamala come ti pare.
GIULIANO: – Palline un po’ più sottili, in equilibrio un po’ più dinamico…
SANDRA: – Lascia stare il tuo Lucrezio, il tuo Epicuro e il tuo Democrito. Del resto, anche Lucrezio nel De rerum natura ha dovuto introdurre il concetto di "clinamen"(4), per spiegare come queste bendette palline un bel momento, deviano dalla verticale: altrimenti cadrebbero eternamente nel vuoto, senza toccarsi, e nulla si formerebbe al mondo di quel che esiste, nulla potrebbe nascere.
GIULIANO: – Sandra, ti ho detto come la vedo io, in questa faccenda; perciò non burlarti dime. Ma ora dimmi come la vedi tu. Considerami già confutato, se vuoi; ma proponimi qualche cosa di meglio delle palline che si muovono in base a precise leggi fisiche…
SANDRA: – Lo farò, se mi consenti di ricorrerea un mito.
GIULIANO: – Come mai?
SANDRA: – Per i razionalisti come te, la mitologia è solo una forma pre-scierntifica, quindi "inferiore", di conoscenza della realtà. Secondo me, invece – e non solo i cosddetti popoli primitivi la pensano così, ma anche i sapienti orientali e lo stesso Platone – il mito è una forma simbolica di conoscenza, capace di spingersi nelle regioni aspre e difficili , dove il ragionamento strettamente logico non trova alimento sufficiente per sopravvivere. Una forma simbolica e ipotetica di conoscenza, dico, diversa ma niente affatto inferiore a quella scientifica. E teniamo ben presente, sia detto per inciso, che anche la scienza procede per ipotesi…
GIULIANO: – …. Che poi va a verificare mediante l’esperimento.
SANDRA: – Questo accadeva al tempo della scienza galileiana. Oggi, quale Einstein potrebbe "verificare" la teoria del Big Bang? O dell’espansione dell’Universo? Quando i calcoli della fisica si basano su entità non misurabili, anzi nemmeno certe, come, ad esempio, i neutrini (5) o i tachioni (6)…
GIULIANO: – Va bene, mi hai convinto. Anche le ipotesi scientifiche raramente sono dimostrabili, al giorno d’oggi.
SANDRA: – Del resto, non sostenevi ieri il più completo anarchismo epistemologico? Ogni forma di conoscenza ha gli stessi titoli di legittimità di qualsiasi altra…
GIULIANO: – Sì, è vero. Ammetto la contraddizione e non cerco scuse. Allora, sentiamo questo raconto mitologico, intendendo "mito" come forma sapienziale.
SANDRA: -Hai presente quel frammento di Archiloco in cui il poeta dice d’essere stato costretto ad abbandonare lo scudo in guera, per salvarsi la vita? (7)
GIULIANO: – Sì, lo ricordo bene. Il poeta dice d’aver perduto qualcosa di molto bello e caro, e vive con tutta la sua intensa umanità quella perdita…
SANDRA: – Il che non gli impedisce di concludere con quel verso: "Che m’importa di quello scudo? Di nuovo me ne procurerò uno migliore", che ha fatto dannare generazioni di filologi…
GIULIANO: – Perché così in contrasto con l’etica greca: pare quasi che egli si vanti di un’azione che costituiva il massmo disonore per un guerriero: fuggire, abbandonare il proprio scudo. Dice infatti: "Abbandonai lo scudo…, e così mi salvai", con aria impudicamente soddisfatta.
SANDRA: – D’altra parte, Archiloco (oltre a essere un poeta straordinariamente simpatico e "moderno") era un mercenario di professione. E non è lecito chiedere a un mercenario di morire per amor di patria, come Leonida e i suoi trecento alle Termopili, visto che combatte per il soldo e non per la patria….
GIULIANO: – Pienamente d’accordo con te.
SANDRA: – E del resto, lasciamo agli eruditi di azzuffarsi per decidere se vi sia o non vi sia, nei suoi versi, ostentazione e magari compiacimento nel deridere l’etica dominante. Ora non voglio parlarti dell’Archiloco storico, il poeta di Paro, figlio di Telesicle e di Enipo, vissuto nella seconda metà del VII secolo e cioè la bellezza di duemilaseicento anni fa; ma di un Archiloco che ho scelto a protagonista del mito che ora ti voglio raccontare.
GIULIANO: – Sono tutt’orecchi e curiosissimo di ascoltarti.
SANDRA: – Dunque, un giorno Archiloco era impegnato in un’azione di guerra. Non stava combattendo in battaglia: doveva, più modestamente, spiare i movimenti del nemico e riferire poi al suo comandante. Per questo si era acquattato dietro un folto di cespugli e, naturalmente, si era tolto l’elmo dall’alto cimiero. Lo scudo, grande e bello, di fine ed esperta fattura, lo teneva invece al braccio sinistro. Era un oggetto non solo perfetto, ma utile, anzi indispensabile nei pericoli del corpo a corpo: più volte gli aveva salvato la vita ed egli vi era sinceramente affezionato, quasi come a un amico. Per questo non aveva voluto separarsene, affidandolo a qualche commilitone, prima di uscire in esplorazione: temeva potesse andar perduto. E così lo aveva portato con sé, benché non gli servisse affatto, nelle presenti circostanze; anzi, benché gli fosse decisamente d’impaccio. Dimmi, riesci a immaginartelo?
GIULIANO: – Sì, mi par di vederlo con chiarezza. Se ne sta rimpiattato a spiare, come fece il troiano Dolone, secondo Omero (8); e osserva nella notte i fuochi dell’accampamento nemico.
SANDRA: – Benissimo. Ma ecco che qualcosa va storto, chi lo sa il perché? Forse i cavalli hanno fiutato la sua presenza. Fatto sta che in pochi attimi tutto il campo è in allarme; voci risuonano nell’oscurità, e il nostro eroe viene rapidamente scoperto. Parecchi guerrieri si lanciano verso il suo nascondiglio, cercando di tagliargli ogni via di fuga. E allora lui deve decidere in fretta: fuggire, senza perdere neppure un istante; ogni attimo di ritardo può costargli la vita. Ma che fare dello scudo? Oltre che inutile, è d’inciampo, perché grande e pesante: lo rallenterebbe nella corsa; peggio ancora, riflettendo i raggi della luna sulle piastre metalliche, denuncia la sua posizione e guida all’inseguimento i guerrieri nemici. Che fare? Senza po tempo in mezzo, Archiloco sfila il braccio dalla cinghia di cuoio e lascia cadere il bello scudo fra i rami, nel buio; poi fugge, così alleggerito, più veloce d’un daino. Si sente il cuore in gola, che batte furiosamente; il sudore scende a ruscelli giù per le membra; mentre i piedi volano sulle rocce con la prestezza delle ali.
GIULIANO: – Benissimo. Chi ha detto che un eroe non può conoscere la paura? Basti pensare a Ettore, a come fugge per ben tre giri intorno alle mura di Troia, davanti al terribile Achille (9)…
SANDRA: – E poi, non si sa se Archiloco fosse proprio un eroe. Ho detto poc’anzi "il nostro eroe" in senso generico. Era un mercenario e combatteva per la paga; ma la sua vera passione, secondo me, erano il vino e le belle donne. Dunque, egli fugge a tutta velocità , abbandonando lo scudo. Si vede che sua madre, da ragazzo, non lo aveva mai ammonito: "o con questo, o su questo". Fatto sta che riesce a seminare i suoi inseguitori, lasciandoli con un bel palmo di naso. E si salva la vita!
GIULIANO: – Meglio un uomo vivo che un eroe morto, cantava Luigi Tenco in una sua bella canzone (10)…
SANDRA: – Non dice proprio così. Dice: "Ma lei che lo amava/ aspettava il ritorno d’un soldato vivo/ di un eroe morto/ che ne farà?", perché gli hanno dato una medaglia alla memoria. Ma torniamo ad Archiloco. Il quale, molti anni dopo, cade in battaglia: quella volta sì, scudo o non scudo. Ironia della sorte, lui ch’è un mercenario muore proprio in difesa della sua patria, combattendo contro gli abitanti di Nasso. Un certo Caronda lo colpisce a morte, spingendolo ai tristi regni dell’Ade, oltre il fiume Acheronte.
GIULIANO: – E poi, che accade?
SANDRA: – Si trova davanti al tribunale di Zeus, naturalmente. È Ares che lo ha trascinato in giudizio, quando già lui pensava d’essersi meritato senz’altro un beato soggiorno nei Campi Elisi, là dove sono accolti (come dirà poi Virgilio nell’Eneide), i guerrieri caduti gloriosamnente. (11) E invece niente, Ares non gli ha mai perdonato quell’oscura faccenda dello scudo abbandonato, e adesso propone per lui la pena dei tristi: essere precipitato nel più profondo del Tartaro.
GIULIANO: – Direi che c’è una bella differenza fra le due destinazioni… E come va a finire?
SANDRA: – Ermes, sempre pronto a difendere ladri, gaglioffi e truffatori (probabilmente perché li sente affini al suo temperamento) si assume la difesa d’ufficio. Ma la sua perorazione è fiacca e deludente, mentre la requisitoria di Ares è stata tagliente, implacabile, e ha colpito profondamente l’intera giuria. A questo punto il nostro poeta, sentendosi già quasi spacciato, chiede a Zeus di poter pronunciare lui stesso la propria difesa. Gli dèi e le dee (soprattutto Afrodite, che parteggia per lui perché in vita fu un suo appassionato seguace) lo osservano con tanto d’occhi e lo ascoltano senza fiatare. Dunque, Archiloco si leva in piedi e, disdegnando i molli artifici della retorica, se ne viene dritto dritto al cuore del discorso, com’è nel suo carattere schietto e impetuoso. E parlando, dice più o meno così:
"Onorevoli giurati, avete udito le roventi accuse mossemi da Ares, accuse volte a dimostrare la mia lucida e imperdonabile vigliaccheria, per essermi un giorno salvata la vita, abbandonando il mio grande scudo rotondo. Egli ha sostenuto che lo scudo è il simbolo stesso dell’onore e del valore guerriero e che quindi io, anteponendo la salvezza della mia miserabile vita all’onore, ho senz’altro meritato le pene inestinguibili del Tartaro. Ora, io non voglio né posso contestare la legittimità e la perfetta coerenza di un simile impianto accusatorio. Ma desidero farvi riflettere su una questione che sta a monte. Posto che abbandonare lo scudo sia stato un atto disonorevole e vile, io chiamo te, o sommo Zeus, in giudizio al posto mio."
A queste parole gli dèi hanno un moto di sorpresa e, alcuni, d’indignazione. Zeus impallidisce, perfino; ma sua figlia Atena, forse perché protettrice della guerra ordinata e intelligente (di contro alle nauseanti carneficine predilette da Ares) pare sorridere con una certa benevolenza. Senza dar modo ad alcuno di interromperlo, audacementeArchiloco prosegue con tono sempre più incalzante:
"Fosti tu, infatti, o Zeus, ad assegnare a ogni uomo, al momento della nascita, il bagaglio di doni con cui affrontare la vita. Nel mio, forse, non avevi provveduto a porre abbastanza coraggio: è dunque giusto chiedere conto a un mortale di ciò che non gli fu dato in dote dagli dèi?"
GIULIANO: – Mi piace questa storia, Sandra. Però, fino a questo momento, sembrerebbe portare acqua al mulino del mio ragionamento: noi siamo quel che la natura (e le esperienze) hanno fatto di noi.
SANDRA: – D’accordo, ma aspetta un po’: non è ancora finita. Col suo discorso, dunque, Archiloco ha ridotto al silenzio ogni possibile obiezione; gli dèi, imbarazzati, ammutoliscono. Zeus, certo, potrebbe prenderlo e scaraventarlo nel Tartaro, senza tanti complimenti. Ma può, il gran padre celeste, macchiarsi così palesemente d’ingiustizia, lui che è il simbolo stesso della giustizia suprema? A questo punto, inaspettatamente, il nostro poeta riprendea parlare. Ed è un discorso coraggioso, da uomo a uomo; anzi, da uomo a dio, ma privo di qualunque sudditanza psicologica nei confronti degli olimpi.
"E tuttavia, o sommo Zeus, e voi, dee e dèi tutti, ascoltatemi: non sarò così vile da trincerarmi dietro l’argomento della mia stessa debolezza, acquattandomici come un coniglio selvatico nella sua tana. Se in vita ebbi un momento di debolezza e abbandonai vilmente il mio scudo, ora che sono al cospetto dell’eternità voglio essere coraggioso, anche se non sfrontato. E mi porrò lealmente la domanda: potevo, in quei drammatici momenti che precedettero la mia fuga ignominiosa, agire diversamente da come ho agito? Ero comunque libero di scegliere, di prendere una decisione oppure un’altra? Mi restava, nonostante tutto, un briciolo di volontà per oppormi all’impulso di fuggire e di gettare alle ortiche lo scudo e, con esso, il mio onore? Nella mia vita, del resto, non fui un vile: la mia morte ne è testimonianza. Ebbi un solo momento di debolezza, e non volli seppellirlo nelle profondità del cuore, ma osai guardarlo ben bene e raccontarlo, nei miei versi, al mondo intero. Chi mai l’avrebbe saputo tra i mortali, se io stesso non mi fossi accusato apertamente? Ebbene, questo vi dico, o numi celesti: forse sì; forse mi rimaneva una possibilità di libera scelta. Sminuirei la mia umanità se lo negassi; se, per salvarmi dalle pene eterne, cercassi rifugio nella costituzionale incapacità degli uomini di prendere in pugno il proprio destino. Anche Ettore ebbe paura, e fuggì, dimentico dell’onore e della reputazione; ma poi si riprese, si fermò e rimase saldo ad aspettare il duello fatale col Pelìde. No, non siamo pupazzi nelle mani del Fato: alle sue leggi cieche e incomprensibili, possiamo opporre la nostra consapevolezza e la nostra dignità. Cadremo, ma cadremo con la fronte alta. Non si troveranno ferite sulle nostre schiene. (12) In questo, o Zeus, mi riconosco dunque uomo: che ebbi un momento di smarrimento, e fuggii: ma so che avrei potuto forse oppormi alla paura, come feci altre volte: come sto facendo anche adesso, fieramente accusandomi di ciò che poteva restare occultato agli altri, riconoscendo la verità dei miei sentimenti e dei miei pensieri."
Questo disse Archiloco agli immortali – concluse Sandra -, con uno dei suoi enigmatici sorrisi. – e pensi che qualcuno, a cominciare dal Cronìde, abbia avuto il coraggio di condannarlo?
NOTE
1) Iliade, XVI, 458-461.
2) Cfr. F. O. Vallino- F. Guazzo Albergoni, Dalla foresta al deserto, Milano, 1978.
3) Odissea, VII, 112-132.
4) Il termine lucreziano "clinamen" traduce il greco "parénclisis" e designa la lieve ondulazione, volontaria e autonoma, degli atomi nella propria caduta:De rerum natura, II, 186 sgg.; cfr. Epicuro, Lettera a Erodoto, § 61. Nella concezione di Democrito, invece, lo scontro fra gli atomi (e la successiva formazione dei corpi) ha origine dal vortice ("dínos"), causa prima della nascita del mondo.
5) Componenti della "massa invisibile"dell’Universo (come i buchi neri e le stelle di neutroni). Se si accettano i calcoli che attribuiscono al neutrino una massa di 20 elletronvolt, ne conseguirebbe che il 90 per cento della massa dell’intero Universo sarebbe costituita dagli invisibili e inafferrabili neutrini. Cfr. P. Bianucci, Stella per stella, Firenze, 1997, pp. 275.
6) Ipotetiche particelle più veloci della luce, comparse nella letteratura scientifica intorno al 1970., ma non universalmenteaccettate. Teoricamente, se esistono e se possono interagire con la materia, sarebbero una possibile "porta" sugli universi paralleli. Cfr. R. Giovannoli, La scienza della fantascienza, Milano, 1991, pp. 194-201.
7) Archiloco, fr. 6 Diehl. Sull’intera questione dello scudo, cfr. G. Monaco, Charites, Firenze, 1960, pp. 13-17. È stato peraltro osservato (A. Scarcella, Letteratura e società nella Grecia antica, Roma, 1987, vol. 1, p. 57) che solo in epoca posteriore il soldato che avesse gettato lo scudo, il "rhipsaspis", veniva colpito da infamia. Anche Odisseo, infatti, pur mentendo, dice di aver fatto la stessa cosa: Odissea, XIV, 276 sgg.
8) Iliade, , X, 299 sgg.
9) Iliade, XXII, 135 sgg.
10) La canzone, interpretata da Tenco, è di Monti-De André.
11)Eneide, VI, 660: "Hic manus ob patriam pugnando vulnera passi".
12) Cfr. Sallustio, De coniuratione Catilinae, LXI, 2: "Nam fere quem quisque vivos pugnando locum ceperat, eum amissa anima corpore tegebat. Pauci autem, quos medios cohors praetoria disiecerat, paulo divorsisus, sed omnes tamen advorsis volneribus conciderant."
Fonte dell'immagine in evidenza: sconosciuta, contattare gli amministratori per chiedere l'attribuzione