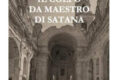fonte sabinopaciolla.com 10/03/2024
Di seguito segnalo all’attenzione e alla riflessione dei lettori di questo blog l’articolo scritto da Padre Eric Banecker e pubblicato su What we need to now. Visitate il sito e valutate liberamente le varie opzioni offerte e le eventuali richieste. Ecco l’articolo nella traduzione di Occhi Aperti! (pseudonimo).
La chiesa dove servo come Pastore è una delle più belle chiese del Nord America. Naturalmente, tutti pensano che la loro chiesa sia bella, – anche nel caso di quelle che assomigliano al Millennium Falcon di Star Wars. Ma questa, dedicata a San Francesco di Sales, nella zona ovest di Philadelphia, è un edificio oggettivamente straordinario. Tra i suoi dettagli più ragguardevoli, un insieme di vetrate firmate D’Ascenzo, nella navata, che raffigurano la vita di Cristo e la vita del Patrono della parrocchia, San Francesco di Sales. In una scena della sua vita, c’è un’immagine di una processione eucaristica in atto, davvero mozzafiato, con un gruppo di persone che guardano dall’altra parte del fiume. Questa potente scena raffigura il tempo in cui San Francesco di Sales visse da giovane sacerdote nella regione di Chablis, un periodo straordinario della sua vita, che ancora oggi offre insegnamenti a tutti i credenti.
La regione di Chablis, situata appena a sud di Ginevra, era una zona complessa della diocesi di Annecy, di cui Francesco di Sales era sacerdote e in seguito vescovo. Nel corso di pochi decenni, la gente di Chablis passò dall’essere culla per i cattolici a subire persecuzioni una volta che l’area venne occupata dai protestanti bernesi. Poi, attraverso una serie di eventi che caratterizzavano l’Europa di quei tempi, un Duca cattolico della Savoia reclamò la zona e diede di nuovo piena libertà al culto cattolico. Tutto ciò che restava da fare ora, naturalmente, era convincere i 60.000 abitanti a diventare di nuovo cattolici. Questo sarebbe dovuto avvenire con il sostegno morale (ma non amministrativo) del Duca, la cui influenza sul territorio era debole. Ma il vero potere nella regione lo esercitarono i calvinisti, che erano certi di poter applicare forti pressioni per ostacolare gli sforzi di San Francesco di Sales, il cui sostegno proveniva dalla vicina Ginevra. In questo maelstrom politico e religioso, il vescovo di Ginevra, in età matura ma audace, decise di inviare il 27enne appena ordinato, Francesco di Sales.
Una volta arrivato, Francesco comprese velocemente che pochissime persone si sarebbero presentate per i suoi sermoni – anche se avessero avuto simpatie per il cattolicesimo – perché non volevano incorrere nell’ira dei calvinisti. In una lettera al suo ordinario, il vescovo Grenier (di cui, entro breve, diverrà il successore), Francesco di Sales scrisse: “La verità è che il nostro compito qui non è solo quello di vincere le eresie, ma soprattutto quello di sbarazzarci degli interessi mondani”. Frustrato ma impavido, Francesco tentò una diversa strategia. Gli venne l’idea di stampare trattati, opuscoli contenenti punti chiave della dottrina, tratti dai suoi sermoni in difesa della fede cattolica. Queste istruzioni stampate iniziarono a diffondersi – all’inizio segretamente – fino a quando alcune persone, tra cui alcuni dei capi locali, finirono coll’essere convinti dal suo modo di scrivere elegante ma semplice. (San Francesco di Sales per tutta la sua vita scrisse come fosse stato quell’avvocato che suo padre tanto desiderava divenisse.)
Dopo circa tre anni di missione nella regione di Chablis, il sacerdote trentenne decise che era giunto il tempo di una manifestazione pubblica di fede. La devozione delle Quarant’Ore era recentemente diventata popolare a Roma, grazie soprattutto all’opera di San Filippo Neri. Questa devozione richiedeva diversi giorni di solenne esposizione del Santissimo Sacramento, con culto pubblico e pubbliche celebrazioni. Tali atti pubblici di pietà eucaristica, naturalmente, avvenivano con un certo grado di pericolo in una terra in gran parte calvinista. Eppure le Quarant’Ore proseguirono, complete di due grandi processioni in cui, ci viene detto, migliaia di persone si riunirono. Un anno dopo, Francesco organizzò due devozioni delle Quarant’Ore, con Sante Messe solenni e processioni e con la presenza del Duca, nuovamente fiducioso riguardo alla sua sicurezza, non a causa della sua valida amministrazione, ma per l’incredibile successo pastorale del giovane sacerdote. Si stima che, alla fine del suo apostolato di quattro anni, due terzi dei 60.000 abitanti della regione di Chablis fossero tornati alla fede cattolica.
Questa straordinaria storia ha avuto un profondo impatto su di me, e i suoi insegnamenti, mutatis mutandis, sono ampiamente fruibili anche ai nostri giorni. In primo luogo, il saggio vescovo attempato non ebbe alcuna paura a mandare qualcuno con zelo e abilità in una difficile situazione pastorale, nonostante la giovane età. Avrebbe potuto facilmente decidere – come molti spesso fanno oggi – di tenerlo vicino o assegnarlo ad un incarico già consolidato e “stabile”. Francesco era senza dubbio un giovane dotato, con doni unici ben chiari al suo vescovo. Ma i suoi carismi vennero a galla proprio perché fu messo a capo di una missione impegnativa. Quanti potenziali Francesco abbiamo lasciato languire in incarichi pastorali troppo semplici? Coloro che assegnano incarichi pastorali non dovrebbero avere paura di essere audaci – e di esigere l’eccellenza invece della mediocrità.
In secondo luogo, Francesco si avvalse della tecnologia del suo tempo per raggiungere il suo gregge. La gente, alla fine, decise di venire ai suoi sermoni – anzi, gremivano le chiese – ma solo dopo aver ricevuto, con originalità, i suoi messaggi direttamente nelle loro case. Internet, nonostante le sue molte ovvie insidie, non ci ha fornito una medesima opportunità oggi? Eppure temo stia andando sprecata. L’“internet cattolico” sembra in gran parte dominato da quelle voci squillanti che si susseguono nell’attirare le persone verso un’ideologia piuttosto che alla fede degli Apostoli. Nel frattempo, molti sacerdoti che sono stati incoraggiati a fare discepolato sono invece impegnati a guardare Tik Tok (o peggio). Naturalmente, non tutti necessitano di fare un apostolato digitale in stile vescovo Barron o padre Schmitz. E l’evangelizzazione digitale deve sempre servire l’obiettivo di una comunione personale, non il contrario. Eppure, se riesco a registrare un breve discorso e ad inviarlo a tutti i miei parrocchiani con pochi clic, perché non dovrei farlo? L’opera di evangelizzazione è già abbastanza difficile: dovremmo cogliere le opportunità che abbiamo di fronte.
Infine, ci sono le processioni. Atti pubblici di pietà che attirano l’attenzione della gente. Esse hanno un grande valore pastorale, non solo nell’ambito della “Cristianità”, ma ancora di più quando camminare per le strade potrebbe significare ricevere occhiatacce, derisione e persino violenza. Pensate al potente finale del film The Mission: lascia lo spettatore ammaliato, perché in quell’unica scena viene presentata tutta la Chiesa così come è destinata ad essere. C’è la fede in Cristo Redentore, c’è una comunità unita al suo eroico Pastore tramite il vincolo della carità, c’è il Signore Eucaristico che cammina tra il suo popolo e sì, c’è il perpetuo atto cristiano di testimonianza. Con meno drammaticità, San Francesco di Sales ha dato una medesima pubblica dimostrazione di fede eucaristica. Ed è questa che ha costretto lo spettatore a chiedersi: questa è un’assoluta buffonata oppure questi sanno qualcosa che io non so?
Per più di cinquant’anni, i cattolici negli Stati Uniti sono stati persuasi che più si agisce mescolandosi con la società secolare, meglio è. Invece questo si è dimostrato un totale disastro. Per qualche ragione, abbiamo deciso di fare la pace con lo Zeitgeist nel momento esatto in cui la principale linea guida americana consisteva nel trasformarsi in una macchina di distruzione culturale, di devastazione economica, di depravazione e di sofismi intellettuali. L’unica risposta adeguata a tutto questo deve essere una profonda conversione interiore che si manifesta nelle nostre liturgie, nelle scuole, nei servizi sociali e nelle congregazioni religiose.
Mentre alcuni potrebbero sentirsene irritati e gridare ad una nuova “ghettizzazione”, questa non sarebbe necessariamente la realtà. Una persona può essere sia cattolica molto devota che rispettosa dei nostri fratelli e sorelle separati in Cristo. Si può avere una certa preferenza liturgica senza denigrare altre forme di liturgia approvate dalla Chiesa. E nella vita pubblica, non c’è contraddizione tra agire in conformità con la Dottrina Sociale cattolica (nella sua interezza, e non conformandoci solo a ciò che più ci aggrada) e avere conversazioni rispettose con coloro verso cui non ci troviamo d’accordo. In molte parti dell’Africa, i musulmani scelgono di mandare i loro figli nelle scuole cattoliche, – non perché sono d’accordo sul punto della fede, nient’affatto, ma perché le scuole forniscono un’istruzione eccellente e sicura. E qualche faccia tosta può mai accusare i cattolici africana di diluire la fede? Si comprende, allora, che una robusta, autentica fede unitamente alla pratica religiosa ci rendono più capaci di impegnarci con gli altri, non di meno.
Penso a queste cose quando guardo quella vetrata colorata, con i suoi osservatori che guardano dall’altra parte del fiume, alcuni con tali sguardi sui loro volti come se volessero unirsi alla processione, nonostante tutto. Quelle vetrate si affacciano su un mondo, quello del West Philadelphia, così diverso dalla regione di Chablis. Qui la lotta non è tra cattolici e calvinisti, ma riguarda alcune domande ancora più fondamentali: esiste la verità oggettiva? Che cos’è una persona umana? La realtà è qualcosa che posso manipolare a mio piacimento o è un dono ricevuto? In effetti, molti dei nostri vicini hanno abbandonato la pratica religiosa oppure non l’hanno mai avuta. Ma questa “liberazione” dalle catene della vecchia fede è arrivata a un prezzo indicibile: disgregazione sociale, solitudine e cinismo. Di fronte a una tale realtà, le processioni pubbliche e le devozioni non rientrano nel punteggio di obiettivi teologici ma ricordano alla gente una domanda necessaria: e se fosse tutto vero?
Sono piuttosto convinto, come scrisse una volta Joseph Ratzinger, che per quanto il credente sia di fronte ad una apostasia di massa e all’abbandono della pratica religiosa, anche il non credente è ugualmente interessato da questa domanda. Perché, se è davvero tutto vero, allora la vita del miscredente ha un significato intrinseco, allora la sua sofferenza non è inutile, allora è amato più di quanto possa immaginare di un amore perfetto, allora la sua vita non finisce con la morte e la gioia eterna della visione beatifica è qualcosa che può essere scelto. Questo messaggio, soffocato dalla nostra cultura secolare, deve essere proclamato da tutti i cattolici di tutto il mondo.
Ciò di cui abbiamo bisogno ora sono vescovi audaci a tal punto da inviare uomini buoni in tutte quelle missioni che molti considererebbero avventate. Abbiamo bisogno di laici, di persone consacrate e del clero per usare i mezzi a nostra disposizione per proporre la verità del Vangelo in questa nuova era. Abbiamo bisogno della testimonianza pubblica della fede in tutta la sua bellezza – musica, chiese, processioni e feste – che sappia riunire la meravigliosa diversità del popolo di Dio. E, sì, abbiamo bisogno di autentica santità, il tipo di santità incarnato dallo stesso “santo nobiluomo”, san Francesco di Sales, che così ci incoraggia: “Tutti noi possiamo raggiungere la virtù e la santità cristiana, non importa in quale condizione di vita viviamo e quale sia il nostro lavoro nella vita”. Seguendo il suo esempio, possiamo cercare sempre il volto del Signore e aiutare le anime a vivere con Gesù per sempre nei loro cuori.
Padre Eric Banecker
Padre Eric Banecker è un sacerdote dell’arcidiocesi di Filadelfia